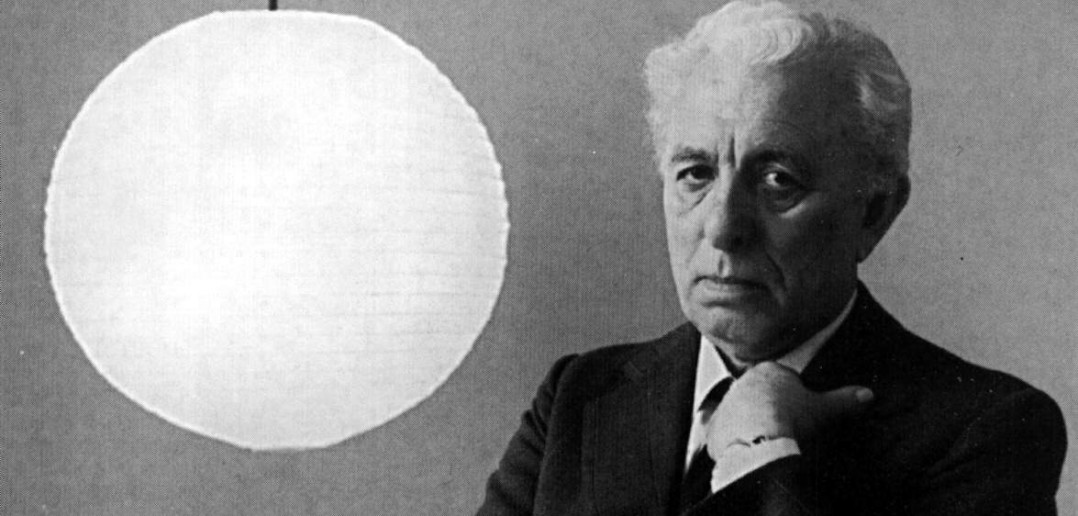Speciale Franco Fortini
di Luca Lenzini
dal numero di febbraio 2015
Quando abbiamo cominciato a pensare all’anniversario della scomparsa di Fortini, siamo partiti da una domanda molto semplice e radicale: Fortini chi? Così infatti, al modo epocale, rispondevano i librai alle richieste di chi cercava i suoi libri. Ma non solo i librai: anche avvoltoi accademici e opinion makers di dubbia fama ripetevano la domanda o tacevano del tutto (intanto fioccavano convegni e concistori, ogni weekend un centenario o un cinquantenario, e a nessuno si nega una Festschrift). Per tanti, troppi motivi di quella domanda non c’era in verità da stupirsi. Sono cambiati assai i tempi, da quando strutturalisti in crisi, barbudos in eskimo o smunti filologi bussavano alla porta di via Legnano o della facoltà di lettere di Siena per chiedere lumi sul mondo, per sapere “che fare”, per portare a casa una Weltanschauung o ricaricarsi d’indignazione, almeno per qualche ora. E lui, che non si negava a nessuno, ogni volta a negare ricette, a decostruire le parole d’ordine. Un libro da leggere? La Bibbia; e che andassero a studiare.
 Ma oggi, bisognava pur rispondere e allora cominciavano i problemi. Almeno per me, che in molti anni di studi su Fortini poeta e intellettuale mi sono sempre rifiutato alla sintesi. Rifiutato perché intimorito dalla complessità e molteplicità dell’opera, atterrito dai nessi con gigantesche questioni storiche e sociali; ma anche perché consapevole di non disporre di altro strumento, per tentare di capire qualcosa del suo sterminato lavoro, di quello parziale, partigiano e imperfetto, imparato molto approssimativamente proprio da lui e da alcuni altri: ovvero il saggio – quindi solo assaggi, domande parziali, interrogazioni empiriche, commenti a singoli testi, interpretazioni provvisorie. Nessuna sintesi (Fortini chi?…).
Ma oggi, bisognava pur rispondere e allora cominciavano i problemi. Almeno per me, che in molti anni di studi su Fortini poeta e intellettuale mi sono sempre rifiutato alla sintesi. Rifiutato perché intimorito dalla complessità e molteplicità dell’opera, atterrito dai nessi con gigantesche questioni storiche e sociali; ma anche perché consapevole di non disporre di altro strumento, per tentare di capire qualcosa del suo sterminato lavoro, di quello parziale, partigiano e imperfetto, imparato molto approssimativamente proprio da lui e da alcuni altri: ovvero il saggio – quindi solo assaggi, domande parziali, interrogazioni empiriche, commenti a singoli testi, interpretazioni provvisorie. Nessuna sintesi (Fortini chi?…).
E nemmeno stavolta. Del resto, da dove cominciare? Dal 1917, l’anno dell’ottobre, da una pensione in Oltrarno, di fronte alla torre di San Niccolò, dove l’Arno si allarga prima di scivolare sulla pescaia? O dall’Ossola, dalla valle senza ritorno di Foglio di via? Oppure ancora dalle stanze del “Politecnico”, con Vittorini “ardente e alato” e le forbici di Albe Steiner che “costringevano a scegliere”? O invece dalla piccola porta di Brecht, lassù in Scandinavia? E perché no da quel serpe, in un quadro di Poussin? Ognuna di queste ipotesi aveva un suo fondamento, indicava un possibile percorso. Ma era meglio, forse, cominciare dalla fine: dal 7 novembre 1994, quando Fortini scrisse il suo ultimo testo pubblico, Lettera all’Assemblea “Per la libertà d’informazione”, lettera che a sua volta termina con queste parole:
“Cari amici, non sempre chiari compagni; cari avversari, non sempre invisibili agenti e spie; non chiari ma visibilmente nemici; vi saluta un intellettuale, un letterato, dunque un niente. Dimenticatelo se potete”. (Sono le parole che chiudono il “Meridiano” Saggi ed epigrammi del 2003; l’“Oscar” di Tutte le poesie, 2014, si chiude invece con un testo intitolato L’Internazionale). Si poteva cominciare da qui, da questa domanda: perché “un niente”? Cos’era questa negazione di sé, un atto di modestia o di orgoglio? Il gesto di chi sa di aver saputo dire qualcosa, ma in prossimità della fine preferisce tirar dritto, e ci pensino gli altri a giudicare, a scegliere, a canonizzare, chi se ne frega, avanti un altro? A veder bene, però, il riferimento alla “nientificazione” poteva anche essere un preciso richiamo all’annullamento e svuotamento di un ruolo, un ruolo quale era stato il suo, di intellettuale critico ma anche di poeta, di uno comunque che rifiutava di tener separate etica e politica, etica e poesia; che si era sempre battuto contro ogni “doppia verità”.
Le due versioni, credo io, non sono necessariamente alternative; ed entrambe ci costringono a fare i conti non solo e non tanto con il passato, ma con il presente. Ancora il 1994, e un altro flashback: l’ultima volta che incontrai Fortini e si parlava di elezioni, disse a un certo punto: che importa chi vince le elezioni, hanno già vinto, loro hanno vinto nella società. Non c’era nessuna indignazione, nessun senso di scandalo nell’osservazione. Va sempre così (questo il sottinteso), una parte della società fa il suo gioco contro un’altra parte, ci sono interessi contrapposti e “loro”, quell’altra parte, hanno quasi sempre a disposizione i migliori strumenti per vincere; non parliamo poi se “noi” non sappiamo più nemmeno di cosa parliamo quando parliamo di “società”, se anzi non sappiamo cos’è il noi, dove si forma e a che fine, e chi sono loro, che sanno fare i propri interessi. Volpi del Tavoliere, kennediani col broncio e scout di Pontassieve, loro è di potere che si occupano; ma noi? Intere generazioni bruciate ai margini del lavoro più precario e senza domani, tenute sotto ricatto, la disuguaglianza crescente e i privilegi insultanti sotto gli occhi di tutti. Ma zitti, non è vero? Potremmo perdere quel posticino garantito. E oggi che la continuità lampante tra prima e dopo (1994 e 2014) sigilla un incarognimento ancora più duro, una cecità e un’ignoranza ancora più tremende e profonde, dovremmo ripensare a quanto scriveva Fortini agli inizi dei novanta, in un passaggio che delimita un crinale decisivo. Ancora un flashback, dunque: In mano ai rinnegati (“il manifesto”, 6 maggio 1990):
 “Quel che avviene sotto i nostri occhi è la vendetta perpetrata contro se stessi da coloro che vent’anni fa ebbero tra i venti e i venticinque anni. Questi quarantenni, o anche più avanzati in età, quando non abbiano conosciuta la galera o la droga o l’espulsione dalla fabbrica o l’umiliazione di rinnegare il periodo più generoso della propria giovinezza, hanno dovuto attraversare un’età che è cominciata con le stragi, il terrorismo e la P2 e si conclude con una situazione di regime, un sindacato trasformato in istituzione produttiva e un partito comunista che si vergogna del proprio nome. (…) Gli anni settanta hanno spezzato la schiena al nostro paese. Esso ha ora gli uomini politici e i ‘media’ che si merita. Non potrò vedere cacciata e punita la classe politica che – al potere o all’opposizione – ci ha governati nel ventennio 1968-1988 ma non ho dubbi su come sarà giudicata. (…) Guardiamo in televisione precipitare e ricrearsi un mondo, a meno di due ore di aereo da qui. Ma gli autori dei titoli della nostra stampa, equivalenti a quelli che svolgevano la medesima bisogna mezzo secolo fa sui quotidiani del regime, possono continuare tranquillamente il loro lavoro: nessuno li caccerà. Anche in questo il terrorismo ha svolto pienamente la sua opera criminale e cretina”.
“Quel che avviene sotto i nostri occhi è la vendetta perpetrata contro se stessi da coloro che vent’anni fa ebbero tra i venti e i venticinque anni. Questi quarantenni, o anche più avanzati in età, quando non abbiano conosciuta la galera o la droga o l’espulsione dalla fabbrica o l’umiliazione di rinnegare il periodo più generoso della propria giovinezza, hanno dovuto attraversare un’età che è cominciata con le stragi, il terrorismo e la P2 e si conclude con una situazione di regime, un sindacato trasformato in istituzione produttiva e un partito comunista che si vergogna del proprio nome. (…) Gli anni settanta hanno spezzato la schiena al nostro paese. Esso ha ora gli uomini politici e i ‘media’ che si merita. Non potrò vedere cacciata e punita la classe politica che – al potere o all’opposizione – ci ha governati nel ventennio 1968-1988 ma non ho dubbi su come sarà giudicata. (…) Guardiamo in televisione precipitare e ricrearsi un mondo, a meno di due ore di aereo da qui. Ma gli autori dei titoli della nostra stampa, equivalenti a quelli che svolgevano la medesima bisogna mezzo secolo fa sui quotidiani del regime, possono continuare tranquillamente il loro lavoro: nessuno li caccerà. Anche in questo il terrorismo ha svolto pienamente la sua opera criminale e cretina”.
“Nessuno li caccerà”, no certo. Anzi a certuni si dedicherà magari un bel tomo rilegato o si concederà un posto in parlamento. Non è andata così? Ma tornando alla Lettera all’Assemblea del 1994, lì c’è un passaggio che ci riguarda, in senso stretto, dove si parla di una “oscura voglia, e disperata, di dimissione e servitù”. La Boétie? Sì certo, anche; e poco più in là, un accenno a “quei lavoratori che dai loro capi vengono illusi di battersi attraverso le strade con antichi striscioni e poi, nel buio della Tv, ridono alle battute dei pagliaccetti di Berlusconi”. Non è andata così? E ora che a dire il vero non avremmo più voglia di ridere e nessuno crede più ai vecchi striscioni, tuttavia l’oscura voglia e disperata di dimissione e servitù ha trasformato il paese intero, l’Europa; e non abbiamo nemmeno più dove chiedere una spiegazione, una Weltanschauung, nemmeno un consiglio per come indignarsi per un paio d’ore. Solo talk show e l’eterno cabaret dell’entertainment sinistroide per arrivare a notte.
Non è proprio vero, però, che Fortini si rifiutasse di dare consigli. Certamente non spiegazioni del mondo, ma compiti, pensieri da non dimenticare sì. Per esempio in Più velenoso di quanto pensiate (1971) si possono trovare utili indicazioni. Sono due i compiti, scriveva allora, che ci stanno davanti. Il primo “è quello di far passare i nostri vicini e noi stessi dalla passività quotidiana (attraversata da sussulti di piacere e di angoscia, come i feti nelle loro acque), alla capacità di mutamento come costituzione di un progetto di se stessi; di passare dal senso di un tempo non qualificato, che si contorce nell’attimo, a quello di un tempo sostenuto dalla solidarietà e quindi volto a rendere, come diceva Merleau-Ponty, ‘meno fatale il disordine e meno insensata la morte’. (…) L’altro impone di combattere l’ipnosi indotta dall’azione come droga, la ‘distrazione’ che viene dal falso ottimismo; ci comanda di dispiegare e di aver sempre presente la irriducibilità, la insaziabilità dei desideri e dei timori, le radici corporee della individualità, la passione per il valore del presente, la necessità di chiamare per nome i vizi e le virtù e praticarli nella loro contraddizione”.
Personalmente, non avrei da cambiare una virgola in questo discorso, oggi dicembre 2014. Ed è così che abbiamo cominciato a pensare, con Valentina Faleri, Lorenzo Pallini, e Cecilia Mangini, e poi con tanti altri, che Memorie per dopo domani, titolo di un libretto fortiniano del 1984, era l’insegna giusta per l’anniversario: domande, frammenti, appunti da usare per un futuro diverso. Nessun convegno, niente Festschrift o commemorazioni.
In molti si sono dati da fare, per farci dimenticare quel niente di nome Fortini. Per sotterrarlo a furia di stereotipi, per rimuoverlo dal palinsesto, per sfogare il rancore verso se stessi, per farci credere a un futuro sempre eguale al presente, per non dover cercare di capire, per non dover lottare.
Ma eccoci qua, non ce l’hanno fatta.
luca.lenzini@unisi.it
L Lenzini dirige la Biblioteca umanistica dell’Università di Siena ed è membro del Centro studi Fortini