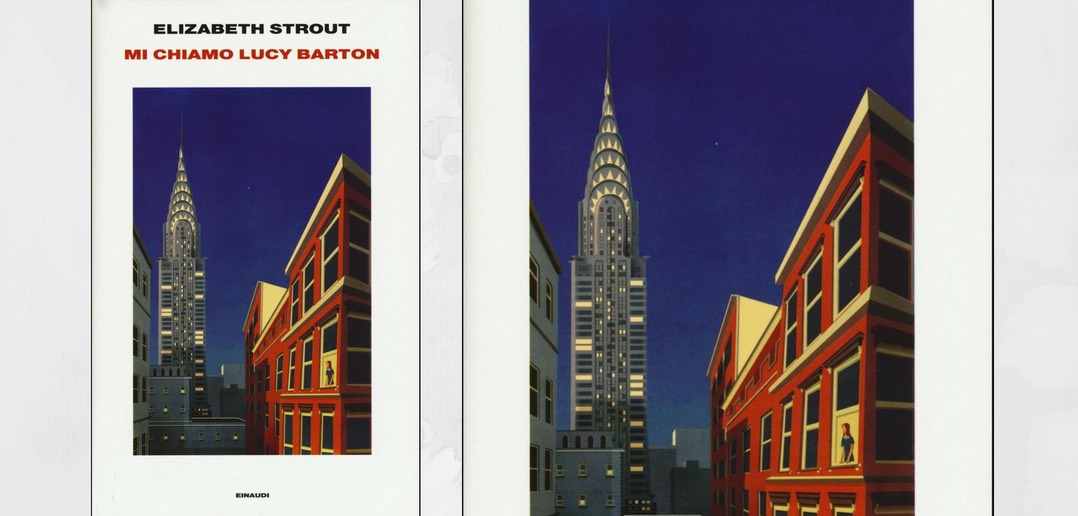L’arte di raccontare storie
recensione di Gabriella Dal Lago
dal numero di settembre 2016
Elizabeth Strout
MI CHIAMO LUCY BARTON
ed orig. 2016, trad. dall’inglese di Susanna Basso
pp. 168, € 17.50
Einaudi, Torino 2016
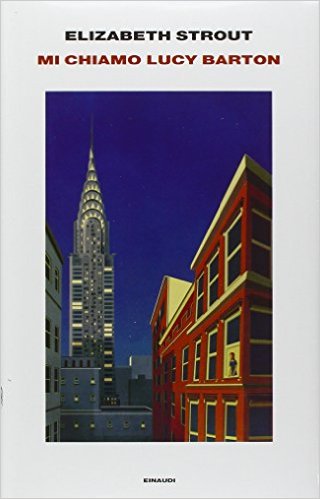 Dopo una semplice operazione all’appendice, Lucy, madre di due bambine, viene trattenuta in ospedale per nove settimane a seguito di alcune complicazioni, un batterio misterioso a cui nessuno riuscirà a dare nome. Cinque giorni di quel lungo periodo di degenza Lucy li passa con sua madre, che dall’Illinois arriva nella stanza di ospedale di New York da cui si vede il grattacielo della Chrysler. Elizabeth Strout fa iniziare il suo ultimo libro da qui: dall’incontro tra una madre e una figlia.
Dopo una semplice operazione all’appendice, Lucy, madre di due bambine, viene trattenuta in ospedale per nove settimane a seguito di alcune complicazioni, un batterio misterioso a cui nessuno riuscirà a dare nome. Cinque giorni di quel lungo periodo di degenza Lucy li passa con sua madre, che dall’Illinois arriva nella stanza di ospedale di New York da cui si vede il grattacielo della Chrysler. Elizabeth Strout fa iniziare il suo ultimo libro da qui: dall’incontro tra una madre e una figlia.
Mi chiamo Lucy Barton è, prima di tutto, un romanzo sull’arte di narrare storie. Ci sono le storie degli altri, raccontate dalla madre di Lucy nella stanza di ospedale: come una bambina che non riesce ad addormentarsi, Lucy, «Bestiolina», chiede a sua madre «raccontami ancora». E così la stanza anonima dell’anonimo ospedale newyorkese si popola di figure che arrivano dalla provincia.
Ci sono le storie delle persone che Lucy ha incontrato nel suo cammino che l’ha portata lontana dalla provincia: i maestri che ha avuto da bambina, l’artista di cui è stata innamorata al college, e poi Jeremy, Molla, la scrittrice Sarah Payne, il dottore a cui Lucy vuole bene, e suo marito William. C’è la storia della famiglia di Lucy, che ha vissuto in un garage ad Amgash, che sempre si è vergognata della propria miseria, che ha mangiato pane e melassa per cena e ha sofferto l’inverno e gli sguardi di chi l’ha compatita. C’è la storia di Lucy, narrata in prima persona, che inizia sì in quella stanza d’ospedale ma che si muove tra passato e futuro, abbracciando l’infanzia della protagonista fino ad arrivare alla sua vecchiaia: in mezzo, ci sono quei cinque giorni di ospedale, l’ultima vera occasione per sentirsi dire dalla propria madre «ti voglio bene».
Il mestiere di scrivere
E c’è poi una vera e propria riflessione sul mestiere della scrittura: perché prima ancora di essere un io narrante, Lucy è una scrittrice, e nel corso del libro non fa che riflettere su questa sua condizione, sulla necessità della scrittura. Così quando il lettore meno se lo aspetta, Elizabeth Strout, nei panni dei propri personaggi, risponde a delle domande centrali per chi cerchi di penetrare il mistero della scrittura. «E quale sarebbe il suo mestiere come romanziera?’, fece lui. Il suo mestiere come romanziera era riferire della condizione umana, raccontare chi siamo e cosa pensiamo e come ci comportiamo». Poco importa che sia una risposta inserita nella narrazione romanzesca: noi lettori sentiamo che quello che la Strout ha deciso di fare con questo romanzo è proprio raccontare chi siamo e cosa pensiamo e come ci comportiamo.

Elizabeth Strout
La narrazione si muove non solo su diversi piani temporali, ma anche divisa tra città e provincia, tra il desiderio di tagliare per sempre i ponti con Amgash e il non sentirsi mai del tutto al proprio posto a New York. Quello che Lucy prova a fare è proprio conciliare queste due nostalgie: aggrapparsi con spietatezza a se stessa, scrivere di se stessa, perché dalla sua insegnante di scrittura ha imparato che «ciascuno ha soltanto una storia. Scriverete la vostra unica storia in molti modi diversi. Ma tanto ne avete una sola».
La parola di Lucy è limpida ma non si sottrae ai tentennamenti: non è raro che il discorso si interrompa, metta in dubbio se stesso, si interroghi sulla propria veridicità. Quello che sto raccontando è vero, o sono io che ricordo male?, si chiede spesso Lucy. Così la storia si nasconde nella reticenza e nel non detto, nei silenzi che pesano di più delle parole scritte.
Non è un romanzo per ragazze
Ma non chiamatelo un romanzo per ragazze, sembra dire continuamente Elizabeth Strout. Anche se le donne sono il cuore del libro; anche se le loro storie muovono la narrazione. Anche se nel romanzo è presente una profonda riflessione sulla maternità e i conflitti che la maternità porta con sé: quello tra essere madre ed essere figlia, quello tra essere donna ed essere madre. Nella stanza d’ospedale, Lucy ha bisogno di riconciliare lo strappo con sua madre, che mai l’ha davvero perdonata per essersene andata, per aver studiato, per aver abbandonato la provincia. E poi di nuovo, in un’altra camera, con sua madre questa volta malata, Lucy ha bisogno di dirle addio: di iniziare a vivere senza lei, la sua ombra che sempre l’ha schiacciata con il senso di colpa e di inadeguatezza, ma che l’ha anche protetta.
Nella scrittura, Lucy ha bisogno di rimarginare la ferita che si è aperta quando le sue figlie sono andate al college, e il suo matrimonio è fallito, perdendo il collante che aveva tenuto per tutti quegli anni Lucy e William insieme: la sicurezza di essere un padre e una madre, prima ancora di essere un uomo e una donna. La necessità di diventare di nuovo una donna e basta. Ma non chiamatelo un romanzo per ragazze: è un romanzo per chi, come Lucy, ha bisogno di dire Questo è mio. Questa persona sono io. Io mi chiamo Lucy Barton.
gabriella.dallago@gmail.com
G Dal Lago è laureanda in letteratura italiana