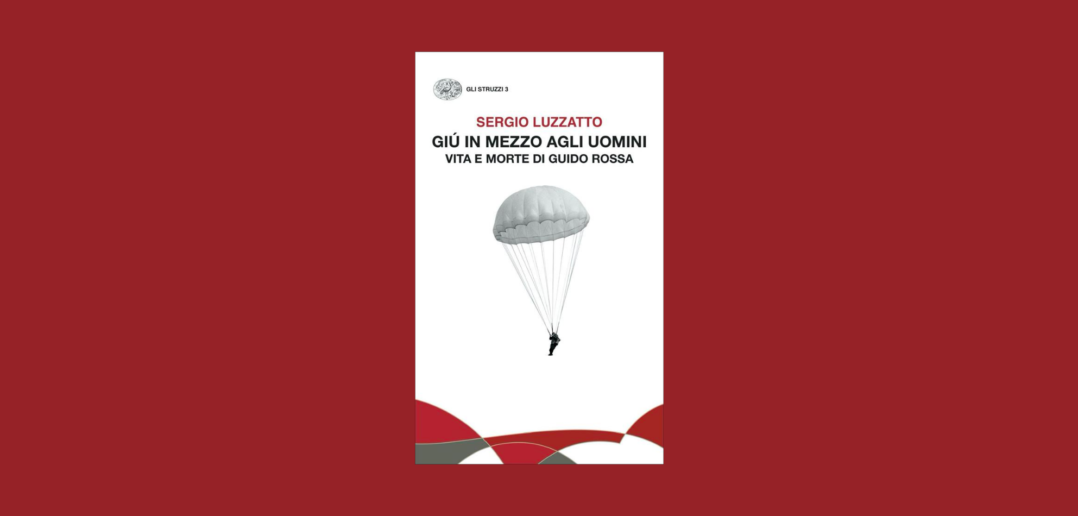Il coraggio, la coerenza, le vette e la fabbrica
di Andrea Casalegno
Sergio Luzzatto
Giù in mezzo agli uomini
Vita e morte di Guido Rossa
pp. XIV-240, € 16,
Einaudi, Torino 2021
 24 gennaio 1979, Genova, via Fracchia. Sabina Rossa, sedici anni, esce alle sette e mezza del mattino per andare a scuola. Il cielo è ancora buio, passando non si accorge che la Fiat 850 è ancora al suo posto lungo il marciapiede. Suo padre Guido, operaio e delegato all’Italsider, è uscito un’ora prima, ma non è arrivato al posto di lavoro: è lì, di traverso sui sedili, con il capo appoggiato al volante. Vincenzo Guagliardo, militante delle Brigate rosse, gli ha sparato tre colpi alle gambe; poi il capo della colonna genovese, Riccardo Dura, gli ha sparato al cuore. Pochi giorni prima Guido Rossa aveva confidato a un amico, alpinista come lui, Piero Villaggio (il fratello di Paolo), “che si riteneva condannato a morte”. Così ci dice Sergio Luzzatto nel libro che dedica alla vita e alla morte di Guido Rossa. Non era stato lui a trovare, il 25 ottobre 1978, i volantini delle Br lasciati in fabbrica da Francesco Berardi, che si suiciderà in carcere un anno dopo. Ma è stato Rossa “l’unico firmatario della testimonianza contro di lui”, è stato Rossa “l’unico testimone a carico nell’aula del Palazzo di giustizia”, dove si è presentato completamente solo. “Il Secolo XIX”, incautamente, ha pubblicato il suo nome e ha descritto la sua figura: “Semicalvo, barbuto, con il giubbotto blu”. La logica del terrorismo, lo dice il nome, è crudele: colpirne uno per spaventarne cento. Rossa era condannato e lo sapeva. Lasciato solo, non aveva scampo. Ma era anche un operaio, un delegato. E allora il volantino di rivendicazione delle Br si esibisce in questo capolavoro di ipocrisia: “Era intenzione del nucleo di limitarsi a invalidare la spia come prima e unica mediazione nei confronti di questi miserabili: ma l’ottusa reazione opposta dalla spia ha reso inutile ogni mediazione e pertanto è stato giustiziato”. Non ci sono parole per commentare questo linguaggio abietto. Reazione? Rossa era disarmato. Reazione verbale? Forse. Il 26 agosto 2020 Luzzatto parla con Dino Rabbi, amico e compagno di cordata di Rossa: “Secondo me Guido gli ha gridato qualcosa”. L’ipotesi è che Dura si sia sentito offeso, sia tornato indietro e lo abbia ucciso. Non ci credo. Dura, detto “Pol Pot” dai suoi compagni, era spietato ma non imbecille. Un rivoluzionario, tale riteneva di essere, non uccide per una parola, se non l’ha già deciso. Tuttavia uccidere un operaio, un delegato, in fabbrica non è popolare: l’“ottusa reazione” viene utile per tentare di giustificarsi.
24 gennaio 1979, Genova, via Fracchia. Sabina Rossa, sedici anni, esce alle sette e mezza del mattino per andare a scuola. Il cielo è ancora buio, passando non si accorge che la Fiat 850 è ancora al suo posto lungo il marciapiede. Suo padre Guido, operaio e delegato all’Italsider, è uscito un’ora prima, ma non è arrivato al posto di lavoro: è lì, di traverso sui sedili, con il capo appoggiato al volante. Vincenzo Guagliardo, militante delle Brigate rosse, gli ha sparato tre colpi alle gambe; poi il capo della colonna genovese, Riccardo Dura, gli ha sparato al cuore. Pochi giorni prima Guido Rossa aveva confidato a un amico, alpinista come lui, Piero Villaggio (il fratello di Paolo), “che si riteneva condannato a morte”. Così ci dice Sergio Luzzatto nel libro che dedica alla vita e alla morte di Guido Rossa. Non era stato lui a trovare, il 25 ottobre 1978, i volantini delle Br lasciati in fabbrica da Francesco Berardi, che si suiciderà in carcere un anno dopo. Ma è stato Rossa “l’unico firmatario della testimonianza contro di lui”, è stato Rossa “l’unico testimone a carico nell’aula del Palazzo di giustizia”, dove si è presentato completamente solo. “Il Secolo XIX”, incautamente, ha pubblicato il suo nome e ha descritto la sua figura: “Semicalvo, barbuto, con il giubbotto blu”. La logica del terrorismo, lo dice il nome, è crudele: colpirne uno per spaventarne cento. Rossa era condannato e lo sapeva. Lasciato solo, non aveva scampo. Ma era anche un operaio, un delegato. E allora il volantino di rivendicazione delle Br si esibisce in questo capolavoro di ipocrisia: “Era intenzione del nucleo di limitarsi a invalidare la spia come prima e unica mediazione nei confronti di questi miserabili: ma l’ottusa reazione opposta dalla spia ha reso inutile ogni mediazione e pertanto è stato giustiziato”. Non ci sono parole per commentare questo linguaggio abietto. Reazione? Rossa era disarmato. Reazione verbale? Forse. Il 26 agosto 2020 Luzzatto parla con Dino Rabbi, amico e compagno di cordata di Rossa: “Secondo me Guido gli ha gridato qualcosa”. L’ipotesi è che Dura si sia sentito offeso, sia tornato indietro e lo abbia ucciso. Non ci credo. Dura, detto “Pol Pot” dai suoi compagni, era spietato ma non imbecille. Un rivoluzionario, tale riteneva di essere, non uccide per una parola, se non l’ha già deciso. Tuttavia uccidere un operaio, un delegato, in fabbrica non è popolare: l’“ottusa reazione” viene utile per tentare di giustificarsi.
Tre giorni dopo una folla immensa dà l’ultimo saluto a Guido Rossa. E qui, scrive Luzzatto, “l’appropriazione edificante della figura di Rossa da parte del partito e del sindacato inciampa nell’intervento di Luciano Lama”. Ecco le sue parole, riportate da “l’Unità”: “Riconosciamo sinceramente che se il gesto di coraggio civile compiuto dal compagno Rossa non fosse rimasto troppo isolato, se attorno a lui, nel momento più arduo della prova, noi tutti, a cominciare dagli operai dell’Italsider, fossimo stati un solo grande testimone schierato contro il nemico della democrazia, forse la vita di questo compagno non sarebbe stata spezzata”. Ma chi era questo compagno? Non lo sapremo mai se non guarderemo, al di là della sua morte, la sua vita. Ed è ciò che si è proposto Luzzatto, che la ricostruisce tutta, a partire da quella dei suoi genitori, immigrati a Torino dal bellunese, scavando, al di là delle numerose testimonianze edite, soprattutto negli archivi familiari. Il risultato è il ritratto a tutto tondo di un uomo impegnato “in un prolungato, faticoso corpo a corpo con il lato oscuro di sé stesso”. Rossa è un personaggio complesso: grande alpinista prima che operaio, ardito nel corpo e nella mente, appassionato fotografo, non solo comunista militante e delegato sindacale. “A quindici anni aveva iniziato a lavorare in fabbrica come meccanico, dai diciotto in poi si era affermato come uno scalatore tra i più forti della sua generazione, a ventidue aveva preso a lanciarsi col paracadute da alpino assaltatore, a venticinque era entrato a Mirafiori sud per stampare lamiere da fresatrici Keller alte due piani, a ventisette si era trasferito a Genova per ricominciare da padre di famiglia quale aggiustatore all’Italsider, a ventotto era partito per conquistare un settemila in Nepal”. La sua vita è segnata dalla tragedia. Nella spedizione del 1963 al Lirung, una cima inviolata, due dei dieci alpinisti del Cai di Torino, Giorgio Rossi e Cesare Volante, muoiono travolti da una valanga “per il cedimento delle corde fisse lungo il canalone”. Guido e Dino Rabbi si occupano della sepoltura. L’anno seguente, al Becco di Valsoera, “dopo il cedimento di un chiodo fissato male”, Guido fa un volo di ottanta metri. Si salva per miracolo, e l’indomani, “dopo un bivacco in parete, è capace di compiere a corda doppia e con una gamba rotta il resto della discesa”. Rischiando la vita sui monti Rossa cerca di superare un trauma ben più atroce. Il 7 dicembre 1961 suo figlio Fabio è morto a due anni, in casa della nonna, per una fuga di gas. Nato il primo dicembre 1934, Guido aveva sposato Silvia il 23 aprile 1959, ad Arenzano. Testimone di nozze è stato Dino Rabbi.
Quasi sempre l’alpinismo estremo è una passione totalizzante. I grandi amici di Rossa sono tutti alpinisti: l’operaio Corradino Rabbi, il notaio valdostano Ottavio Bastrenta, il professore genovese Piero Villaggio. L’alpinismo sarà anche un legame tra Guido e Bruno Trentin. L’ex segretario generale della Fiom lo ricorda nell’agosto 1999, a Belluno, la terra natale dei genitori di Rossa, insieme a Dino Rabbi. Appassionato di alpinismo, Trentin conosceva Rossa e si proponeva di scalare con lui. Ma non ne avrà il tempo. Dovrà accompagnare Lama a Genova, in piazza De Ferrari. La passione per la montagna basta, da sola, a dare senso a una vita? Forse Rossa lo ha creduto in passato. Ora non più. Tra il 15 febbraio e il 4 marzo 1970 scrive all’amico Bastrenta una lettera di trenta pagine, che comincia così: “Ottavio carissimo, l’indifferenza, il qualunquismo e l’ambizione che dominano nell’ambiente alpinistico… sono tra le squallide cose che mi lasciano scendere senza rimpianto la famosa ‘lizza’ della mia stagione alpina”. E continua: “Penso che anche noi dobbiamo finalmente scendere giù in mezzo agli uomini a lottare con loro”. Nel 1967 Rossa si era iscritto alla sezione Italsider del Partito comunista. Nel 1970, l’anno dello Statuto dei lavoratori e della trasformazione delle commissioni interne in consigli di fabbrica, diventa delegato di reparto. Nel 1974 sarà rieletto “con 175 voti di preferenza su 212 voti validi”.
Nell’ambiente alpinistico l’atteggiamento di Rossa non passa inosservato. Nel settembre 1972 Gian Piero Motti, brillante alpinista e scrittore torinese, pubblica sulla rivista mensile del Club Alpino Italiano un articolo che farà epoca sull’ossessione dell’alpinismo fine a sé stesso. Lo intitola I falliti. Scrive: “Incontrerò una sera d’inverno Guido Rossa, il quale fissandomi a lungo, con quei suoi occhi che ti scavano e ti bruciano l’anima, con quella sua voce calma e posata, mi dirà delle cose che avranno un valore definitivo. Mi dirà che l’errore più grande è vedere nella vita solo l’alpinismo, che bisogna nutrire altri interessi, utili non solo a sé stessi ma anche agli altri uomini”. C’è però una lezione della montagna che Guido Rossa non ha mai rinnegato: la lezione del coraggio. Il 2 dicembre 1977 è, con gli altri compagni dell’Italsider, a presidiare in piazza San Giovanni, a Roma, il palco di Luciano Lama contro l’assalto degli “autonomi”. “Volavano pietre grosse così” racconta il collega Renato Penzo. “Io mi difendevo in modo scomposto. Lui invece era lì fermo. Gli chiedo: ma tu non hai paura? Rossa sorrise: Se perdessi la testa quando c’è pericolo non avrei mai fatto un passo in montagna”.
Un anno dopo, in fabbrica, Penzo gli pone la stessa domanda: non hai paura? Tutti si aspettano la vendetta delle Br. Rossa risponde: “Ho scalato di tutto, sempre rischiando la vita, per provare il mio coraggio. A un certo punto mi sono reso conto che questo gusto del rischio era senza scopo e poteva sfociare nell’arditismo fine a sé stesso. E ho capito che ci vuole più fegato a essere coerente tutti i giorni. L’ho capito qui in fabbrica, negli anni difficili per noi comunisti”.
casalegno.salvatorelli@gmail.com
A. Casalegno è giornalista