Valorizzare l’irrazionale senza smitizzarlo
di Riccardo Gasperina Geroni
Albergo Roma, a Torino: 27 agosto 1950. Cesare Pavese è riverso sul letto, la testa appoggiata sul cuscino, e lo sguardo rivolto verso il cielo della notte appena trascorsa. Alla sua destra sul comodino, una decina di bustine di sonnifero sparpagliate e strappate. Con lui, in quella stanza, i Dialoghi con Leucò, l’opera a cui era più affezionato e che aveva appoggiato sul tavolo, affinché fosse subito ritrovata. Sulla prima pagina, poche parole lasciate in eredità: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”. È una scena nota, e oggi un po’ consunta, ma che ha segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni di lettori che hanno amato e apprezzato la sua opera letteraria. “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, recitava il verso iniziale della poesia omonima, di certo la più amata dai suoi lettori, soprattutto quelli più giovani: “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. / Sarà come smettere un vizio, / come vedere nello specchio / riemergere un viso morto, / come ascoltare un labbro chiuso”. E quando la morte è arrivata, Pavese si deve essere specchiato in quel “gorgo” dove tutti noi scenderemo “muti” e che ha nel suo lavoro e nel suo pensiero un ruolo preponderante.
 Qualche giorno fa si sono celebrati i settant’anni dalla sua morte, e sembra giusto chiedersi: che cosa sopravvive ancora oggi di quel mondo letterario, legato all’infanzia langarola, alla guerra civile e alla città di Torino? Indelebili mi risuonano le parole di Natalia Ginzburg che, in un ricordo commosso dell’amico, scriveva che in sua compagnia si diventava, in qualche modo, più intelligenti, migliori. È un’esperienza che forse abbiamo provato tutti quanti, in presenza della persona che amiamo o che semplicemente stimiamo, ci sentiamo spinti a portare nelle parole quanto abbiamo “in noi di migliore e di più serio; butt(iamo) via i luoghi comuni, i pensieri imprecisi, le incoerenze”. La bellezza e il senso delle parole che dovrebbero riflettere quanto portiamo dentro, quella bellezza che Pavese non ha mai smesso di cercare dentro di sé, scavando nelle profondità della propria coscienza. Le parole di Ginzburg sono gentili, e omaggiano senz’altro l’amico e collega di casa Einaudi, di cui non può tuttavia non ricordare anche quella tristezza, che i tanti che l’hanno conosciuto gli riconoscevano: era una tristezza infantile, “voluttuosa e svagata”, propria “del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni”.
Qualche giorno fa si sono celebrati i settant’anni dalla sua morte, e sembra giusto chiedersi: che cosa sopravvive ancora oggi di quel mondo letterario, legato all’infanzia langarola, alla guerra civile e alla città di Torino? Indelebili mi risuonano le parole di Natalia Ginzburg che, in un ricordo commosso dell’amico, scriveva che in sua compagnia si diventava, in qualche modo, più intelligenti, migliori. È un’esperienza che forse abbiamo provato tutti quanti, in presenza della persona che amiamo o che semplicemente stimiamo, ci sentiamo spinti a portare nelle parole quanto abbiamo “in noi di migliore e di più serio; butt(iamo) via i luoghi comuni, i pensieri imprecisi, le incoerenze”. La bellezza e il senso delle parole che dovrebbero riflettere quanto portiamo dentro, quella bellezza che Pavese non ha mai smesso di cercare dentro di sé, scavando nelle profondità della propria coscienza. Le parole di Ginzburg sono gentili, e omaggiano senz’altro l’amico e collega di casa Einaudi, di cui non può tuttavia non ricordare anche quella tristezza, che i tanti che l’hanno conosciuto gli riconoscevano: era una tristezza infantile, “voluttuosa e svagata”, propria “del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni”.
 È indubbio che la morte di Cesare Pavese abbia lasciato un vuoto che noi ora non siamo più in grado di comprendere: era all’apice del successo, aveva appena vinto il Premio Strega con la trilogia della Bella estate, ed era il centro intorno a cui ruotava una fetta importante del mondo della cultura italiana; tuttavia, credo sia arrivato il tempo di scrollarsi di dosso il peso di quella silenziosa dipartita, e concentrarsi di più sulle sue opere, seguendo proprio quell’accorato invito che lui stesso ci aveva rivolto nelle poche frasi di congedo: “non fate troppi pettegolezzi”. Lo dico, perché la sua morte ha prodotto nella ricezione dei suoi lavori una distorsione, come una lente colorata che si frappone tra l’osservatore e il mondo, e lo trasforma. Così le sue opere sono state scandagliate e lette con una morbosa attenzione per il dettaglio che avrebbe finalmente rivelato la causa di quel “vizio assurdo”. Eccolo: ora era l’impotenza, ora le donne amate (Tina Pizzardo, Fernanda Pivano, Constance Dowling per citarne alcune) che non lo corrispondevano, ora la colpa di non aver preso parte alla guerra civile, e forse di non esserci morto, ora tutte queste cose insieme. Pure il suo interprete più acuto, il germanista e mitologo Furio Jesi, è caduto nella trappola del suo suicidio, riconducendo le sue opere a un côté mitteleuropeo, in cui la morte avrebbe rappresentato l’ultimo rifugio dove scovare le fonti originarie del mito e della vita.
È indubbio che la morte di Cesare Pavese abbia lasciato un vuoto che noi ora non siamo più in grado di comprendere: era all’apice del successo, aveva appena vinto il Premio Strega con la trilogia della Bella estate, ed era il centro intorno a cui ruotava una fetta importante del mondo della cultura italiana; tuttavia, credo sia arrivato il tempo di scrollarsi di dosso il peso di quella silenziosa dipartita, e concentrarsi di più sulle sue opere, seguendo proprio quell’accorato invito che lui stesso ci aveva rivolto nelle poche frasi di congedo: “non fate troppi pettegolezzi”. Lo dico, perché la sua morte ha prodotto nella ricezione dei suoi lavori una distorsione, come una lente colorata che si frappone tra l’osservatore e il mondo, e lo trasforma. Così le sue opere sono state scandagliate e lette con una morbosa attenzione per il dettaglio che avrebbe finalmente rivelato la causa di quel “vizio assurdo”. Eccolo: ora era l’impotenza, ora le donne amate (Tina Pizzardo, Fernanda Pivano, Constance Dowling per citarne alcune) che non lo corrispondevano, ora la colpa di non aver preso parte alla guerra civile, e forse di non esserci morto, ora tutte queste cose insieme. Pure il suo interprete più acuto, il germanista e mitologo Furio Jesi, è caduto nella trappola del suo suicidio, riconducendo le sue opere a un côté mitteleuropeo, in cui la morte avrebbe rappresentato l’ultimo rifugio dove scovare le fonti originarie del mito e della vita.
 L’anniversario è il momento giusto per riannodare i fili di questa storia, e in questa direzione ci sono stati e ci saranno quest’anno occasioni, eventi e pubblicazioni. A muoversi in prima battuta è stata la casa editrice Einaudi, in cui Pavese ha lavorato sin dalla sua fondazione in qualità di redattore e di direttore editoriale, e che con il 2020 perde i diritti di esclusiva sull’opera pavesiana, d’ora in avanti accessibile a tutti gli editori con esiti a tutt’oggi imprevedibili. Intanto, in libreria dal 26 maggio, si trovano i testi ripubblicati da Einaudi che sono, nell’ordine, Le poesie, Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il diavolo sulle colline, Tra donne sole, La luna e i falò, Il mestiere di vivere. La scelta, che presenta una veste grafica rinnovata e davvero originale a firma di Manuele Fior, è dettata dalla volontà di riproporre al mercato italiano i testi più noti della sua produzione, mantenendo le precedenti “note al testo” (scientifiche e molto dettagliate dei diversi Guglielminetti, Masoero, Nay, Zaccaria) ma aggiungendovi una nuova introduzione a firma di scrittori e intellettuali che gravitano, da anni, intorno alla casa editrice torinese. Sempre nell’ordine, Tiziano Scarpa, Nicola Gardini, Donatella Di Pietrantonio, Paolo Giordano, Nicola Lagioia, Wu Ming e Domenico Starnone hanno arricchito con ricordi, aneddoti, riflessioni, interpretazioni originali e accessibili a un pubblico ampio ed eterogeneo, le tradizionali ristampe. È una strategia che risponde in modo coerente al calo progressivo dell’interesse che si è verificato nella critica e nei lettori nei confronti dell’opera di Pavese, e che al contempo preserva la parte più spiccatamente scientifica e di ricerca che da sempre contraddistingue i lavori einaudiani.
L’anniversario è il momento giusto per riannodare i fili di questa storia, e in questa direzione ci sono stati e ci saranno quest’anno occasioni, eventi e pubblicazioni. A muoversi in prima battuta è stata la casa editrice Einaudi, in cui Pavese ha lavorato sin dalla sua fondazione in qualità di redattore e di direttore editoriale, e che con il 2020 perde i diritti di esclusiva sull’opera pavesiana, d’ora in avanti accessibile a tutti gli editori con esiti a tutt’oggi imprevedibili. Intanto, in libreria dal 26 maggio, si trovano i testi ripubblicati da Einaudi che sono, nell’ordine, Le poesie, Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il diavolo sulle colline, Tra donne sole, La luna e i falò, Il mestiere di vivere. La scelta, che presenta una veste grafica rinnovata e davvero originale a firma di Manuele Fior, è dettata dalla volontà di riproporre al mercato italiano i testi più noti della sua produzione, mantenendo le precedenti “note al testo” (scientifiche e molto dettagliate dei diversi Guglielminetti, Masoero, Nay, Zaccaria) ma aggiungendovi una nuova introduzione a firma di scrittori e intellettuali che gravitano, da anni, intorno alla casa editrice torinese. Sempre nell’ordine, Tiziano Scarpa, Nicola Gardini, Donatella Di Pietrantonio, Paolo Giordano, Nicola Lagioia, Wu Ming e Domenico Starnone hanno arricchito con ricordi, aneddoti, riflessioni, interpretazioni originali e accessibili a un pubblico ampio ed eterogeneo, le tradizionali ristampe. È una strategia che risponde in modo coerente al calo progressivo dell’interesse che si è verificato nella critica e nei lettori nei confronti dell’opera di Pavese, e che al contempo preserva la parte più spiccatamente scientifica e di ricerca che da sempre contraddistingue i lavori einaudiani.
Dalle introduzioni emerge un Pavese letto da più prospettive e differenti sensibilità, che danno rilievo non solo alla sua attività di romanziere e a quella di poeta (mai veramente scisse nei suoi lavori) ma anche al suo ruolo cruciale di intellettuale. Non si dimentichi che, insieme alla collaborazione dell’antropologo Ernesto de Martino, autore del Mondo magico, volume n. 1 della nota “Collana Viola” (1948, sulla cui esperienza si rimanda al bel libro a cura di Pietro Angelini, La collana viola. Lettere 1945-1950, Bollati Boringhieri, 1991), Pavese si è fatto portavoce e interprete di alcune discipline come la fenomenologia della religione e la psicoanalisi archetipica, che difficilmente sarebbero penetrate in Italia, visto il loro alto contenuto di elementi considerati irrazionali dalla critica marxista.
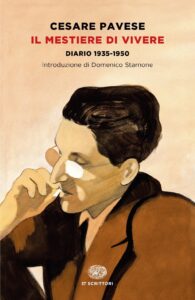 Starnone, nell’Introduzione al Mestiere, sottolinea proprio come nel suo diario, redatto fra il 1935 e il 1950, costanti siano le metafore legate alla scrittura e al pensiero come arte della costruzione. “La lezione è questa: costruire in arte e costruire nella vita, bandire il voluttuoso dall’arte come dalla vita, essere tragicamente”. Si tratta di un appunto del 20 aprile del 1936, in cui c’è già tutto Pavese, così speso a fare della scrittura acuminata e del pensiero profondo gli strumenti a difesa dalla barbarie che intanto si stava diffondendo a macchia d’olio nel vecchio mondo. È un mestiere, quello dell’intellettuale; e in quanto tale va coltivato, protetto, curato sino a trasformarlo nella propria vita, nel proprio mestiere con tutte le contraddizioni che questo comporta. Spedito al confino per errore, antifascista claudicante, poi estemporaneo cultore degli ideali fascisti, infine tesserato del Partito comunista, Pavese è stato tutto questo, e il contrario. Lo si evince anche dalla bella biografia, così sentita e intima, che molti anni fa gli ha dedicato l’amico Davide Lajolo, Il vizio assurdo. Storia di Cesare Pavese, opera introvabile da molti anni sul mercato e che è stata ora ristampata (con la Prefazione di Andrea Bajani, pp. 553, € 21) da minimum fax.
Starnone, nell’Introduzione al Mestiere, sottolinea proprio come nel suo diario, redatto fra il 1935 e il 1950, costanti siano le metafore legate alla scrittura e al pensiero come arte della costruzione. “La lezione è questa: costruire in arte e costruire nella vita, bandire il voluttuoso dall’arte come dalla vita, essere tragicamente”. Si tratta di un appunto del 20 aprile del 1936, in cui c’è già tutto Pavese, così speso a fare della scrittura acuminata e del pensiero profondo gli strumenti a difesa dalla barbarie che intanto si stava diffondendo a macchia d’olio nel vecchio mondo. È un mestiere, quello dell’intellettuale; e in quanto tale va coltivato, protetto, curato sino a trasformarlo nella propria vita, nel proprio mestiere con tutte le contraddizioni che questo comporta. Spedito al confino per errore, antifascista claudicante, poi estemporaneo cultore degli ideali fascisti, infine tesserato del Partito comunista, Pavese è stato tutto questo, e il contrario. Lo si evince anche dalla bella biografia, così sentita e intima, che molti anni fa gli ha dedicato l’amico Davide Lajolo, Il vizio assurdo. Storia di Cesare Pavese, opera introvabile da molti anni sul mercato e che è stata ora ristampata (con la Prefazione di Andrea Bajani, pp. 553, € 21) da minimum fax.
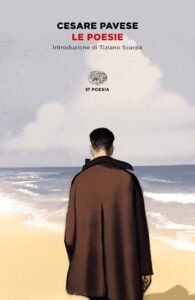 È vero quanto scrive Scarpa nell’Introduzione alle Poesie: “Cesare Pavese era un cinico in una società di ipocriti. Cinico come i filosofi cinici greci, Diogene, Antistene, Cratete, Ipparchia; cinico come i cani. Ma più timido, più irresoluto di loro”. E il suo sogno era davvero quello di poter vivere nudi, a contatto con la terra, raschiarla e scavarla, toccare quelle profondità da cui siamo nati e in cui ci rifonderemo una volta morti. Le sue poesie, infatti, sono piene di persone che si stendono sulla terra, si allungano all’ombra di un cipresso, oppongono la forza vitale e primigenia del proprio corpo nudo al conformismo di chi sta, invece, in piedi e vestito. Distesi sono i suoi personaggi come se si stirassero e si stendessero sulla lunghezza di quei versi alieni alla tradizione italiana, fondati sul ritmo lungo dell’anapesto (breve, breve, lunga), che, ricorda Scarpa, è il ritmo del mondo animale, del mondo subcosciente: “Camminiàmo una séra sul fiànco di un còlle / Stupefàtto del mòndo mi giúnse un’età…”. Su questo ha ragione Nicola Gardini, nell’introduzione ai Dialoghi con Leucò, c’è in Pavese una poetica della felicità che, tuttavia, aggiungo io, è controbilanciata da una poetica della colpa, quella di sentirsi vivi al cospetto di una natura che ci può annichilire e distruggere. Tutto in Pavese è costruito nel segno del due, della polarità che mai si risolve in sintesi dialettica: all’adulto si contrappone l’infante, alla seconda volta la prima, alla città la campagna, al logos il mito, all’uomo la donna.
È vero quanto scrive Scarpa nell’Introduzione alle Poesie: “Cesare Pavese era un cinico in una società di ipocriti. Cinico come i filosofi cinici greci, Diogene, Antistene, Cratete, Ipparchia; cinico come i cani. Ma più timido, più irresoluto di loro”. E il suo sogno era davvero quello di poter vivere nudi, a contatto con la terra, raschiarla e scavarla, toccare quelle profondità da cui siamo nati e in cui ci rifonderemo una volta morti. Le sue poesie, infatti, sono piene di persone che si stendono sulla terra, si allungano all’ombra di un cipresso, oppongono la forza vitale e primigenia del proprio corpo nudo al conformismo di chi sta, invece, in piedi e vestito. Distesi sono i suoi personaggi come se si stirassero e si stendessero sulla lunghezza di quei versi alieni alla tradizione italiana, fondati sul ritmo lungo dell’anapesto (breve, breve, lunga), che, ricorda Scarpa, è il ritmo del mondo animale, del mondo subcosciente: “Camminiàmo una séra sul fiànco di un còlle / Stupefàtto del mòndo mi giúnse un’età…”. Su questo ha ragione Nicola Gardini, nell’introduzione ai Dialoghi con Leucò, c’è in Pavese una poetica della felicità che, tuttavia, aggiungo io, è controbilanciata da una poetica della colpa, quella di sentirsi vivi al cospetto di una natura che ci può annichilire e distruggere. Tutto in Pavese è costruito nel segno del due, della polarità che mai si risolve in sintesi dialettica: all’adulto si contrappone l’infante, alla seconda volta la prima, alla città la campagna, al logos il mito, all’uomo la donna.
Proprio a questo aspetto è dedicata la seconda iniziativa di un certo rilievo nell’anno dell’anniversario della sua morte. Mi riferisco alla miscellanea di scritti pavesiani, Cesare Pavese, il racconto tra razionale e irrazionale, edita dalla rivista “Ticontré”, a firma di Carlo Tirinanzi De Medici, uno dei curatori (con Massimiliano Tortora e Giancarlo Alfano), che nell’Introduzione discute proprio del ruolo che Pavese si era proposto di ricoprire in quanto “poeta” e attento esploratore della dimensione mitica. In un appunto del Mestiere, egli ricorda la necessità di “valorizzare l’irrazionale”. “Il tuo problema poetico – aggiunge il 7 febbraio del 1944, parlando a se stesso – è valorizzarlo senza smitizzarlo”. Ecco il centro dell’intera riflessione pavesiana, l’idea di portare il mito nella storia senza fargli perdere quella forza originaria, quella freschezza di un altro tempo nel tempo della storia presente. È il nucleo aporetico del suo pensiero, che vuole tenere insieme due polarità inconciliabili. E questo è, di certo, il motivo che ha spinto tanti esegeti del suo pensiero a parlare di fallimento della sua poetica. Ammesso che di fallimento si possa parlare, la sua opera va oggi letta non più alla luce del suo suicidio, che ne coronerebbe il fallimento umano, ma in relazione alla forza che i suoi testi ancora ci regalano. In quest’ottica, si inseriscono i saggi contenuti nel volume e ai quali caldamente rimando coloro i quali siano interessati ad approfondire gli aspetti scientifici della produzione saggistica di questi anni intorno alle opere di Pavese. Tra questi, si segnalano in particolare i saggi di Maririta Guerbo (su de Martino e Pavese) e di Salvatore Renna (sulla rifunzionalizzazione del motivo della metamorfosi nei Dialoghi).
Da ultimo, si ricordano due importanti convegni internazionali che vedranno la partecipazione di esperti pavesiani, di vecchia e nuova generazione: il primo, organizzato da Daniela Vitagliano e intitolato Cesare Pavese. Scrittura, lingua e stile, si terrà presso l’università Sorbonne Nouvelle di Parigi in autunno (le date devono essere ancora fissate), mentre il secondo, dal titolo Cesare Pavese: dialoghi con i classici, si svolgerà dal 3 al 4 novembre, all’Università di Torino in collaborazione con il Centro interuniversitario per gli studi di letteratura italiana in Piemonte.
riccardo.gasperina@unibo.it
R. Gasperina Geroni è italianista e ricercatore presso l’Università di Bologna


