Nostalgie restauratrici e consumi di lusso
recensione di Luca Simonetti
dal numero di marzo 2016
Vito Teti
FINE PASTO
Il cibo che verrà
pp. VI-155, € 11
Torino, Einaudi 2015
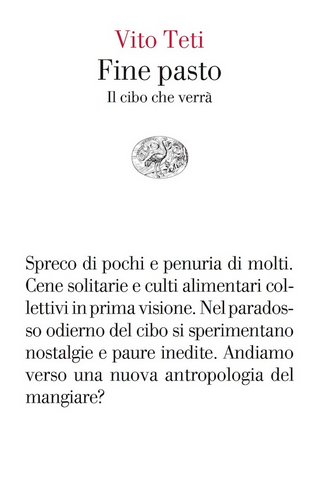 Il libro di Teti considera il trapasso alla modernità come passaggio da “un regime alimentare sobrio, precario ma ‘equilibrato’” a uno “sempre più vario, articolato, a volte abbondante e col tempo eccessivo”. Nota come oggi l’alimentazione sia priva di modelli o regole condivise, il che conduce sia a un disorientamento, una “gastro-anomia”, sia a un’ossessione dietetica, una invenzione di nuove regole alimentari (una “ortoressia”), e all’invenzione di tradizioni alimentari mai esistite (come la “dieta mediterranea”). Il problema attuale nascerebbe dal fatto che sono andate perdute le tradizioni e la “sacralità” che indicavano i limiti da non oltrepassare, perdita i cui effetti sono visibili nella nostra difficoltà a raggiungere un equilibrio sostenibile con l’ecosfera. Nell’ultimo capitolo, i toni si fanno cupi: “le magnifiche sorti progressive si sono rivelate un’illusione e l’Occidente si è avviato (…) verso un suicidio da bulimia sociale”. Addirittura, “la tradizione occidentale sembra custodire una sorta di consapevole tendenza al suicidio e all’autodistruzione”. La soluzione consisterebbe nel recupero di una “nuova sacralità”: non per tornare a un eden inesistente, ma per capire “limiti e paradossi dello sviluppo. E (…) che una libertà dai bisogni non coincide poi con il tuffarsi nella dissipazione e nella distruzione del limite”.
Il libro di Teti considera il trapasso alla modernità come passaggio da “un regime alimentare sobrio, precario ma ‘equilibrato’” a uno “sempre più vario, articolato, a volte abbondante e col tempo eccessivo”. Nota come oggi l’alimentazione sia priva di modelli o regole condivise, il che conduce sia a un disorientamento, una “gastro-anomia”, sia a un’ossessione dietetica, una invenzione di nuove regole alimentari (una “ortoressia”), e all’invenzione di tradizioni alimentari mai esistite (come la “dieta mediterranea”). Il problema attuale nascerebbe dal fatto che sono andate perdute le tradizioni e la “sacralità” che indicavano i limiti da non oltrepassare, perdita i cui effetti sono visibili nella nostra difficoltà a raggiungere un equilibrio sostenibile con l’ecosfera. Nell’ultimo capitolo, i toni si fanno cupi: “le magnifiche sorti progressive si sono rivelate un’illusione e l’Occidente si è avviato (…) verso un suicidio da bulimia sociale”. Addirittura, “la tradizione occidentale sembra custodire una sorta di consapevole tendenza al suicidio e all’autodistruzione”. La soluzione consisterebbe nel recupero di una “nuova sacralità”: non per tornare a un eden inesistente, ma per capire “limiti e paradossi dello sviluppo. E (…) che una libertà dai bisogni non coincide poi con il tuffarsi nella dissipazione e nella distruzione del limite”.
Teti è mosso da due impulsi opposti: non mitizzare il mondo preindustriale e non denigrarlo (benché il libro finisca col sottolineare più il secondo pericolo del primo): questo conflitto interno produce ambiguità e contraddizioni. Per esempio, Teti condivide l’idea che il “mangiare in solitudine” sia un comportamento moderno. Ma solo poche pagine prima, aveva ricordato che la solitudine alimentare esisteva anche nella società tradizionale, anzi era la norma (eccezionale era semmai il mangiare assieme e con lentezza). Oppure pensiamo alla sobrietà del mondo d’antico regime. L’autore ovviamente non ignora che essa era conseguenza della scarsa produttività (siccome non si riusciva a produrre stabilmente neppure il necessario, si erano sviluppati dei valori culturali che premiavano la frugalità); ed è lui stesso a ricordare che l’autentica aspirazione dei poveri era mangiare a crepapelle: il mondo tradizionale era disposto ad accontentarsi di poco, ma desiderava proprio l’“eccesso”. Ma allora perché raccontarci che nel passato regnavano equilibrio e sobrietà?

In genere l’autore ha cura di non sottoscrivere certi diffusi luoghi comuni; ma a volte si distrae. Si pensi alla convinzione che incentivare i prodotti Doc, Docg, Igp e compagnia, sia “una sfida di grande rilevanza economica, culturale, identitaria”: in realtà, si tratta solo di prodotti di lusso, che presuppongono l’esistenza di un vasto pubblico di consumatori abbienti, e che dunque non potranno mai servire a rovesciare il “sistema”, dato che lo presuppongono esattamente com’è. O pensiamo all’idea che esista un nesso ovvio e univoco fra lo spreco d’acqua qui e la penuria idrica altrove (da cui lo scandalizzato sfoggio di confronti numerici insensati come “in Italia consumiamo quaranta volte più acqua del contadino del sud-est africano”) o per cui la nostra ricchezza sarebbe fondata sulla povertà degli “altri” (che sappiamo essere falsa fin dagli studi di Paul Bairoch). Per non parlare di teorie grottesche, come quella del preteso “patto implicito” un tempo vigente fra uomo e natura: “ogni cibo era sacro perché necessario (…) non andava sprecato”, sicché “l’uccisione del maiale, un ‘nume protettore’ della famiglia contadina, era una festa e insieme un ‘rito sacrificale’. Si stabiliva una sorta di complicità (…) Il maiale sembrava quasi rassegnato al suo destino”.
La sacralità del cibo, un recupero possibile?
Quando Teti raccomanda di “partire da piccole utopie realizzabili, da gesti quotidiani rivoluzionari e possibili, da scelte tendenti, anche nel piccolo, al rispetto della natura, di tutti gli esseri viventi, della vita”, appare chiara la vicinanza con quelle correnti (dalla decrescita felice a Slow Food) secondo cui un mutamento rivoluzionario può nascere, non già dalla politica, ma dalle scelte di consumo. Si tratta di una tesi implausibile, per le ragioni esposte anni fa in The Rebel Sell (Harper Collins, 2004) di Joseph Heath e Andrew Potter. Allo stesso modo, non è chiaro perché il rimedio ai nostri mali sarebbe una “nuova sacralità” (“sacralità” e “ritualità”, d’altronde, ricorrono nel libro con frequenza ossessiva). Intanto, se persino nel passato la sacralità non si accompagnava a un atteggiamento “equilibrato” verso il cibo, perché ciò dovrebbe avvenire adesso? La sacralità non ha mai salvato nulla dall’esaurimento (la terra un tempo era sacra ma veniva ugualmente depauperata e desertificata; gli animali erano sacri ma venivano sterminati): perché oggi dovrebbe andare altrimenti? L’approccio di tipo sovrastrutturale di Teti, e di tanti altri, a problemi che non sono culturali ma economici, mostra qui vistosamente la corda. È proprio sicuro Teti che la “nostalgia restauratrice, capace di immaginare un futuro diverso”, basti a cambiare le cose? Il problema, ovviamente, è che un mondo in grado di produrre valori diversi dai nostri dovrebbe essere un mondo diverso dal nostro, ma nel libro manca ogni indicazione su come ottenerlo. A tutti piacerebbe una tradizione che garantisse “un legame con quei luoghi che hanno elaborato una saggezza alimentare basata sulla ricerca dell’equilibrio, della salute, del benessere, della socialità, dello stare insieme” e che per soprammercato fosse anche “aperta e dinamica”: ma sospettiamo che una tradizione del genere non sia mai esistita e non possa esistere. E comunque, gli esempi di “resistenza ai modelli omologanti” elencati da Teti, come i banchetti di san Giuseppe, i recuperi delle baite di montagna o il “ritorno alle cucine casalinghe”, non bastano. Infatti, non solo è dubbio che in queste occasioni si recuperi “la sacralità conferita al cibo e al mangiare insieme tipica degli antichi pellegrinaggi” (sospettiamo, invece, che si tratti di un ennesimo happening consumistico): peggio ancora, recuperare la sacralità non serve a nulla, se non si accompagna a un progetto politico per il quale, più che le tradizioni, i riti e i miti del passato, servono gli strumenti razionali, scientifici e economici della modernità.
l.simonetti@spslex.com
L Simonetti è saggista


