Onore, religione e famiglia: il mondo di mezzo dei manutengoli
Intervista a Salvatore Lupo a cura del Larco
La Mafia di Salvatore Lupo, edito da Donzelli, è il nostro libro del mese di giugno. Leggi anche la recensione a cura di Rocco Sciarrone. Qui, invece, l’intervista all’autore del libro a cura del Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata dell’Università di Torino.
Il libro si apre con la definizione di mafia contenuta nel codice penale e l’indicazione dello scarto esistente tra la tipizzazione astratta del reato e i modelli descrittivi proposti da storici e scienziati sociali, che fanno invece riferimento a fenomeni situati e specifici. Come si pone lo storico di fronte alla divaricazione tra “mafia giudiziaria” e “mafia storica” proposta con forza, ad esempio, da alcuni recenti processi su gruppi criminali attivi a Roma?
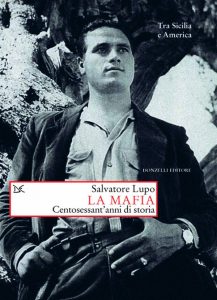 L’uso generalizzato che oggi si fa del plurale mafie riflette un successo planetario del termine, che nel tempo l’ha condotto ben oltre i suoi originari campi di applicazione e geografici e concettuali. Altre volte ho segnalato la perplessità di Giovanni Falcone, espressa nel 1990, quando ancora questi sviluppi non si erano ben definiti: “Non mi va più bene che si continui a parlare di mafia in termini descrittivi e onnicomprensivi perché si affastellano fenomeni che sono sì di criminalità organizzata ma che con la mafia hanno poco o nulla da spartire” (“Segno”, 1990, n. 116). Dal mio punto di vista, il fenomeno è peculiare essenzialmente per ragioni storiche. Innanzitutto, il radicamento secolare in certi territori della Sicilia occidentale, a cominciare da Palermo e molti centri della provincia. E, contemporaneamente, il carattere transoceanico. Abbiamo una serie di interconnessioni, anche qui in una dimensione pressoché secolare, tra gruppi mafiosi collocati in Sicilia e gruppi collocati nell’area orientale degli Stati Uniti. Questi gruppi godono di vasta legittimazione sociale e culturale. Praticano il medesimo rituale (comprovato già negli anni settanta dell’Ottocento). L’appartenenza mafiosa spesso si trasmette su scala pluri-generazionale.
L’uso generalizzato che oggi si fa del plurale mafie riflette un successo planetario del termine, che nel tempo l’ha condotto ben oltre i suoi originari campi di applicazione e geografici e concettuali. Altre volte ho segnalato la perplessità di Giovanni Falcone, espressa nel 1990, quando ancora questi sviluppi non si erano ben definiti: “Non mi va più bene che si continui a parlare di mafia in termini descrittivi e onnicomprensivi perché si affastellano fenomeni che sono sì di criminalità organizzata ma che con la mafia hanno poco o nulla da spartire” (“Segno”, 1990, n. 116). Dal mio punto di vista, il fenomeno è peculiare essenzialmente per ragioni storiche. Innanzitutto, il radicamento secolare in certi territori della Sicilia occidentale, a cominciare da Palermo e molti centri della provincia. E, contemporaneamente, il carattere transoceanico. Abbiamo una serie di interconnessioni, anche qui in una dimensione pressoché secolare, tra gruppi mafiosi collocati in Sicilia e gruppi collocati nell’area orientale degli Stati Uniti. Questi gruppi godono di vasta legittimazione sociale e culturale. Praticano il medesimo rituale (comprovato già negli anni settanta dell’Ottocento). L’appartenenza mafiosa spesso si trasmette su scala pluri-generazionale.
Ma c’è uno specifico del metodo mafioso? La legge italiana vigente dice di sì, e definisce associazione di tipo mafioso quella che fa ricorso alla violenza per garantire ad associati e amici certi vantaggi, o solo minaccia di farlo. Ora, molte sono le organizzazioni criminali che adottano questi metodi. La legge ha un andamento generalizzante, e giustamente: perché la definizione di un reato così grave non può essere certo legata a specifici contesti storici, regionali o peggio etnici. Penso che dunque gli inquirenti si siano mossi nell’ambito della legge accusando di associazione mafiosa quegli affaristi, politicanti, criminali attivi a Roma e che in quell’ambiente si sono formati. Poco importa in quest’ottica il fatto che quella mafia non rientri nei parametri miei o di altri studiosi del fenomeno.
D’altra parte, anche indipendentemente dalla qualificazione giudiziaria del fenomeno mafioso, una delle questioni più controverse è quella dell’individuazione dei suoi “confini”. È infatti inevitabile porsi la domanda su “che cos’è la mafia”, ovvero affrontare il problema della sua definizione e quello dei rapporti con l’ambiente esterno. Perché è difficile rispondere a questa domanda?
Riparto dalla gang di Mafia capitale. Lo stesso suo boss Massimo Carminati si dipingeva come il protagonista di un “mondo di mezzo” capace di mettere in comunicazione il “sovramondo” e il “sottomondo”. Magari lui pensava a Tolkien e al Signore degli anelli. Il mio pensiero invece va allo storico americano Alan Block, il quale definiva “criminalità organizzata” un sistema di “reciproci servizi” che garantisce i rapporti tra i criminali e i loro soci, clienti, protettori, interlocutori nell’establishment politico, economico ed amministrativo; un sistema che connette “membri dell’underworld a individui e istituzioni dell’upperworld” (East Side-West Side, Organizing Crime in New York, 1930-1950, University College Cardiff Press, 1980).
Questa sarebbe anche una buona definizione di mafia. Infatti noi parliamo di un reticolo o network così composto. Nella sfera sotterranea abbiamo un’organizzazione magari compattata da tenebrosi rituali, che è già di per sé interclassista: a guidarla sono in genere “facinorosi della classe media”, per usare la celebre definizione di Franchetti (1876). Tutt’intorno ci sono i “manutengoli”, per usare un’altra espressione ottocentesca, clienti e soci, meno che complici, e protettori. Questi ultimi spesso appartengono al mondo del potere per così dire ufficiale: funzionari pubblici, proprietari anche eminenti, uomini politici. Vorrei però evitare un fraintendimento. Il fatto che le classi dirigenti siano coinvolte nella fenomenologia mafiosa non vuol dire che la questione della mafia militare possa mai essere liquidata come secondaria. Nella rete l’elemento più solido è l’organizzazione mafiosa: l’ala militare, si dice oggi. E non bisogna tornare al discorso allusivo del “terzo livello”, che poi ragiona in base al non tanto sofisticato modello interpretativo del burattino e del burattinaio.
La mafia ha un’ideologia? I mafiosi seguono, a loro modo, un sistema di valori?
I mafiosi si sono sempre rapportati alla tradizione, al senso dell’onore, alla religione, alla famiglia. Tuttora lo fanno. Un po’ strumentalmente, perché consapevoli della necessità di occultarsi nelle pieghe della cultura comunitaria, un po’ perché veramente sono parte di quella cultura. Così quel disvalore che è la mafia rischia di trasformarsi in un valore seppur controverso ed estremizzato nella sua fenomenologia. Nell’Ottocento la virilità era intesa come un valore arcaico, un valore profondo, il valore dei valori: maschio era attività, femmina passività; maschio era Occidente, femmina Oriente; maschio era raziocinio, femmina isteria. Quando il grande etnologo Pitrè diceva, e gli avvocati di mafia ripetevano con lui, che il mafioso è un uomo al cubo, sapeva di affondare profondamente nel sistema valoriale di chi lo stava ad ascoltare. Forse anche oggi, seppure in maniera meno esplicita, agisce un simile meccanismo. Virile, autorevole, conservatore, raziocinante ma anche volitivo, il mafioso riafferma quello che tutti i conservatori vogliono, la legittimazione dell’autorità senza passare attraverso canali democratici e legali, l’affermazione di un carisma imperniato sulla mediazione che tiene la violenza solo come ultima ratio. Si tratta ovviamente di un’ideologia che poco dice sulla realtà dei comportamenti mafiosi, ma molto dice dei successi della mafia nell’opinione pubblica. Il Padrino di Puzo e Coppola è un personaggio di grande fascino perché ripropone tutta questa mitologia, tutti i modelli tradizionalisti che hanno agevolato la comunicazione tra l’alto e il basso, tra il salotto buono e la piazza della borgata, tra i palazzi e il fango delle strade. Per parte nostra, dobbiamo sfuggire a queste trappole svelando il carattere mistificante di questi discorsi.
Che rapporto c’è fra le diverse strategie messe in atto dai mafiosi e le “congiunture storiche”? Come inquadrare e analizzare le relazioni tra capacità strategica dei mafiosi e condizioni di contesto?
Nei suoi centosessant’anni di storia, dal 1861 a oggi, la mafia ha rappresentato nelle zone di sua influenza un potere più che altro sotterraneo: conficcato nella profondità delle relazioni sociali, dell’economia, della politica. Ha avuto anche natura complementare rispetto al potere “ufficiale” dello stato, dell’impresa, e della proprietà fondiaria. E i membri dell’establishment (siciliano e nazionale) hanno il più delle volte assunto un atteggiamento negazionista, che li ha portati a dire: la mafia non esiste o, se pure esiste, non rappresenta un problema per la gente “per bene”. Ci sono state però anche stagioni storiche conflittuali, nel corso delle quali il potere statale ha considerato quello mafioso non complementare ma antagonistico, facendone un problema politico (cioè anche simbolico) di prima grandezza. Ho molto ragionato, nel mio libro, sulla stagione del fascismo. E anche delle diverse fasi in cui negli Stati Uniti le organizzazioni gangsteristiche e mafiose hanno dovuto far fronte a ondate repressive anche a livello federale. Per tornare all’Italia, nel 1979-93 la mafia-Cosa nostra si è clamorosamente palesata con una sequenza di delitti di sangue e di attentati terroristici. Il suo potere è salito alla superficie. Ha duramente colpito le istituzioni, sino a minacciarne il funzionamento. è stata però anche colpita, e molto più duramente che in ogni altro momento del passato. Quest’alternanza storica tra fasi caratterizzate da spirito collaborativo e da attacco violento (sul fronte mafioso) e fasi di tolleranza e repressione (sul fronte statale) ha consentito all’opinione pubblica, e consente a noi che ricostruiamo fatti anche remoti, di vedere la mafia. Senza tenerne conto, non se ne può fare storia.
Prendiamo atto dei successi sul piano repressivo seguiti alla stagione stragista. Diverse inchieste giudiziarie continuano però a portare alla luce reti di complicità e accordi collusivi con soggetti della sfera legale dell’economia, della politica e delle istituzioni. Le strategie di contrasto sono molto efficaci nei confronti della struttura organizzativa di Cosa nostra, ma sembrano esserlo molto meno rispetto alle “relazioni esterne”. Come spiegare questo paradosso? Non pensa che tra gli stessi studiosi sia stata a lungo prevalente la tendenza ad assegnare maggiore importanza alla dimensione organizzativa interna dei gruppi mafiosi rispetto ai legami esterni?
Il paradosso si spiega eccome. Molti investigatori già nell’Ottocento erano consapevoli del carattere iniziatico e segreto dell’organizzazione. Però solo con la legge Rognoni-La Torre l’appartenenza a quel tipo di organizzazione venne definita in sé illecita, e solo a partire dal maxiprocesso palermitano del 1986-87 – grazie all’opera pionieristica del pool antimafia guidato da Falcone – il discorso trionfò in tribunale. (Grazie anche alle rivelazioni di Buscetta). Però è stato ed è molto più difficile comprovare in sede penale l’appartenenza mafiosa di un singolo che appare collocato in luoghi meno centrali del sistema delle relazioni mafiose. Facciamo qualche esempio: di chi paga la tangente, di chi fa lavori di consulenza per imprese giudicate (più o meno) colluse, di chi ricorre a procacciatori di voti che a loro volta ricorrono al sostegno mafioso. Si tratta di responsabilità che molto spesso sarebbero più facili da definirsi in chiave politica o morale.
Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra sono le “mafie storiche” italiane. Stando alle evidenze delle ricerche svolte nel campo della storia e delle scienze sociali, fino a che punto è sostenibile questa equiparazione? Quali i tratti comuni e quali le divergenze?
Mi sembra si possa ragionare di un modello comune più che altro per la mafia siciliana (Cosa nostra) e per quella calabrese (la ‘ndrangheta). I gruppi camorristici di Napoli e di altre zone della Campania non rispondono a un unico modello, e di certo non a quello mafioso doc. Ma, come ho spiegato, l’uso del plurale mafie, per quanto a rischio di una certa genericità, può considerarsi giustificato. Per le mafie italiane e anche per altre.
Lei individua nel 1963, in concomitanza alla strage di Ciaculli, un importante punto di rottura del lungo “armistizio” tra stato e mafia e l’inizio di un meccanismo di sfida e risposta, cui associa l’introduzione del termine antimafia nel linguaggio pubblico italiano, anche in riferimento alla neonata Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafioso. Perché sarebbe corretto parlare di “antimafia” solo a partire da questa data?
Perché il termine antimafia implica a mio parere l’idea di un’azione convergente dall’alto e dal basso, che si è venuta a formare (e in parte a realizzare) solo in questo periodo secondo-novecentesco, e che si è andata via via chiarificando col procedere degli anni. Quando dico “dall’alto” intendo riferirmi alle istituzioni statali, a quelle “normali” e a quelle (come la Commissione antimafia) “speciali”, che sono state costituite cioè nel corso della lotta drammatica impegnatasi in questa fase della storia italiana. Quando dico “dal basso” intendo riferirmi a partiti ed associazioni che spesso si dicono espressione della “società civile”, ma che a mio parere hanno pur sempre carattere politico. Sia i soggetti del primo che (a maggior ragione) del secondo tipo si muovono in base a motivazioni ideali, a valori che vengono in quanto tali esplicitamente espressi. La questione della mafia e dell’antimafia viene da loro proposta come centrale nella vita pubblica. Produce grandi passioni e, direbbe Sciascia, carriere e identità politiche.
Nell’ultima parte del libro, l’attenzione è rivolta all’uso della memoria dell’antimafia, problematizzando il “senso da attribuirle” e soprattutto interrogandosi su “chi ha titolo di rivendicarla”. Qual è secondo lei il ruolo della storiografia e delle scienze sociali nel processo di continua costruzione, conservazione e rielaborazione della memoria?
Ho scritto in effetti che in molti paventano una cancellazione della memoria, ma il vero rischio è che non si riesca ad attribuire un senso alle battaglie che sono state combattute. La privatizzazione della memoria di certi caduti da parte di certi gruppi mi sembra aumentare queste incertezze. Paradosso vuole che l’antimafia militante, ovvero l’insieme delle persone e dei gruppi (d’opinione e istituzionali) che tutt’oggi si definiscono in questa maniera, dia il più delle volte una risposta negativa alla domanda: la battaglia è stata vinta? Loro diranno che non è stata vinta la battaglia per una politica e un’economia pulita, libere da degenerazioni di tipo mafioso. In effetti. Difficile dire però quando e se mai ci arriveremo. Sta di fatto che è stata conseguita una grande vittoria nella lotta intrapresa contro Cosa nostra siciliana (e anche americana) a partire dal 1993, o meglio dal 1986-87. Io trovo sconfortante che questa parte migliore d’Italia così ostinatamente si rifiuti di ammettere che qualcosa di positivo possa essere accaduto nel paese, e in particolare nella sua parte meridionale.
Ma non pensa che i molti studi “scientifici” sulle mafie possano fare su questi punti chiarezza? E, in generale, qual è la loro rilevanza, e per chi? Hanno un impatto sul piano politico e, più nello specifico, su quello della definizione degli interventi e delle politiche antimafia?
Io spero di sì. In questo caso gli studiosi dovrebbero però meglio delimitare l’oggetto, e magari raffreddarlo: chiarendo quello che dal punto di vista delle discipline (non solo da quello del diritto penale) possa essere considerato mafia e cosa no, evitando di ridurre ogni pur grave patologia sociale a un indistinto male metafisico, frenando le passioni forcaiole di cui sembra alimentarsi il paese, evitando di accreditare la mitologia della mafia sempre invitta e dunque invincibile. Ma realisticamente credo di no. Non penso che una questione così importante riguardante l’identità collettiva degli italiani possa essere risolta dalle scienze sociali. Bisognerà che le soluzioni a questi problemi dell’etica e della politica vengano dall’etica e dalla politica medesime.
larco@unito.it
Larco è il Laboratorio di analisi e ricerca sulla criminalità organizzata dell’Università di Torino


