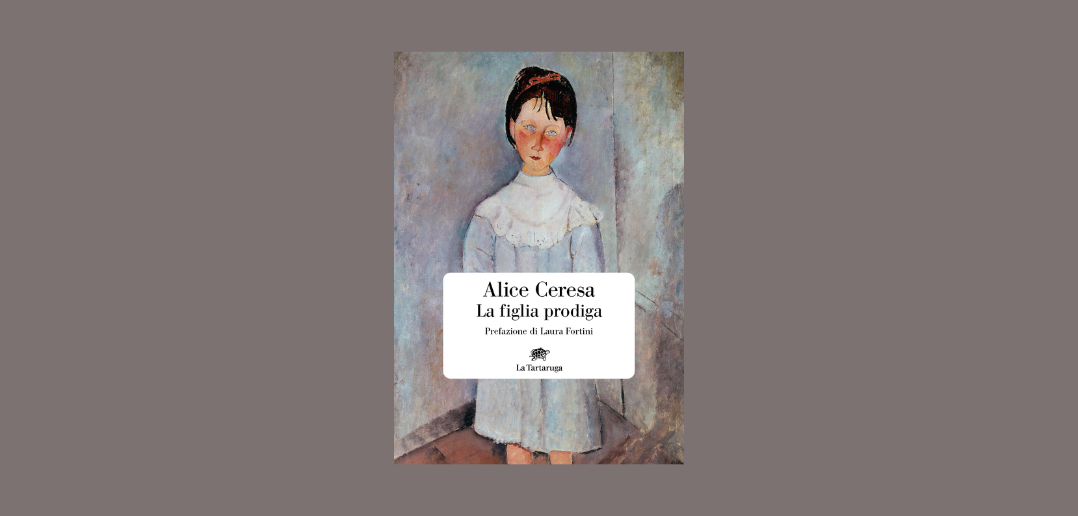di Virginia Giustetto
C’è, all’origine di tutto, la famiglia. Una famiglia novecentesca composta da un padre, da una madre e da due figlie: la maggiore e la minore. Il padre, in questo elenco, va nominato per primo, perché si tratta, incontrovertibilmente, di un nucleo patriarcale
Tutta l’opera di Alice Ceresa, raffinata scrittrice svizzera nata a Basilea nel 1923 e morta a Roma nel 2001, è una messa a fuoco etologica dell’istituzione familiare così composta: un’implacabile descrizione dei ruoli a cui, fin dall’infanzia, si è instradati; il tentativo, non esente da sofferenza, di illuminarne le storture, di raccontarne analiticamente l’orrore e i risvolti perversi, al punto da corroderla e svuotarla di senso, servendosi innanzitutto del linguaggio.
Dell’ultimo romanzo pubblicato, Bambine (uscito nel 1990 per Einaudi, tornato ora in libreria per Casagrande) Toti Scialoja scrisse: “ne ho ricevuto un’emozione violentissima, travolgente. […] Il tuo libro mi ha spaccato in due”. La ripubblicazione, curata da Tatiana Crivelli e arricchita da un’intervista all’autrice e da due lettere, propone il testo nelle sue vesti originali: la reintroduzione di alcuni a capo nel capitolo incipitario e in quello conclusivo conferisce alla cornice testuale la forma di una prosa versificata, come suggerisce Crivelli nella preziosa Postfazione, in cui si ripercorre la vicenda editoriale dell’opera. Fin dall’incipit, insieme incantato e spoglio: “Occorre disegnare / per incominciare / una piccola città”.
Il romanzo si apre dunque sulla descrizione di un disegno infantile, che ritrae una fila di case, qualche negozio, una chiesa e un municipio. Si aggiungono, sovrapposte, alcune figure umane, in particolare “un piccolo gruppo rappresentante un esemplare ed essenziale per quanto minuscolo nucleo familiare”, più avanti ribattezzato, con l’esattezza clinica di cui Ceresa è maestra, un “involucro isolante”: una madre, un padre, le due bambine del titolo.
A narrazione avviata, come una scenografia teatrale statica che tutt’a un tratto si anima dopo l’apertura del sipario, il disegno prende vita intorno alle sagome delle bambine, di cui si ripercorrono, nella forma di brevi ritratti, passaggi salienti dell’infanzia e dell’adolescenza da figlie femmine: atteggiamenti e condotte, aspettative e devianze, sotto lo sguardo giudicante e gelido della figura paterna (“Quest’uomo guarda ogni cosa soltanto per soppesarla ed eventualmente biasimarla”) e quello “distraibile e sollecitabile” – alle volte frivolo, molto più spesso disperato – della madre.
La scelta di affidarsi esplicitamente al linguaggio del disegno non è casuale: per raccontare l’infanzia, quella che la scrittrice considera “l’esperienza più oscura di noi viventi”, a Ceresa non interessano né le sovrainterpretazioni del senno di poi né, tantomeno, le memorie personali. Desidera, al contrario, “una descrittività pura e semplice”, bidimensionale. Così facendo intende raccontare una famiglia specifica e al tempo stesso una famiglia come tante: una condizione comune, che pur trovando precise corrispondenze nella sua esperienza biografica, è rimarchevole per il fatto di essere condivisa – se non convenzionale, quasi normata.
Si comprende allora la scelta di trasformare la voce narrante in prima persona – presente in alcune versioni precedenti del romanzo, conservate presso l’Archivio svizzero di letteratura di Berna – nella voce impersonale adottata nella redazione definitiva. Al tempo stesso, la predilezione per l’immagine si spiega alla luce di una convinzione costante: per Ceresa il linguaggio visivo, e più nello specifico la pittura, costituisce un modello per il rinnovamento della forma narrativa.
Un riferimento imprescindibile è Paul Klee (a voler trovare delle corrispondenze: la piccola città descritta nella prima pagina di Bambine non assomiglia forse alla Deutsche Stadt del 1928?), ma la scrittrice è anche fortemente connessa alle esperienze informali di Jean Fautrier e Jean Dubuffet, o al lavoro di Eugenio Carmi in Italia. Artisti diversi, accomunati da un incessante spirito di esplorazione, capaci di mettere in discussione il linguaggio precostituito, sottoponendolo a una disamina che investe sia la forma sia la materia.
Come ha rilevato Patrizia Zappa Mulas, Ceresa ha ricercato con ostinazione il modo più adeguato – linguistico, identitario prima ancora che letterario – per formulare la nuova coscienza della donna: “Alice Ceresa riconosce alla letteratura un compito immenso, forse sovrumano, che è quello di ripensare le radici (sofferenti) dell’essere sessualmente distinto”.
Lo ha fatto a partire dal suo esordio, La figlia prodiga (ed. orig. 1967, ora La Tartaruga, 2023), (anti)romanzo che le valse il premio Viareggio Opera Prima, apprezzato tra gli altri da Goffredo Parise, Giorgio Manganelli, Maria Corti, Franco Fortini e Italo Calvino. Un testo concettuale ed eversivo, a metà tra il poema in prosa e il trattato filosofico, segnato dalle avanguardie: Ceresa frequentò il Gruppo 63, stazionando però ai margini, posizione a lei prediletta per osservare il mondo e per lasciare un segno.
La figlia prodiga, riscrittura della parabola evangelica dalla prospettiva femminile, probabilmente ispirata alla vicenda biografica di Annemarie Schwarzenbach, mette in scena la condizione dell’essere femminile, costretto tra “la personalità privata di una donna moderna e la tradizionalità di una società edificata interamente al contrario di questa sua presa di coscienza”.
Ripubblicato nel 2023 con prefazione di Laura Fortini, il libro fu il biglietto da visita con cui Ceresa, sorprendente e per molti versi contestataria, si presentò al mondo letterario. In tanti, riconoscendone il valore, aspettarono impazienti la seconda prova. Giorgio Manganelli osservò: “Mai scrittore al mondo riuscì a frustrare una impaziente attesa in modo più meticoloso. Passarono gli anni, ed ogni tanto giungeva una voce: la Ceresa lavora al secondo libro”.
Ma la scrittrice scomparve, per oltre un decennio. Tornò nel 1979 con un racconto lungo, di straordinaria potenza, pubblicato su “Nuovi Argomenti” “e poi raccolto in volume da et al./Edizioni nel 2013, ripubblicato da La Tartaruga nel 2022: La morte del padre. Testo scritto di getto a ridosso della morte del genitore, è legato a doppio filo con Bambine: vi si analizzano le modalità attraverso cui la famiglia assimila la scomparsa del padre padrone, che fissa per sempre – anche con la sua assenza, ingombrante presenza – i ruoli di chi rimane.
Per Ceresa un ruolo “non è mai una cosa allegra: soffoca o ammazza la più felice e totale disponibilità umana”. La figura paterna, nelle sue vesti di patriarca, diviene allora una casa “di muri e di pietra”, che gradualmente frana e si sgretola. Il decomponimento fisico è, al contempo, il venir meno, luttuoso e insieme liberatorio, del nucleo familiare.
Avversa alle pose, intollerante al precostituito, la perseveranza con cui Ceresa ha stravolto, plasmato e soprattutto creduto nelle possibilità demiurgiche del linguaggio – si veda il Piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile, Nottetempo, 2007, ed. ampl. 2020) – si spiega anche in virtù dello sradicamento linguistico, e dunque identitario, che contraddistinse la sua vicenda biografica. “Ho il profondo e ottuso convincimento”, affermò nel 1994, “che le appartenenze al proprio paese siano di natura essenzialmente linguistica. A me è capitato di nascere già emigrata. Suppongo di essere incappata in un problema di identità”.
Questo non le ha impedito, proprio come la minore delle sue Bambine, di procedere nella vita “a passo comodo e testa al vento”.
V. Giustetto è dottoressa di ricerca in lingua e letteratura italiane
virginia.giustetto92@gmail.com
I libri di Alice Ceresa
Bambine, ed. orig. 1990, a cura di Tatiana Crivelli, pp. 142, € 20, Casagrande, Bellinzona (Svizzera) 2025
La figlia prodiga, ed. orig. 1967, La Tartaruga, 2023
La morte del padre, ed. orig. 1979, con Ritratto di Alice di Patrizia Zappa Mulas, La Tartaruga, 2022