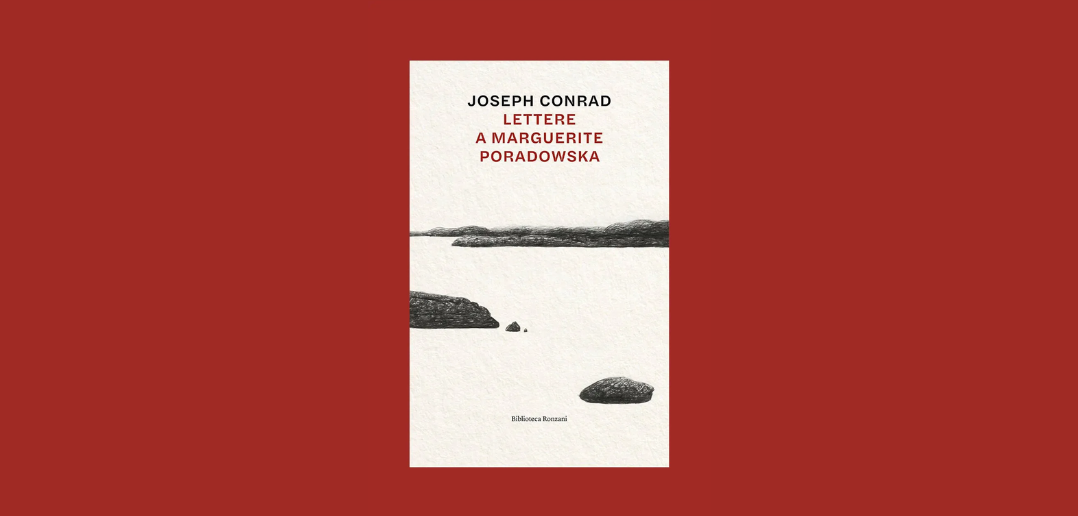Joseph Conrad
LETTERE A MARGUERITE PORADOWSKA
a cura di Giuseppe Mendicino,
ed. orig. 1966, trad. dal francese di Anna Lina Molteni,
pp. 299, € 22,
Ronzani, Dueville VI 2025
Il dono di una zia affascinante
di Giuseppe Sertoli
“Voi avete dato alla mia vita un nuovo interesse, un nuovo affetto; ve ne sono molto riconoscente. Riconoscente per tutta la dolcezza, per tutto l’amaro di questo regalo senza prezzo. In questo momento guardo due strade aperte nello spesso e caotico groviglio di erbe insalubri. Dove vanno? Voi seguite l’una, io l’altra. Divergono”. La persona a cui, nel giugno del 1890, in viaggio verso l’Africa, Conrad scriveva queste parole era Marguerite Poradowska (1848-1937), la “zia” che grazie alle sue conoscenze politiche era riuscita – come ricorderà qualunque lettore di Cuore di tenebra – a fargli avere il comando di un battello fluviale in Congo al servizio di Leopoldo II. Nata in Belgio da genitori francesi e appartenente alla buona società di Bruxelles, Marguerite Gachet aveva sposato un lontano cugino di Conrad (Alexander Poradowski), espatriato in Belgio a seguito della fallita insurrezione antirussa del 1863, e dopo il matrimonio era vissuta una decina d’anni in Galizia (allora parte dell’impero austro-ungarico), imparando il polacco e traducendo in francese racconti di scrittori polacchi. Rientrata in patria per ragioni di salute, aveva avviato una fortunata carriera letteraria come autrice di romanzi di ambientazione polacca. Rimasta vedova all’inizio del 1890, due soli giorni dopo che Conrad aveva fatto visita allo “zio” Alexander, Marguerite divenne la principale destinataria delle numerose lettere che, fra il 1890 e il 1895, l’acquisito nipote scrisse ai suoi pochi parenti e conoscenti, prima dal Congo, poi dai vari porti dove approdavano le navi su cui di volta in volta era imbarcato. Lettere particolarmente preziose perché gettano luce su un periodo cruciale della vita di Conrad, quello coincidente con la sua trasformazione – tanto inattesa da sorprendere lui stesso – da uomo di mare in scrittore (all’autunno del 1889 risalgono le prime pagine del suo primo romanzo, La follia di Almayer, pubblicato nel 1895). Rese note nell’originale francese solo nel 1966 e mai tradotte in italiano, quelle lettere escono ora nell’ottima versione di Annalisa Molteni, in un volume curato con passione e precisione da Giuseppe Mendicino (recente autore di Conrad: una vita senza confini, Laterza, 2024), insieme a tre lettere di Poradowska – una delle quali fino a oggi sconosciuta – e con l’aggiunta di un efficace ritratto della stessa Marguerite firmato dalla traduttrice. Due strade, quelle del “devotissimo e affezionato nipote” e della “piccola cara zia”, che per cinque anni procedettero, se non parallele, vicine l’una all’altra. Che cosa le aveva fatte incontrare e le tenne, almeno per un po’, vicine? Per quanto riguarda Conrad (è la sua sola voce che ascoltiamo, perché le lettere di Poradowska, con le tre eccezioni di cui si è detto, sono andate perdute o soppresse), non c’è dubbio che egli trovò in lei, da un lato, una figura femminile su cui riversare un’affettività che dalla morte della madre, quando aveva appena sette anni, si era portata dentro inappagata e compressa, e dall’altro un’interlocutrice con la quale poteva parlare di cose – non solo ricordi e speranze, progetti e delusioni, ma considerazioni “filosofiche” sul senso della vita, la solitudine, il sacrificio, il dovere – che certo non potevano essere argomento di conversazione con marinai e addetti portuali. Di qui l’idealizzazione romantica, vagamente adolescenziale, che Conrad fa subire alla “affascinante” figura della “zia” (di nove anni maggiore di lui e ancora molto bella): “Quando vi avvicinerete a me non scendete dal piedistallo dove vi ho posta”. Ora, che una simile idealizzazione nascondesse (o rischiasse di trasformarsi in) qualcosa di diverso, poteva sospettarlo solo il lontano e ignaro zio-tutore Tadeusz Bobrowski, il quale, giudicando Marguerite una bas-bleu, esortava il nipote a porre fine a un “gioco” che poteva diventare pericoloso. In realtà, non c’era alcun pericolo. Nelle lettere di Conrad, al netto di espressioni che rientrano nella retorica sentimentale del tempo (“Vi bacio le mani”, “Tutto Vostro” eccetera), non si trova alcun indizio che confermi quella “passione amorosa” che vi legge Mendicino. L’investimento affettivo-idealizzante proiettato sulla figura della “zia” escludeva (a meno di voler chiamare in causa l’Edipo…) qualsiasi pulsione erotica e, a fortiori, qualunque fantasia matrimoniale. Se nel 1895 la corrispondenza s’interruppe – o piuttosto si diradò: ci sono prove che non cessò mai del tutto – non è, come qualcuno ha ipotizzato, perché Conrad si sarebbe proposto a Marguerite ottenendone un rifiuto, ma per qualche altra ragione che non conosciamo. L’idealizzazione affettiva con cui Conrad aveva investito la figura della “zia” non poteva non estendersi alla sua produzione letteraria. Egli ne legge e rilegge i romanzi dichiarandosi ogni volta “affascinato” e arrivando a paragonarli a quelli di Flaubert per la “meravigliosa” capacità di osservazione e la tersa “semplicità” dello stile. Stupiti di fronte a simili giudizi, i critici li hanno per lo più liquidati attribuendoli, quando non a mero accecamento sentimentale, al fatto che nelle vicende e nei personaggi di quei romanzi Conrad ritrovasse la Polonia della propria infanzia. Chi però si è preso la briga di rileggerli, ne ha scoperto non poche tracce nelle opere di Conrad, e non solo nelle prime. Fanno quindi bene Mendicino e Molteni a invitarci a riconsiderare l’opera di una scrittrice che forse non merita di essere ricordata solo come la destinataria di un pacco di lettere dell’autore di Lord Jim. Lettere, d’altra parte, nelle quali Conrad tanto è pronto a commentare ciò che scriveva la “zia” quanto è restio a parlare di ciò che stava scrivendo lui. Solo nel gennaio del 1894, più di tre anni dopo l’avvio della corrispondenza, fa menzione della “storia di Almayer” – iniziata ben quattro anni prima – promettendole di fargliela leggere “quando l’avrò finita”. La finirà tre mesi dopo, e glielo annuncerà con parole entrate in ogni biografia conradiana: “Mia cara Zia, ho il dolore di parteciparvi la morte di M. Kaspar Almayer, che ha avuto luogo questa mattina alle ore 3. Finito! … Da quando mi sono svegliato stamane mi sembra di aver sepolto una parte di me nelle pagine che sono davanti ai miei occhi. E tuttavia sono felice – un po’”. Che però Conrad non solo si sentisse un parvenu rispetto a una scrittrice premiata dall’Académie française, donde la riluttanza a rivelarle che anche lui aveva cominciato a scrivere, ma considerasse il romanzo appena ultimato non più che “un episodio senza conseguenze nella mia vita”, dimostra quanto poco – a quel tempo – egli vedesse nello “sfregare della penna” una risorsa per il futuro. Solo dopo l’accettazione del romanzo da parte dell’editore, rassicurato dal consenso dei suoi primi lettori-critici, Conrad vincerà la propria ritrosia e non nasconderà alla “zia” di aver messo in cantiere un secondo romanzo, tenendola anzi aggiornata – come non aveva fatto in precedenza – sulle difficoltà che il progetto incontrava e sui dubbi che esse alimentavano. Ma a quel punto il posto di interlocutore privilegiato che era stato di Poradowska l’aveva ormai occupato Edward Garnett, il principale sponsor di Conrad sulla scena letteraria londinese, e le strade di “zia” e nipote non potevano che allontanarsi. La corrispondenza riprese con una certa regolarità nel 1900 per proseguire nei vent’anni successivi (l’ultima lettera è del dicembre 1920), sempre affettuosa ma anche sempre più sporadica e laconica. Marito e padre, Conrad era ormai uno scrittore a tempo pieno, in fitto scambio epistolare con altri scrittori, editori e critici, sicché dell’ascolto della “tante Margot” non aveva più bisogno e poteva rivolgersi a lei chiamandola semplicemente Marguerite o addirittura “Cara amica”.
G. Sertoli ha insegnato letteratura inglese all’Università di Genova
giuseppe.sertoli@emeriti.unige.it