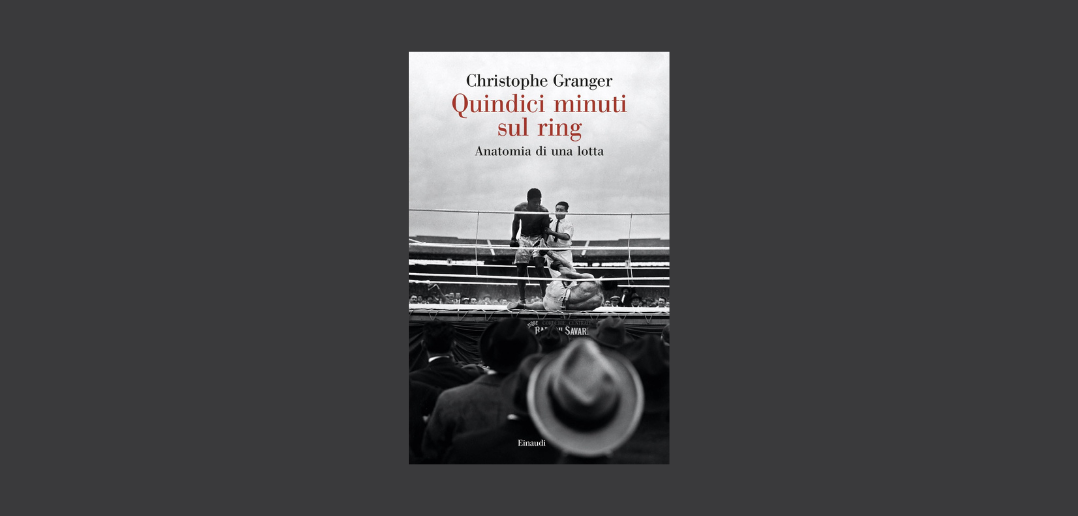Christophe Granger
Quindici minuti sul ring. Anatomia di una lotta
pp. XXX-386, €26,
Einaudi, Torino 2025
I codici profondi dell’azione
di Lorenzo Bartalesi
Almeno a partire dagli Annales di Quinto Fabio Pittore (III secolo a.C.), uno dei compiti principali dello storico è quello di ricostruire il passato attraverso la narrazione di imprese e azioni, sia singole che collettive. Ancora Benedetto Croce, in Teoria e storia della storiografia (1916), intendeva la ricerca storica come historia rerum gestarum e la storia come res gestae. Il particolare tipo di fatti storici oggetto di questa antica e nobile tradizione storiografica sono le azioni e, nello specifico, quelle azioni che hanno impresso una svolta al corso degli eventi. Ma che cos’è un’azione? Quali sono i suoi confini? Cosa significa comprenderla nella sua natura di fatto storico? Se l’unità minima della narrazione storica sono le azioni, rispondere a questi interrogativi diventa di grande importanza per il lavoro storiografico.
Le azioni che compongono la trama degli eventi si presentano ai nostri occhi come già compiute, siamo noi a definirne a posteriori inizio e fine e la spiegazione che ne diamo è tradizionalmente nell’ordine di una descrizione di che cosa è accaduto, delle cause e motivazioni di cui gli atti così circoscritti sono l’esito. Ma come è fatta nel suo svolgimento? Quanto e come è determinata da ciò che la precede? Perché, in un dato giorno, uno o più individui hanno compiuto quella determinata azione in quel determinato modo e non in un altro? Tali questioni sono al cuore dell’originale e a tratti spiazzante volume dello storico e sociologo Christophe Granger, Quindici minuti sul ring. Anatomia di una lotta, che intende condurre il lettore nel cuore stesso di un’azione, rendendo osservabile che cosa sia agire, dandovi accesso nel momento stesso in cui si svolge. Tale ambizione teorica, che implica una riformulazione della categoria stessa di “azione” e, più in generale, l’annosa questione filosofica sul perché agiamo in un determinato modo, viene portata avanti da Granger attraverso la ricostruzione ravvicinata di un’unica azione, circoscritta e intellegibile, facendone gradualmente emergere gli elementi compositivi come in un’analisi al microscopio. “Solo la descrizione nel dettaglio e nella situazione”, scrive Granger, “permette di afferrare la logica specifica di ciò che le persone fanno effettivamente”. Diversamente da quanto ci saremmo potuti attendere, tuttavia, la posta in gioco del volume non è tanto la descrizione di un fatto storico in ottica micrologica – sul modello della corrente storiografica inaugurata da Carlo Ginzburg –, quanto una ricerca filosofica dichiaratamente ispirata all’inquieto interrogare wittgensteiniano e rivolta a svelare come fanno le persone ad agire quando arriva il momento di agire. Nel fare ciò, mobilita tutta una serie di strumenti concettuali presi in prestito da diverse discipline e tradizioni filosofiche come la riflessione antropologica sull’azione di Jean Bazin e Gregory Bateson, la nozione di habitus di Pierre Bourdieu e quella di frame di Erving Goffman.
L’episodio selezionato è un incontro di boxe tra il francese Georges Carpentier, campione del mondo dei pesi mediomassimi, e lo sfidante franco-senegalese Battling Siki, svoltosi nel quartiere della Vache-Noire di Montrouge a Parigi, il 24 settembre 1922, e immortalato da un celebre filmato che diviene la fonte storica utilizzata. L’azione è qui solo apparentemente delimitata dal gong iniziale e dal ko che pone termine alla competizione. Come in un susseguirsi di piani cinematografici, l’analisi fa emergere l’intreccio di temporalità e spazialità diverse implicate nell’interazione tra i due pugili sul ring. La durata – i quindici minuti del titolo – viene dilata e compressa in un movimento continuo tra le profondità temporali dei grandi processi socioculturali (il livello dell’istituzione), i gesti fulminei dei pugili in cui tali processi si attualizzano (l’interazione) e gli automatismi dei meccanismi mentali attivati da un uppercut di Carpentier o da uno swing di sinistro di Siki (la cognizione). L’azione viene così scomposta in una serie concatenata di gesti minimi il cui significato è gradualmente rischiarato dall’analisi dei meccanismi sociali di razzializzazione in gioco nello stile boxistico dei due contendenti – il pugilato “scientifico” ed elegante del bianco contrapposto alla boxe rozza e violenta del nero. Tali processi sociali non solo configurano simbolicamente l’incontro ma, ben più in profondità, strutturano gli stessi abiti corporei dei due pugili. Sul ring, nella diversa grammatica gestuale adottata, si attualizza il passato di entrambi i contendenti e della boxe stessa, va in scena un’intera epoca con le sue contraddizioni e nefaste ideologie. Una forma di vita si realizza in un combattimento di boxe, allo storico il compito di renderla osservabile e comprensibile. In tal senso, la scelta di utilizzare un filmato cinematografico non è espressione di un’ingenua fiducia di Granger nel documento visivo come accesso neutro al passato. Il film è lo strumento mediante il quale lo storico francese intende emanciparsi dalla dimensione testuale della narrazione storica che privilegia un accesso all’azione passata attraverso ciò che è stato giudicato degno di essere detto da coloro che ne erano contemporanei. Facendo del film oggetto e metodo della ricerca storica, l’autore sembra voler recuperare la carica conoscitiva attribuita al cinema dai contemporanei di Carpentier e Siki. La rappresentazione filmica della realtà, scriveva Walter Benjamin nel 1936, penetra in profondità nel tessuto degli eventi come un chirurgo nel corpo del paziente, restituendoci “un’immagine estremamente frammentata, le cui parti si ricompongono secondo una legge nuova”. Questo è proprio ciò che si prefigge il volume di Granger. Il filmato è per lo storico francese come un bisturi, uno strumento per entrare nel cuore dell’azione al fine di “scomporre un gesto, cogliere una posizione, comporre una traiettoria e paragonare gli elementi fra loro, osservare uno sfondo, notare la regolarità di un movimento, la sua intensità, la reazione di un pugile a ciò che l’altro ha appena fatto, e così via”. Nelle intenzioni dell’autore, l’esito finale di questa continua opera di frammentazione e ricomposizione non sarà una descrizione dell’incontro di boxe secondo i canoni tradizionali della historia rerum gestarum ma un lento e paziente apprendistato del lettore ai codici profondi dell’azione. Acquisita la familiarità con tutto ciò che l’azione contiene e la fa essere quella che è, i quindici minuti sul ring, riprodotti frammento per frammento nella parte conclusiva del volume, si dipanano davanti ai nostri occhi sotto una nuova luce, quella della comprensione. Al lettore il compito di giudicare il successo dell’impresa.
lorenzo.bartalesi@sns.it
L. Bartalesi insegna estetica alla Scuola Normale di Pisa
Il mondo alle corde
di Dario Bassani
Se il mondo è difficile da capire, gli sport da combattimento sono invece una felice, facile eccezione. Funziona così: due persone si fronteggiano in una porzione di spazio, ciascuna con l’obiettivo di prevalere sull’altra in virtù della propria forza, tecnica, resistenza. Una volta esaurito il tempo a disposizione o il vigore di chi lotta, distinguere chi ha vinto da chi ha perso di solito è molto semplice. Nel pugilato il knock out è l’occasione in cui il riconoscimento è più chiaro: la parte sconfitta è quella che non riesce più a rialzarsi dopo essere stata atterrata.
È quello che vedono le quarantamila persone assiepate attorno al ring dello stadio Buffalo di Parigi il 24 settembre 1922. Il campione del mondo dei pesi mediomassimi Georges Carpentier crolla al tappeto “visibilmente malmesso, fa una smorfia di dolore e rotola sulla schiena da una parte all’altra tenendosi la gamba”. Incombe su di lui l’avversario, l’underdog senegalese Battling Siki, che dopo aver portato a termine il colpo decisivo “gli urla qualcosa d’indistinto che si perde nel frastuono e nel finale inatteso”: il pugile nero ha sconfitto il bianco e ha rovesciato le aspettative del pubblico. Ma è tutto qui?
Quindici minuti sul ring. Anatomia di una lotta dello storico e sociologo Cristophe Granger spazzola contropelo il breve arco di tempo storico che dà il titolo al libro con un obiettivo ambizioso. Alla domanda dello storico su che cosa sia accaduto e a quella del sociologo sulle condizioni dell’evento, Granger aggiunge una questione filosofica che fa venire le traveggole: da dove sorgono le azioni che compiamo? “Dove troviamo la possibilità di agire”?
Granger sostiene che ci siano due grandi teorie alle quali fare riferimento per rispondere a questo interrogativo enorme: “una affonda nelle scienze della mente e l’altra in quelle del sociale. E fra loro si parlano poco, o male”. Insomma, ci sono due ipotesi da testare: in quella sociologica, la risposta è fuori da noi, ed è la società a dettare quel che facciamo; in quella cognitivista, si trova dentro di noi, e le nostre decisioni coscienti sono le protagoniste.
Il terreno di prova di queste congetture è un match di pugilato di cui l’autore propone un’etnografia in differita. L’incontro tra Carpentier e Siki era “stato organizzato per essere filmato”: a inizio Novecento le cineprese erano le mediatrici fondamentali del rapporto tra pugilato e industria dell’intrattenimento. Grazie ai filmati d’archivio, Granger analizza fotogramma dopo fotogramma tutto il combattimento.
Una microstoria di taglia tanto minuta forse non è mai stata praticata. Un classico del genere come Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg esaminava la singolarità della vita di Menocchio – uno sconosciuto ma eccezionale mugnaio del Cinquecento – le cui testimonianze a processo smentivano la tesi che il pensiero delle classi subalterne fosse solo un derivato della cultura ufficiale, e ne presentavano la creatività sorprendente, l’agency. Granger invece mobilita una quantità di metodi che fanno appello “alla storia, all’etnografia, alla sociologia, alla conversation analysis, alla cinesica, alla filosofia analitica e alle scienze cognitive” per perlustrare quattro round di pugilato e dimostrare che nel loro corso si squaderna la totalità di un passato.
Il setaccio di Granger è composto da tre livelli. Il primo è l’istituzione, ossia la pressione atmosferica del contesto storico, esercitata all’esterno e all’interno del ring. Sono in campo fattori come l’impatto della prima guerra mondiale sui rapporti tra colonie e metropoli in Francia, in virtù del quale il manager di Battling Siki rivendicherà il diritto a combattere del pugile senegalese: anche se non aveva un grande nome era pur sempre un veterano francese, che si era guadagnato una medaglia per aver fatto tuonare i cannoni in nome della République.
Il secondo è l’interazione, ovvero ciò che accade sul ring. È qui che emergono gli stili pugilistici dei due avversari, cioè i loro habitus. Granger fa suo il concetto di Pierre Bourdieu nella versione munita di guantoni di Loïc Wacquant, allievo del celebre sociologo francese e autore di un importante libro etnografico sulla dimensione sociale della boxe come Anima e corpo. La fabbrica dei pugili nel ghetto nero americano (DeriveApprodi, 2002). Sul ring l’habitus condensa un repertorio di strategie corporee acquisite da due allenamenti profondamente diversi (scientifico quello di Carpentier, istintivo quello di Siki), che vengono messe all’opera con studiata spontaneità: per esempio, lo swing sinistro di Siki, decisivo per la vittoria, non nasce dal nulla, ma anzi è una sorta di autografo pugilistico, un automatismo richiamato secondo necessità.
Lo zoom di Granger finisce nel cranio dei contendenti, cioè nel livello della cognizione, per ricostruire le riflessioni dei due boxeur a partire dalle loro dichiarazioni (“Al terzo round ho capito che probabilmente ce l’avrei fatta”) e dall’analisi dei loro movimenti sul ring. È in questo capitolo che il saggio di Granger risulta meno convincente. Analizzare un filmato d’epoca e alcune dichiarazioni giornalistiche chiamando in causa grandi nomi della filosofia della mente come Ludwig Wittgenstein e G. E. M. Anscombe e concetti complessi come quello di cognizione situata non sembra all’altezza del compito proposto: la confutazione della teoria dell’azione delle scienze cognitive, che cercano nella vita mentale del soggetto il punto archimedico del suo agire nel mondo. Se il passato è una terra straniera, la psiche di chi ci ha vissuto allora è un esopianeta, e le sonde a disposizione di Granger ci trasmettono delle immagini troppo confuse e poco credibili.
Conclusa l’analisi dei tre piani, Granger ci invita a riguardare l’intero combattimento, ora finalmente comprensibile in tutti i suoi strati: il filmato è disponibile su YouTube, ma è anche stampato fotogramma per fotogramma nel libro, come una sorta di flipbook ad andatura orizzontale. Diapositiva dopo diapositiva, ripercorriamo colpo su colpo la lotta dopo averne studiato l’anatomia.
Guardata l’ultima immagine, a chi legge possono sorgere diversi dubbi e uno in particolare: perché Granger ha scelto proprio questo incontro? Che cos’ha di esemplare ai fini della domanda filosofica colossale da cui è partito? L’ultima sezione del libro, chiamata in gergo cinematografico Making of, fornisce una motivazione. Il testo è presentato come un contrattacco allo specialismo accademico, alle strettoie della ricerca. È per questa ragione che ha incrociato materiali e saperi diversi, provenienti dalle più diverse discipline. Granger, insomma, ha voluto “dotarsi di un metodo più realistico per descrivere la vita”. Per fare una cosa solo in apparenza tanto semplice non basta dire che “il 24 settembre 1922, vicino ai bastioni di Parigi, un pugile ha sconfitto un altro pugile” né affidarsi a teorie che pretendono di spiegare tutto ben chiuse nei propri dipartimenti universitari, perché ogni azione mette alle corde il mondo intero.dariobassani95@gmail.com
D. Bassani è responsabile editoriale della rivista multimediale “Lucy sui mondi
La cosa nella sua cosità
di Pietro Grossi
Nel 1950, in una raccolta intitolata in italiano Sentieri interrotti, Martin Heidegger pubblica La cosa. L’intenzione è di cercare di definire cosa rende “cosa” una cosa. La cosa nella sua cosità, insomma, per dirla con le parole del nostro. La cosa che Heidegger prende in esame per questa sua ennesima, ambiziosa, seppur breve impresa è la brocca. In un momento di particolare deriva poetica (pare che gli capitasse, nella seconda parte della sua vita), scrive questo:
Nell’acqua che viene offerta permane la sorgente. Nella sorgente permane la roccia, e in questa il pesante sonnecchiare della terra, che riceve la roccia e la rugiada del cielo. Nell’acqua della sorgente permangono le nozze di cielo e terra. Questo sposalizio permane nel vino, che ci è dato dal frutto della vite, nel quale la forza nutritiva della terra e il sole del cielo si alleano e congiungono. Nell’offerta dell’acqua, nell’offerta del vino permangono ogni volta cielo e terra. L’offerta del versare, però, è l’esser brocca della brocca. Nell’essenza della brocca permangono terra e cielo.
Nelle righe immediatamente successive Heidegger aggiungerà a questa presenza di cielo e terra anche il mortale e il divino, giungendo al cuore di questo breve saggio, la Quadratura, che però qui non tenterò di riassumere o analizzare.
Ciò che più invece mi interessa è l’idea, nelle poche righe riportate qui sopra, che la cosità della cosa sia nel suo agire: per quanto riguarda la brocca, nel suo versare. Per un coltello, devo immaginare, nel suo incidere. La cosa, cioè, è presente nel suo essere azione, e quell’azione porta con sé l’essenza stessa della sua forma, ciò che l’ha concepito: nel caso della brocca, il vuoto contenuto dai suoi bordi, e pronto per essere riempito.
Ecco, è a questo breve saggio che ho ripensato – e che sono andato a riesumare dagli appunti di uno dei due soli esami che a diciannove anni diedi alla Facoltà di Filosofia di Firenze – quando ho letto Anatomia di una lotta. Quindici minuti sul ring di Christophe Granger. Granger opera in modo simile, seppure – va detto – molto meno conciso: per oltre quattrocento pagine osserva un minuscolo brandello di esperienza del genere umano, ponendosi un’immensa domanda. Per non lasciare adito a qualunque dubbio, è con questa domanda che il libro si apre: da dove vengono le nostre azioni e perché agiamo in un determinato modo?
Più vado avanti a leggere, nella vita, più mi rendo conto che ad affascinarmi non sono tanto le vicende raccontate o le tesi a cui si giunge, ma le domande che, palesemente o meno, vengono poste, e il dispiegarsi delle menti nell’affrontarle.
Una sera d’estate di venticinque anni fa, a cena da amici, una ragazza di cui ricordo ancora il largo maglione rosso e i jeans, durante una conversazione disse con grande sicurezza, direi quasi con spocchia, in risposta all’inizio di una conversazione sui nostri condizionamenti: “Io non mi sento condizionata”. Non conoscevo questa ragazza, e non l’avrei mai più vista. Rimasi talmente esterrefatto da divertirmi, come se d’un tratto mi trovassi davanti una rarissima ed esotica creatura. “Come, scusa?”, domandai. “Io non ritengo di essere condizionata in nessun modo dal mondo o dalla società”, aggiunse lei. Ero giovane, avevo forse letto e vissuto ancora troppo poco, e ammetto che non riuscii a trovare parole per ribattere: mi limitai a continuare a sorridere, come un imbecille. Ricordo solo una voce, dentro di me, a cui per cortesia non diedi fiato: “E quei jeans e quel maglione pensi di averli scelti te?”. A quella ragazza vorrei adesso donare il libro di Granger. Se si spera di avere qualche profondo controllo sulle proprie azioni, meglio non leggerlo.
Di quei quindici minuti di vita – in questo caso un incontro di boxe valido per il titolo mondiale dei mediomassimi del 1922, preso in esame soltanto perché filmato e di facile collocazione socio-storica – viene dissezionato ogni istante, dagli eventi e il contesto che l’hanno messo in moto ai processi mentali che hanno presumibilmente guidato ognuno dei colpi capaci di ribaltare il pronostico dell’incontro, facendo vincere lo sfidante Battling Siki, nato in Senegal con il nome di M’Baye Fal sul campione Georges Carpentier.
In una delle prime pagine, Granger ci istruisce su un fatto:
Per cercare di vederci chiaro, possiamo affermare che il modo in cui s’interpreta un’azione si trova definito da due grandi teorie. Una affonda nelle scienze della mente e l’altra in quelle del sociale. E fra loro si parlano poco, o male.
Ecco, dovendolo riassumere in maniera sgraziata, l’arditissimo e mirabile tentativo di Granger nel suo Quindici minuti sul ring è di provare finalmente a far conversare queste due egocentriche teorie. Non leviamo qui al lettore la soddisfazione di scoprire le risposte, o sciupargli anche solo parte del magnifico cammino per scovarle. Devo d’altronde considerare, per l’ennesima volta, quanto insignificante appaia l’individuo ogni volta che gli gettiamo un po’ di vera luce addosso, e però come sia commovente la vastità di cui fa parte.
P. Grossi è scrittore