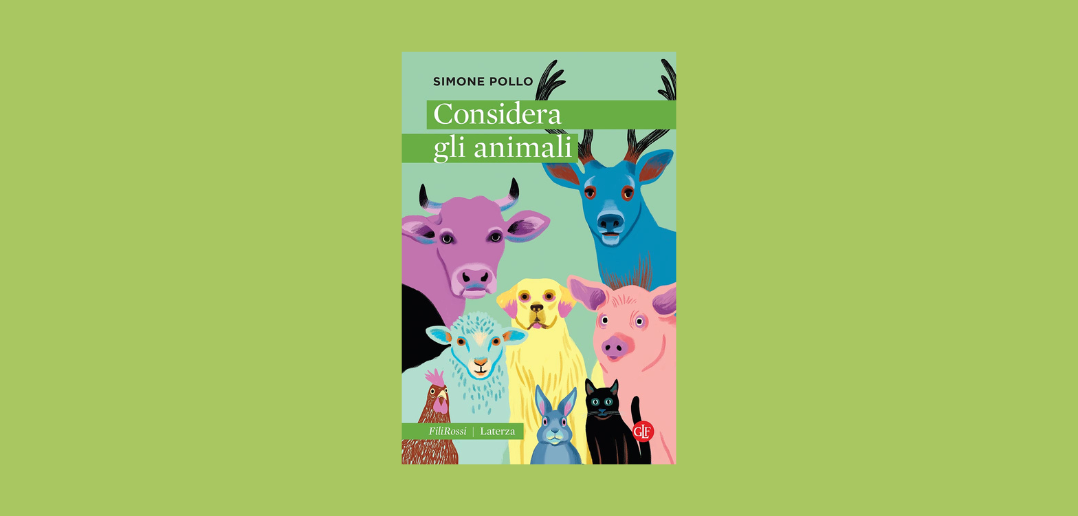Simone Pollo
Considera gli animali
pp. 200, € 18,
Laterza, Roma-Bari 2025
Non più semplici strumenti
di Luca Lo Sapio
Simone Pollo è tra i maggiori studiosi italiani ed europei di etica animale. Dopo Umani e animali: questioni di etica (Carocci, 2016) e Manifesto per un animalismo democratico (Carocci, 2021), Considera gli animali chiude idealmente un trittico. Il volume infatti si pone, per i temi affrontati e le argomentazioni proposte, in continuità con i lavori precedenti, aumentando tuttavia il peso assegnato alla mission divulgativa. Oltre alla chiarezza concettuale e al rigore delle analisi proposte, interviste, glossari, schede, ricette e le illustrazioni di Valeria Petrone contribuiscono, infatti, ad arricchire un itinerario di riflessione che, nonostante la complessità dei temi in gioco, risulta sempre accessibile, ma non per questo incline alle semplificazioni. L’obiettivo è offrire a chi legge strumenti critici, concettuali e pratici per ripensare il proprio rapporto con gli animali. La cifra del volume è proprio questa: non una teoria “sulla carta”, ma una proposta etico-politica radicata nel presente, capace di connettere riflessione filosofica e prassi trasformativa. L’etica, per Pollo, non è infatti un esercizio astratto ma una forma di responsabilità pubblica: una pratica di chiarificazione, orientamento e intervento. E il titolo stesso – Considera gli animali – assume la forma duplice del suggerimento razionale e dell’imperativo etico. È suggerimento, perché gli animali non umani fanno parte delle nostre vite – a vari livelli – e dunque meritano attenzione morale; è imperativo, perché oggi sappiamo che molti animali, pur non essendo agenti morali, sono soggetti senzienti e cognitivamente sofisticati.
Il volume è diviso in otto capitoli, ciascuno dei quali affronta una dimensione specifica del rapporto tra umani e animali. Si parte dall’intreccio tra animali e alimentazione, nodo etico e culturale cruciale delle società contemporanee. L’analisi di Pollo si distingue per attenzione alle sfumature, rifiuto di ogni manicheismo e capacità di leggere anche le scelte alimentari come pratiche eticamente significative. Lungi dal proporre un modello unico o prescrittivo, il testo valorizza la pluralità delle posizioni e invita a leggere l’alimentazione come terreno in cui si giocano scelte morali, simboliche e materiali. Un importante capitolo è dedicato alla storia della domesticazione e al modo in cui Homo sapiens si è coevolutivamente formato insieme agli altri animali. Questa parte offre una base biologico-antropologica che rafforza la tesi secondo cui il problema non è se usiamo gli animali, ma come lo facciamo. È l’allevamento industriale, con le sue logiche di sfruttamento intensivo, a rappresentare oggi una sfida morale e ambientale che non può più essere ignorata. Su questo punto il testo si sofferma con particolare efficacia: la dimensione industriale della zootecnia viene descritta non solo nei suoi aspetti etici (la sofferenza sistemica e strutturale inflitta agli animali), ma anche nelle sue implicazioni ecologiche. L’allevamento intensivo contribuisce in modo massiccio alla deforestazione, all’erosione della biodiversità, all’emissione di gas serra, al consumo eccessivo di acqua e suolo. Pollo sottolinea come il peso ambientale del sistema alimentare fondato sugli animali non sia un effetto collaterale, ma un tratto costitutivo di un modello di produzione insostenibile. La riflessione morale sull’uso degli animali si intreccia così con la consapevolezza dei limiti planetari, collocando l’etica animale dentro un’ecologia della responsabilità.
Nei capitoli centrali il libro ripercorre con chiarezza la genesi dell’etica animale: dall’oblio specista delle tradizioni classiche e religiose, fino alla svolta moderna inaugurata da Bentham, Darwin e poi dalla filosofia contemporanea con Singer, Regan, Nussbaum e altri. Questa genealogia non ha solo valore storico, ma serve a mostrare la possibilità di un’alternativa: un’etica post-antropocentrica che non fonda il valore sulla razionalità, ma sulla capacità di soffrire, di avere una vita soggettiva, di esistere come soggetti di esperienza. Significativa è anche la discussione sullo statuto politico degli animali, con riferimento alla proposta di Donaldson e Kymlicka di estendere forme differenziate di cittadinanza agli animali domestici, liminari e selvatici. Anche qui Pollo non si limita a riportare posizioni, ma invita a un esercizio critico che tenga insieme immaginazione normativa e concretezza delle istituzioni.
Il capitolo conclusivo sui novel food segna un ulteriore passaggio: si guarda al futuro delle nostre pratiche alimentari, dall’introduzione degli insetti nelle nostre diete – evento che sfida schemi culturali alla base di barriere psicologiche apparentemente insuperabili – alla carne coltivata, della quale vengono messe in luce le potenzialità per la mitigazione di problemi ambientali considerati indissociabili dall’agricoltura animale industriale. Non si tratta, nell’ottica presentata e discussa da Pollo, di soluzioni à la carte, frutto di un tecno-soluzionismo semplicistico, ma di possibilità da esaminare alla luce di un approccio critico e, volendo impiegare un termine a me caro, tecno-realistico. In altre parole non si tratta di esaltare o demonizzare le nuove opzioni alimentari ma di ripensare ai nostri paradigmi morali e simbolici anche attraverso l’aiuto della scienza e della tecnologia.
In definitiva, il gesto alimentare è presentato come punto di condensazione di molteplici dimensioni: biopolitica, salute pubblica, sostenibilità, responsabilità verso le generazioni future. L’etica, nella caratterizzazione fornita da Pollo, non è un punitivo invito alla rinuncia o all’esercizio ascetico ma un esercizio di riformulazione attiva della convivenza, che rifugge i radicalismi e preferisce la via del riformismo graduale e della conversazione democratica. Dopo aver letto il volume, difficilmente si potrà continuare a considerare gli animali semplici strumenti a disposizione degli umani.
luca.losapio@unito.it
L. Lo Sapio insegna bioetica e filosofia morale all’Università di Torino