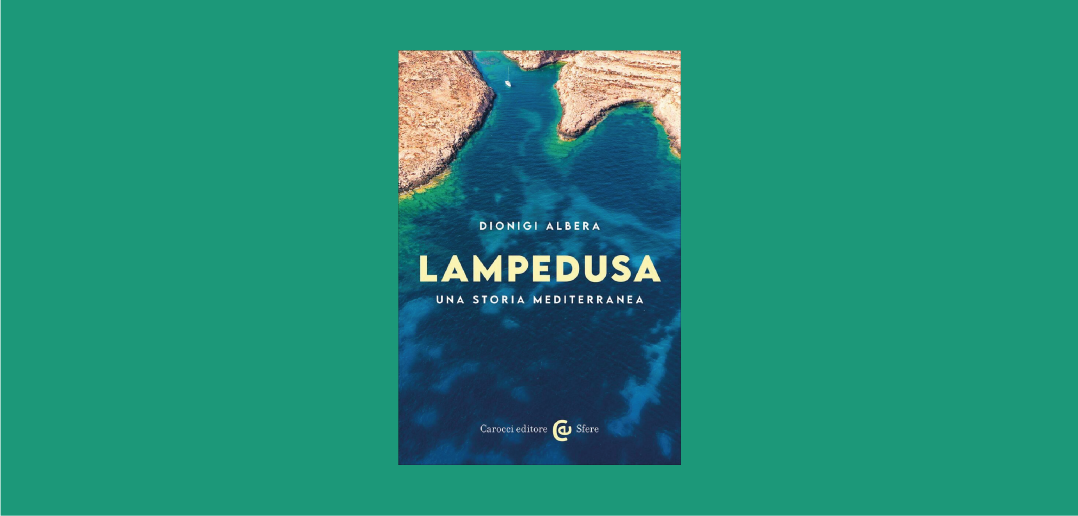Dionigi Albera
Lampedusa. Una storia mediterranea
pp. 248, €19,
Carocci, Roma 2025
Un portolano rovesciato
di Giovanni D’Ambrosio
Isole. Dalle coste orientali che si affacciano sul Mediterraneo allo spazio aperto dell’oceano Atlantico, negli ultimi trent’anni isole e arcipelaghi hanno assunto un ruolo centrale nella costruzione concreta e simbolica del confine all’interno dello spazio mediterraneo. Cipro, Lesbo, Creta, Malta, Lampedusa, Pantelleria, le isole Kerkennah, le Baleari, le Canarie. Nomi di luoghi in parte lontani tra loro, ma che affiorano nei nostri immaginari collettivi tanto per le spiagge, il mare e i paesaggi esotici, quanto – più drammaticamente – in occasione di eventi catastrofici: naufragi, sparizioni, attacchi da parte di milizie, guardie costiere o marine finanziate dall’Europa per attuare respingimenti violenti e troppo spesso letali. Isole unite, nonostante la distanza, da una geografia e una storia comuni, a cui si possono aggiungere anche territori che, pur non essendo isole in senso stretto, ne condividono le caratteristiche, come le enclavi spagnole in Marocco di Ceuta e Melilla.
Le isole diventano così spazi liminari di ingresso e non ingresso allo stesso tempo. Spazi marginali in cui la violenza delle politiche migratorie europee si esprime in modo forse più evidente che altrove, ma dove è possibile anche creare delle zone di complicità e contatto, talvolta inaspettate.
Lampedusa. Una storia mediterranea dell’antropologo Dionigi Albera, studioso del Mediterraneo e dei luoghi sacri condivisi, ci proietta all’interno di uno di questi margini, Lampedusa, costruendo pagina dopo pagina un “portolano rovesciato: invece di guidare la navigazione da un punto all’altro, da un’isola all’altra, si incentrerebbe su un unico punto, piantato in mezzo al mare, per seguirne tanto l’ancoraggio, l’irradiazione e la forza centripeta”.
Lampedusa emerge dal mare come un piccolo altopiano, una massa piatta di rocce bianche segnata da valli che sembrano seguire il tracciato di antichi fiumi. Le fanno compagnia a qualche decina di miglia di distanza le isole di Linosa a nord-est e Lampione a ovest-nord-ovest con le quali forma l’arcipelago delle Pelagie. La sua storia è profondamente connessa alla sua posizione in mezzo alle imprevedibili correnti che attraversano il Canale di Sicilia. Ma imprevedibili sono anche le storie, i frammenti e le fonti raccolti con pazienza da Albera, che portano chi legge a seguire la storia e la fama di Lampedusa ben oltre i confini dell’isola mediterranea.
Lampedusa infatti compare e scompare nella Storia, quasi come la sua vicina Ferdinandea, l’isola vulcanica che emerge ciclicamente dal mare per poi inabissarsi di nuovo. Tale e quale, Lampedusa riappare quando e dove meno te l’aspetti. Come racconta l’autore: “Sebbene sia immobilizzata dalla sua congiunzione con la placca africana, Lampedusa non smette di muoversi. È un’isola viaggiatrice. Il suo nome circola di bocca in bocca, di pagina in pagina, insieme alla natura unica degli scambi che vi si svolgono”. La fama di quest’isola trascende l’effettivo peso storico che Lampedusa ha nella storia del Mediterraneo e questa è una caratteristica che accomuna il passato e il presente dell’isola.
Lampedusa, ci racconta l’autore, è un’eterotopia, ovvero un luogo che trascende il suo essere fisico per diventare lo specchio che in qualche modo riflette contraddizioni e aspettative delle società dell’epoca. E così la ritroviamo tra le pagine dell’Orlando furioso (dove Ariosto la chiama “Lipadusa”), dove Lampedusa è teatro dell’epico scontro tra Franchi e Saraceni; nelle confraternite di schiavi liberati in Brasile; nel ponente ligure grazie ai voti di un naufrago. E poi ancora al seguito di re e regine approdate in una sosta dalle crociate, nella Parigi dei Lumi tra le righe di scritti incompiuti e non. L’isola sembra essere dotata davvero di una forza centripeta che va al di là della sua grandezza o del ruolo che Lampedusa ha nei commerci mediterranei. In parte sicuramente tutto ciò è dovuto anche alla protagonista al centro del libro di Albera: una grotta, un santuario, un luogo venerato e rispettato per secoli da comunità religiose diverse e spesso in conflitto. Albera ricostruisce con cura la storia di quello che oggi è chiamato il Santuario della Madonna di Porto Salvo, ma che in passato è stato un importante spazio religioso condiviso tra musulmani e cristiani e, in epoche diverse, dimora di eremiti, anacoreti e altre figure religiose molto rispettate dai loro contemporanei.
Albera ci consegna così non solo una storia dell’isola, ma un modo nuovo di orientarsi nella complessità del Mediterraneo: attraverso un’isola che non è mai solo confine, ma anche varco e fonte di complicità e contatti insospettabili. L’autore si muove tra passato e presente, senza cadere in facili semplificazioni che riducono troppo spesso l’isola a un’immagine dicotomica tra “l’isola dell’accoglienza” e “l’isola confine”. Un portolano rovesciato, appunto, in cui Lampedusa resta ferma al centro, mentre attorno a lei si muove il mondo.
giovanni.damb9@gmail.com
G. D’Ambrosio ha studiato antropologia delle migrazioni all’Università di Torino
L’isola della tolleranza
di Franca Cavagnoli
Un tempo, quando il faro di Capo Grecale non c’era, gli abitanti dell’isola accendevano dei falò sulle alture per segnalarne la presenza. I naviganti, tra cui anche pirati e corsari, li vedevano e sapevano di poter attraccare, fare rifornimento di acqua e cibo. Lamposa, Lopadosa, Lipadusa, Lampedosa. Il nome deriva da una radice greca che significa luce, fuoco. Su questa isola di cardi e di fichi d’India senz’altro non si vive più in trincea come nel 2011, quando i tg mandavano le immagini del promontorio del Cavallo Bianco su cui erano accampati i migranti, e ora molti cambiano canale quando appaiono le immagini dell’arrivo dei barconi al molo Favaloro o del naufragio dei barchini intorno all’isola. Ma fino al Settecento Lampedusa era stata disabitata, e forse proprio per questo ha alimentato l’immaginazione di molti, tra cui Ariosto, Shakespeare, Diderot, Rousseau, alle gesta letterarie dei quali l’ottimo saggio di Dionigi Albera dà ampio spazio.
L’Orlando furioso è una sorta di peregrinatio in stabilitate, scrive l’autore, perché il viaggio compiuto da Ariosto, che non si era mai mosso da Ferrara, è un pellegrinaggio interiore, secondo il precetto monastico medievale. Gli eroi del suo poema, invece, sono degli autentici nomadi: viaggiano in continuazione, a piedi, in barca, a cavallo o sul dorso dell’ippogrifo, si muovono in giro per il mondo e volano fino alla Luna. Lo stretto braccio di mare fra la Sicilia e la Tunisia fa da sfondo a una serie di episodi che “producono la risoluzione dei tre principali nodi tematici” del poema: la follia di Orlando si dissolve sulle coste africane; le acque del Mediterraneo accolgono l’amore tra Bradamante, cristiana, e Ruggero, guerriero saraceno valoroso quanto lei; la guerra tra i Franchi e i Saraceni culmina proprio a “Lipadusa”, poiché è qui che si svolge la battaglia risolutiva fra i tre paladini cristiani e i tre cavalieri musulmani: “Una isoletta è questa, che dal mare / medesmo che li cinge, è circonfusa”. Ariosto parla anche di altre isole, quelle che formano l’arcipelago delle Pelagie, ma l’unica che nomina è Lampedusa.
Oltre alle molte, vivide pagine che dedica all’Ariosto nella sua storia culturale dell’isola, Albera si sofferma su qualcos’altro di assai interessante. A Greenwich si conserva una piccola incisione su legno che si fa risalire alla fine del Cinquecento. Un’iscrizione segnala che è La Madonna di Lampedosa. Le nuvole scure che circondano la Vergine, il mare agitato e gli uccelli del malaugurio che lo sorvolano sembrano alludere a una tempesta. Ma il volto sorridente della Vergine e gli oranti rassicurano sull’esito positivo del viaggio. Questa incisione è finita nelle lunghe discussioni su La Tempesta di Shakespeare: per alcuni la geografia della pièce è inequivocabile, perché l’imbarcazione che fa naufragio naviga lungo la rotta fra Tunisi e Napoli. Ma a partire dal Settecento alcuni studiosi deviano il viaggio verso l’Atlantico, anche perché un unico verso accenna alle Bermuda, una interpretazione alimentata dapprima dai resoconti dei viaggiatori britannici e in seguito dagli studi postcoloniali. Ma all’inizio dell’Ottocento l’interpretazione più accreditata torna a essere quella dell’ambientazione mediterranea e la patria della Tempesta è di nuovo Lampedusa con la sua grotta-santuario.
A partire dal Cinquecento e fino alla metà dell’Ottocento la piccola grotta ospitava infatti qualcosa di singolare: una metà era riservata alla venerazione di un’immagine della Madonna e l’altra metà a quella di un marabutto, l’asceta eremita di cui si poteva vedere la tomba. Al santuario dedicato alla Vergine ma frequentato anche dai musulmani, Albera torna puntualmente nel suo libro per rimarcare come per secoli l’isola sia stata “un luogo emblematico dell’aiuto reciproco”, di tolleranza e solidarietà, una frontiera aperta a naufraghi e schiavi fuggitivi in un mare infestato da scontri tra cristiani e musulmani. Nel Settecento l’isola che “appartiene a tutti” fece pure il suo ingresso nei salons parigini e il doppio culto del luogo divenne un simbolo di apertura religiosa: “Ah amici miei, se andassimo una volta a fondare a Lampedusa, lontano dalla terra, in mezzo al mare, un piccolo popolo felice!”. Così Diderot in un’opera del 1757, Il figlio naturale, e l’“isoletta” punteggiata di mortella entra nella storia del teatro e della filosofia. Il genere dell’opera è ibrido, ma per Diderot era “una specie di romanzo”, e piace pensare che forse Lampedusa abbia contribuito un poco a rendere più intensa la luce del secolo dei Lumi.
E l’isola affiora anche in un’opera incompiuta di Jean-Jacques Rousseau, Emilio e Sofia o i solitari, un romanzo epistolare iniziato nel 1762 e accantonato presto ma mai veramente abbandonato. Il libro prevedeva che Emilio percorresse a piedi l’Africa e sentisse parlare di un’isola deserta con una grotta contenente una statua della Vergine, dove si trovava sempre del cibo pronto ad accogliere i naviganti. È un vero peccato che Rousseau non ne abbia proseguito il racconto, perché – Albera ne è convinto – “ciò avrebbe senza dubbio significato la consacrazione letteraria di Lampedusa”. Se però Diderot mette a fuoco la convivenza interreligiosa, Rousseau fa dell’eremita che abita l’isola “la quintessenza del cattolicesimo”, pur realizzando nel contempo un punto di equilibrio “tra lo stato di natura e il contratto sociale”. Anche oggi Lampedusa potrebbe essere un luogo di incontro pacifico, “una zona di contatto”, una soglia e non una zona di frontiera: come per buona parte della sua storia, e in particolare durante l’Illuminismo, Lampedusa continua a interpellare la coscienza europea.
franca.cavagnoli3@gmail.com
F. Cavagnoli è scrittrice e traduttrice
L’isola che non c’è (più)
di Giovanna Fiume
Tra medioevo ed età contemporanea il Mediterraneo è un’area di acuto conflitto politico, uno spazio continuamente attraversato da uomini e merci, condiviso nell’attività di commercio e conteso militarmente; su di esso si proietta la giurisdizione degli stati nazionali, degli imperi spagnolo e ottomano in primo luogo e dei rispettivi alleati. L’intensa mobilità che caratterizza i soggetti che attraversano questo mare produce un flusso incessante di informazioni e conoscenze e crea connessioni tra le due sponde che, pur segnate da profonde fratture politiche, mantengono nello stesso tempo una innegabile reciprocità. Ai captivi, prodotti dalla guerra da corsa e ridotti in schiavitù, accade di rinnegare la propria fede: i cristiani “si fanno Turchi” e “prendono il turbante”, i musulmani chiedono il battesimo. Agli inquisitori, di fronte a cui i primi vengono condotti come apostati e presunti dissimulatori, capita di ascoltare le opinioni religiose più ibridate: che Maometto è figlio di Dio, siede alla destra del Padre, è la terza persona della Trinità, che le abluzioni precedenti la preghiera servono a lavare i peccati, che Giacomo di Compostela è genero di Maometto e via dicendo, ed è abbastanza diffusa l’idea che tutte le religioni si equivalgano e ci siano più strade che conducono alla salvezza e al paradiso comune. Molto frequenti altresì sono le pratiche sincretiche dentro l’islam nel vasto e composito impero ottomano dove capita che i musulmani partecipino ai riti dei santuari cristiani e usino come talismani oggetti di culto cristiani.
Dopo lo studio dei luoghi mediterranei delle “religioni condivise”, è Lampedusa ad avere attirato l’interesse dell’antropologo Dionigi Albera, poiché un testo del XIV secolo vi riferisce la presenza di un eremita, dalla capacità profetica pari a quella di Merlino o di Gioacchino da Fiore, ripresa da testi millenaristi nel XV secolo. Di più, nella seconda metà del XVI secolo, appaiono testimonianze su una piccola grotta che riserva uno spazio alla Madonna e uno alla tomba di un marabutto (un eremita musulmano morto in concetto di santità). A entrambi i marinai che sbarcano nell’isola alla ricerca di acqua, legna, conigli e tartarughe, a prescindere dalla religione di appartenenza, chiedono protezione e lasciano offerte votive. Appesi a pertiche e corde, vestiario, cibo, attrezzi, vele, candele, piccoli oggetti preziosi, monete, consentono la sopravvivenza ai naufraghi e agli schiavi fuggitivi: sui furti vigila la potenza soprannaturale (eventualmente vendicativa) della Vergine. I cavalieri di Malta periodicamente raccolgono denaro e gioie e li portano alla Madonna dell’Annunziata di Trapani, verso cui è grande la devozione della gente di mare. L’isola, rimasta spopolata per secoli, diviene così una zona di contatto e di incontro pacifico, di circolazione di beni tra avversari, di sospensione delle ostilità – persino di soccorso – tra cristiani e musulmani in un Mediterraneo in conflitto, segnato da numerose frontiere: “una tregua informale, ratificata da forze soprannaturali, regna sul suolo dell’isola”. La rivalità e l’antagonismo si convertono qui in convivenza e mescolanza. Di questo “miracolo” scrivono i viaggiatori – Lampedusa con Ariosto si radica nell’immaginario della cultura europea – e nel Settecento diventa simbolo di tolleranza a cui mette fine la colonizzazione, ipotizzata o tentata da inglesi, francesi, maltesi, infine intrapresa dal Regno delle due Sicilie.
Sulla grotta-santuario ctonio Albera rintraccia via via più consistenti testimonianze, insegue a Genova e nelle Americhe la reputazione della Madonna di Lampedusa oltrechè negli scritti degli illuministi per i quali l’isola diventa simbolo di apertura religiosa e di sperimentazione di comunità laiche, mentre prende forma un progetto francese di colonizzazione con manodopera maltese per farne una pedina dello scacchiere politico francese nel Mediterraneo, alla stregua di Malta. E in effetti, nel Settecento Lampedusa si dissocia dal suo mito e diviene avamposto maltese nelle mani della Francia dentro i conflitti che avranno luogo tra le potenze europee per il controllo del Mediterraneo. Nel 1843 i Borbone acquistano l’isola e vi insediano centoventi coloni e un distaccamento militare con tre navi; diverrà un luogo di confino per delinquenti e oppositori politici fino al 1940. La Madonna diventa la patrona della colonizzazione, mentre il suolo dell’isola risulta sterile e il disboscamento per fare carbone e l’erosione del suolo le assegnano il suo attuale aspetto spoglio e quasi desertico. Gli isolani si rivolgono al mare, scoprendo la potenzialità delle sue risorse (ricchi banchi di sardine, spugne, coralli); successivamente il boom del turismo darà nuove opportunità economiche a gruppi imprenditoriali del nord e anche ai pescatori e alle loro famiglie.
Negli ultimi decenni del Novecento con la costruzione di una Unione europea, il Mediterraneo viene inglobato in questo spazio comune, di libera circolazione dal 1985-1990, e diviene “oggetto di un processo di radicalizzazione della frontiera”, sempre più rigida a causa delle numerose restrizioni contenute nelle convenzioni che la regolamentano. La “fortezza Europa” erige un muro: a Lampedusa arriva un flusso migratorio crescente – che nel 2008 tocca la cifra record di 30.000 migranti – che la trasforma insieme in centro di controllo, di accoglienza, di detenzione. L’intesa con la Libia del 2017, pone il tema dei trattenimenti e la diminuzione degli arrivi fa pensare alla sottrazione violenta della “speranza del mare” a migliaia di uomini e donne.
La storia culturale di Lampedusa, con le sue radici medioevali, l’ha fatta immaginare per secoli come il laboratorio di una possibile rigenerazione collettiva, su cui incombe oggi la tragedia dei migranti e l’aumento dei naufragi. “In un contesto di violenza e conflitti c’è stato chi ha saputo trasformare questo lembo di terra in un luogo di tregua e di scambio. […] Così è nato il mito di Lampedusa e della sua Madonna. […] L’eredità storica di Lampedusa ci indica la strada per umanizzare di nuovo questa frontiera, per rendere il mare una zona di mescolanza, e non una barriera impenetrabile”. In caso contrario, Lampedusa denuncia la barbarie dell’Europa.
giovanna.fiume@unipa.it
G. Fiume ha insegnato storia moderna all’Università di Palermo