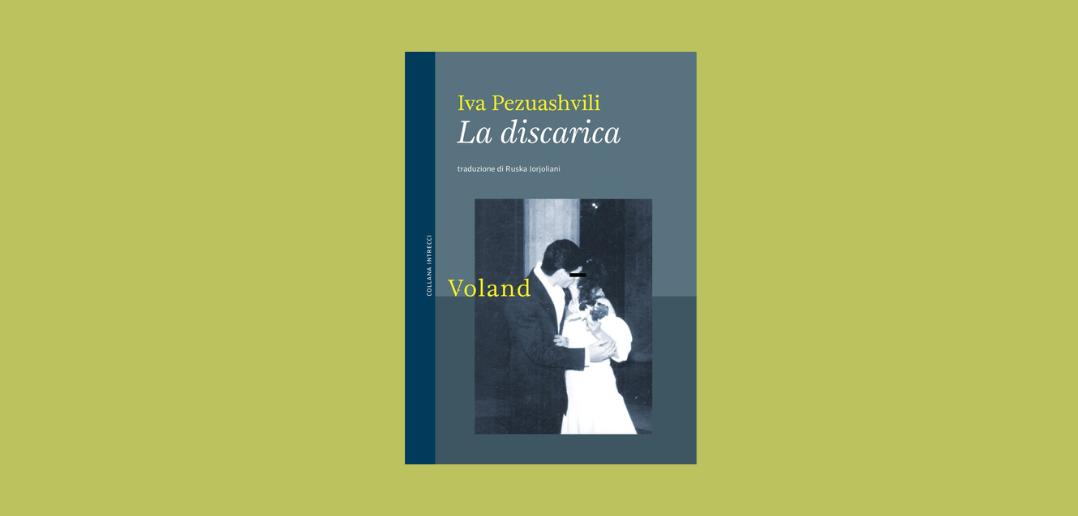recensione di Khatuna Tskhadadze
Iva Pezuashvili
La discarica
trad. dal georgiano di Ruska Jorjoliani
pp. 145, € 18
Voland, Roma 2024.
La discarica di Iva Pezuashvili è una metafora della Georgia contemporanea, una sorta di biografia postsovietica del Paese, raccontata in meno di centocinquanta pagine, non secondo una cronologia lineare, ma piuttosto attraverso immagini, flashback e sensazioni: quarant’anni di memoria collettiva di un piccolo Paese transcaucasico. La storia familiare di due generazioni ravviva, con una limpidezza e una schiettezza quasi offensive, ciò che è stato dimenticato o si è cercato di dimenticare, ma anche ciò che ancora si vive.
La stessa geografia del testo – Erevan, Baku, Tbilisi – è una metafora dell’identità: la ricchezza e la stranezza della capitale georgiana. È questa anche la mistura della famiglia dei due protagonisti, Gheno e Mila. Attraverso i ricordi della loro giovinezza, in cui echeggiano drammi storici e geopolitici, l’autore intreccia il doloroso e irrisolto sfondo transcaucasico con una storia ambientata a Tbilisi. Gheno e Mila incarnano lo spirito multietnico della città, del quale la lingua del romanzo è perfetta espressione: i dialoghi sono un autentico miscuglio del parlato della fine del XX secolo e dell’inizio del XXI – impastato con un russo che non è propriamente russo, ma un idioma tipico di Tbilisi – un gergo che probabilmente solo chi ci ha vissuto può comprendere fino in fondo.
Nella letteratura georgiana contemporanea è raro incontrare un ritratto della capitale così vivido, costruito esclusivamente attraverso i personaggi: è la Tbilisi tardo-sovietica e postsovietica, con le sue trasformazioni e ferite storico-sociali, con l’architettura e l’urbanistica – anzi, il delirio urbanistico – di una città sventrata dalla memoria ma che ancora trasuda questa memoria da ogni suo poro. C’è forse tutto ciò che accomuna i cittadini di Tbilisi: dalle tristi uniformi scolastiche dell’epoca sovietica alla comica bruttezza degli ultimi anni dell’URSS, seguita dall’altrettanto comico delirio pseudo-capitalista che, con quella “diarrea di libertà”, ha travolto uomini e donne agli inizi degli anni Novanta.
Ma quella cacarella patriottica era forse anche un mezzo per fuggire dall’inferno della vita quotidiana – fame, mancanza d’acqua, gas, elettricità o servizi pubblici – incarnata nel romanzo dall’odore insopportabile delle discariche interne nei caseggiati sovietici. Discarica come metafora dell’esistenza: immagine feroce di un fetore onnipresente che non si può allontanare né togliere di dosso, che penetra ovunque, soffoca e ricorda che c’è del marcio nel Paese.
Leggendo il libro, chi ancora oggi conserva il ricordo vivissimo e traumatico di quell’immagine rivoltante e con quella puzza ancora nelle narici, non smette di sorprendersi: da dove veniva tutta quella immondizia? Che cos’era, come si accumulavano tanti “rifiuti” negli anni in cui non c’erano né cibo né vestiti, né buste né bottiglie di plastica? Se tutto ciò con cui oggi si inquina il pianeta, per i georgiani era lusso? Lo scarto non implica, per definizione, che qualcosa sia stato posseduto, consumato e poi gettato via?
Senza nominarla esplicitamente, l’autore descrive anche l’economia (ovvero la sua assenza) della Georgia postsovietica: banca, banca, farmacia, farmacia, banco dei pegni, banca… La rappresentazione del debito e del malessere nell’economia nazionale. È ancora questo l’amaro elenco che incapsula la nostra realtà.
I figli di Gheno e Mila – Lazare (così profondamente georgiano) e Zema (che richiama tutte le etnie possibili che vivono a Tbilisi) – incarnano le due principali “prospettive occupazionali” dei giovani georgiani degli anni 2000: il corriere – ragazzo delle consegne – e l’arruolamento in polizia. Il corriere in motorino è un urlante marchio del tessuto sociale del Paese dell’ultimo decennio: un’intera generazione, povera e senza prospettive, al servizio dei consumatori profumati di ricchezza, che può solo annusare per un attimo l’odore “di un futuro migliore” davanti alla porta del cliente, un futuro che non sarà mai il suo.
La discarica è anche la storia di uomini privati di ogni funzione e di donne divenute “maschi” negli anni Novanta. Donne che non riescono più nemmeno a piangere, che hanno “sostituito gli uomini su tutti i fronti” e che, se mai qualche gesto d’attenzione da parte di quei profumati di ricchezza gli ricorda ancora la loro femminilità, non potranno mai dimenticare il mondo a cui appartengono. Incastonate in abiti presi in prestito, non potranno mai assaporare, nemmeno per una serata, quella felicità illusoria.
Questo libro respira eventi chiave della nostra memoria collettiva – guerra civile, rivoluzione, scontri con la polizia e dispersioni violente, l’attentato al Presidente che trasforma Gheno in un eroe per caso, di cui alla fine non importa a nessuno e che sarà ricordato una volta l’anno, se va bene. Come del resto il 9 aprile, il giorno della più grande tragedia della Georgia contemporanea.
Ma c’è anche la vita di oggi: il nuovo proletariato, il delirio della visibilità sui social, la paura e l’odio verso i flussi migratori, i cambiamenti a folle velocità che creano l’illusione dello sviluppo e fanno dimenticare che i cambiamenti, “a volte – anzi, nella maggior parte dei casi – peggiorano le cose”. È una sintesi della farsa del progresso, tanto comica quanto la democrazia fondata sulla giustizia di strada, informale e mafiosa, della fine del XX secolo.
È vero che in quegli anni la vita umana non valeva più di un pacco di pasta degli aiuti umanitari, ma per il nuovo proletariato non è cambiato molto: oggi un’uscita può costare la vita a un corriere come Lazare, e non basterà il nome per farlo risorgere. Dovrà scroccare gli ultimi 200 lari a sua madre, quella donna ancora bella ma che ha da tempo dimenticato di essere donna.
Non ci sono più le discariche nei caseggiati sovietici, ma il tanfo non scompare: trasferitosi più in profondità, “nello stomaco”, si diffonde da lì come un costante ricordo di un morbo mortale mai diagnosticato.
Anche la musica racconta la storia in questo libro. Non c’è forse nessun marker socio-culturale – doloroso o gioioso, divisivo o unificante – che sia stato omesso. C’è la musica che ascoltavamo, i libri che leggevamo, tutto ciò che ci nutriva e ci formava. I nomi dei personaggi dei cartoni animati sovietici diventano soprannomi dei criminali, di quei bambini affamati e incattiviti che impugnano armi, uomini mai cresciuti. Anche il nome del protagonista, Gheno, è forse un’eco ironica e malinconica di quel coccodrillo Ghena in giacca e cravatta, buono e serio, appassionato di libri e scacchi, che usava la pipa solo per soffiare bolle di sapone.
L’ironia (e l’autoironia) permea ogni aspetto del libro – l’ambientazione, la trama, i personaggi – e aggiunge una sorta di amara tenerezza alla crudele sincerità del racconto, rendendo la lettura ancora più intensa e godibile. La lingua è un vero teatro di sperimentazione per Iva Pezuashvili: passa dal gergo più grezzo alla lingua sofisticata, densa di riferimenti culturali. Le scelte ironiche – come quella di narrare la violenza contro la donna con la lingua che evoca il primo testo letterario georgiano del V secolo – sembrano voler ricordare che la violenza è sempre la stessa, indipendentemente dall’epoca e da chi sia il bullo: un principe violento di quindici secoli fa o un maschio disfunzionale dei nostri giorni. E che la donna – la vittima – è sempre infinitamente più forte del suo carnefice.
Un libro che racconta la crudeltà e la ferocia della guerra civile, la povertà, la frattura sociale, le famiglie disfunzionali, ma racconta anche l’amore e dà speranza, anche solo attraverso l’allenamento della memoria e la lucidità emotiva e intellettuale. Sì, fa sperare che prima o poi ci si liberi anche di quel fetore annidato nel profondo, se si ammette che “per uccidere un uomo non è necessario trovare coraggio ma piuttosto perderlo”.
Un libro profondamente georgiano che, grazie alla maestria della traduttrice – la scrittrice georgiano-italiana Ruska Jorjoliani – riesce a superare le non poche sfide linguistico-culturali e restituisce anche al lettore italiano il ritratto metaforico di un’intera nazione. Un paese su cui tanto si è scritto in chiave geopolitica, ma che, raccontato così “dal basso”, è ancora tutto da scoprire per l’Europa. Questa testimonianza, anche se letteraria, è dunque particolarmente preziosa, e non c’è da temere che qualcosa – tra sofisticate allusioni storico-sociali o culturali – possa sfuggire al lettore italiano: l’edizione include le preziose note della traduttrice. Il libro farà comunque il suo lavoro che è quello di stimolare l’immaginazione e risvegliare la curiosità di un lettore attento.
K. Tskhadadze è scrittrice e traduttrice