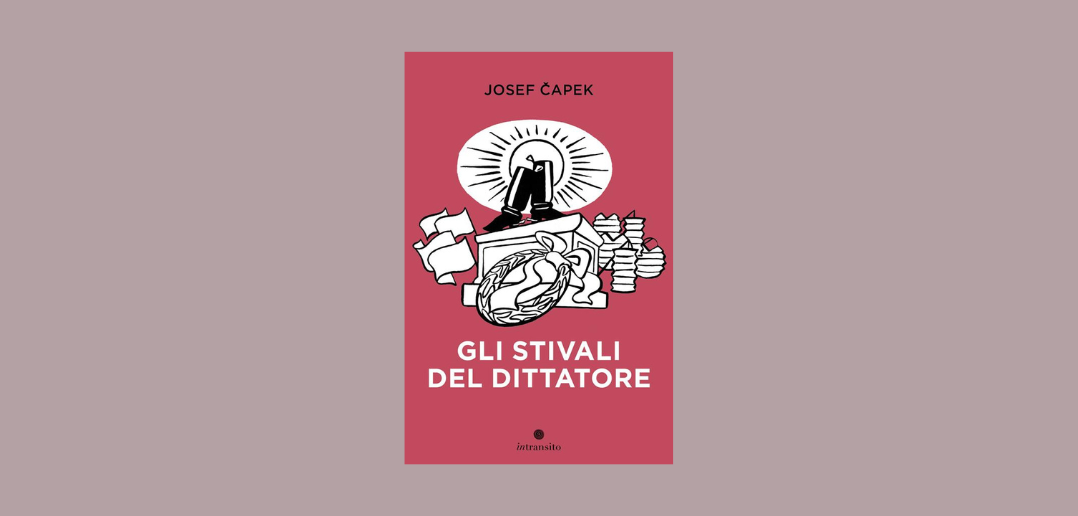recensione di Tiziana D’Amico
Josef Čapek
Gli stivali del dittatore
trad. dal ceco di Angela Mondillo
pp. 90, € 14
Transito, Milano 2024
Quest’anno, 2025, ricorrono ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Insieme a questo anniversario importante, ricorrono anche ottant’anni dalla morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen di Josef Čapek. Fratello maggiore di Karel, Josef Čapek è uno di quegli intellettuali e artisti la cui estrema versatilità rende difficile da racchiudere in una sola definizione, o etichetta. Pittore, illustratore, grafico del libro, scenografo, critico d’arte, scrittore e poeta: in ciascuna delle aree in cui si è mosso ha lasciato il segno.
Nella versatilità della sua forza creatrice, Josef Čapek si distingue anche per la stretta collaborazione con il fratello Karel. Il caso più famoso è pièce teatrale Ze života hmyzu (Dalla vita degli insetti del1921). Tuttavia, l’opera più conosciuta presso il pubblico italiano è forse la raccolta di racconti su un cane e un gatto, Povídaní o pejskovi a kočičce, I racconti sul cagnolino e la gattina, pubblicati nel 2014 da Poldi Libri (tradotta in italiano da Michaela Šebőková Vannini). La produzione per l’infanzia è molto ricca e ogni opera firmata da Karel Čapek (per esempio Dasenka, disponibile in più edizioni in italiano), ha le illustrazioni del fratello Josef. Quando non scrive a quattro mani, Josef è autore delle illustrazioni (come ne L’anno del giardiniere, Sellerio) e delle copertine dei libri del fratello Karel.
Nel 1930, dopo numerose raccolte di racconti, pubblica Stín kapradiny , prosa che unisce l’epico al lirico che nel corsa della lettura muta la sua forma da ballata a preghiera fino alla maledizione; pubblicata in italiano con il titolo L’ombra della felce per i tipi della Poldi Libri nel 2007 con la traduzione a cura di Davide Sormani. Poeta lo è diventato o, meglio ha scoperto di esserlo nel campo di concentramento. Possiamo leggere le sue poesie in italiano grazie alla traduzione di Lara Fortunato per Miraggi Edizioni (Poesie dal campo di concentramento, 2019). Il Primo settembre 1939 viene infatti arrestato nell’ambito dell’Operazione A; operazione messa in atto dalla Gestapo per l’arresto “preventivo” di funzionari, importanti personalità e intellettuali per impedire una loro attuale o futura leadership nella resistenza antinazista e per intimorire la popolazione del Protettorato di Boemia e Moravia. Il 9 settembre Josef Čapek viene deportato a Dachau e poi a Buchenwald, dove rimane fino 1942. A giugno del ’42 viene deportato a Sachsenhausen e nel febbraio 1945 è a Bergen-Belsen, dove si ammala di tifo. Il suo corpo non è mai stato trovato. Nonostante la prigionia, il suo spirito creativo continua ad animarlo. A Sachsenhausen traduce poesie dall’inglese, dallo spagnolo e dal norvegese, illustra un lungo poema dedicato al fratello Karel e diffonde le sue poesie in forma manoscritta. Sarà il poeta Vladimír Holan a curare la pubblicazione postuma delle poesie.
Pubblicamente antifascista, a partire dall’ascesa di Hitler Josef Čapek manifesta la sua dura critica al fascismo anche attraverso numerose vignette satiriche, pubblicate principalmente sul Lidové Noviny (il quotidiano per il quale lavora dal 1921 come redattore e critico d’arte) e su altri giornali. Nel 1937 pubblica, con una introduzione di Josef Hora, Gli stivali del dittatore (Diktátorské boty): un ciclo di vignette satiriche precedentemente pubblicate sulle pagine di Lidové noviny. Nel 1938 crea il ciclo di disegni satirici Tempi moderni (Moderní doba) in risposta alla guerra civile in Spagna. La fretta con cui i nazisti si muovono per arrestarlo è comprensibile se si guarda Gli stivali del dittatore, disponibile per il lettore italiano grazie alla casa editrice In Transito all’interno della collana Praga Magica con la traduzione di Angela Mondillo (2024). La satira fa ridere dell’autorità: non è l’unica forma di risata, ma è quel tipo specifico di risata che nasce dall’inaspettato ridimensionamento di coloro che sono considerati più potenti di noi. Per essere oggetto di satira, qualcosa deve avere potere e prestigio, o deve volere essere riconosciuto come tale. A differenza di un articolo o di un racconto, però, la vignetta satirica ha un impatto maggiore presso il lettore. Ciò è dovuto alla densità del messaggio, condensato nell’ibridazione di immagine e parola.
Gli stivali del dittatore è la storia degli stivali neri, lucidi e imponenti che indossano i dittatori, e che gli aspiranti tali sognano di avere. Gli stivali sono “la più alta espressione degli ideali razziali e spirituali della nazione” (p. 16) e “la storia avanza per lo più in stivaloni” (p.18), ma per farlo, osserva Hora, calpestano milioni di teste adoranti (p.9) fino a riempirsi di teschi dopo aver distrutto la democrazia (p.45). L’adorazione per la forza, il desiderio di fare ordine nel caos è motivo per cui gli stivali sono così lucidi: lustrati dalla propaganda, ma messi in mostra e lodati dalle istituzioni che dovrebbero essere i pilastri della critica a difesa di un’opinione pubblica informata: università, stampa e magistratura. Josef Čapek individua bene i meccanismi per cui gli stivali ottengono il potere, e più questi diventano grandi, più rimpicciolisce il cittadino (pp. 32-33).
Gli stivali del dittatore è un racconto nel momento in cui si prende il ciclo nella sua interezza e lo si guarda e legge in successione: così facendo appare evidente la forza della concisione visiva e del concatenamento delle singole sequenze nel creare un discorso nella sua interezza. La singola vignetta, tuttavia, risulta autonoma nel tratteggiare la situazione. Il disegno di Čapek è semplice, ma ricco di dettagli. Dalla bocca spalancata piena di canini aguzzi di un aquilone che porta sempre più in alto gli stivali al mondo che si sgonfia (anticipando l’idea di Chaplin ne Il grande dittatore) bucato dagli speroni di più dittatori, l’immagine coglie nell’attimo l’abnormalità della dittatura. A questa risponde il testo scritto, anch’esso essenziale e criptico se preso da solo, che nel momento in cui si “innesta” e si lascia “innestare” partecipa alla creazione di un significato nuovo, che si moltiplica all’infinito nel caso della vignetta satirica. In virtù di quanto scritto, non possiamo non osservare che la scelta di collocare il testo in italiano sulla pagina accanto a quella con la vignetta riduca la forza del mezzo scelto da Josef Čapek. Se, infatti, quando l’immagine occupa le due pagine e il testo italiano si trova su una pagina e quello ceco su quella accanto la forza comunicativa è al massimo, quando l’immagine si trova solo su di una pagina, con il testo ceco e la traduzione sulla pagina accanto, vuota, la sua fruizione non è più immediata e il “gioco” risulta rallentato. Elogiamo la scelta di mantenere il testo in ceco (creando una nuova forma delle edizioni con testo a fronte) e comprendiamo la necessità di compiere una scelta “drastica”; tuttavia, ci domandiamo se invertire le due lingue non potesse essere una strada perseguibile. Rimane il merito di mantenere ferma la volontà di unire l’integrità della vignetta satirica originale con la traduzione, mostrando anche al lettore estraneo agli studi sulla traduzione, la complessità del linguaggio multimediale e l’importanza di chi traduce e di chi “fa” i libri.
Gli stivali del dittatore sono un monito della guerra e della morte che il fascismo porta sempre con sé. Il cittadino che, per ingenuità o superficialità, invoca “l’ordine”, ci ricorda Čapek, sta rinunciando alla responsabilità della democrazia, che è compito di tutti noi. Ritornando al potere della risata, una caratteristica di Josef Čapek è l’affetto con cui guarda le piccolezze dell’uomo “medio”. L’obiettivo non è puntare il dito e trovare un colpevole, per Čapek la funzione del riso è quella di far ridere la verità, perché il riso è un prezioso alleato della conoscenza (pensiamo qui alle argomentazioni di Guglielmo ne Il nome della rosa).
Il lettore italiano può vedere la notevole capacità di questo artista e intellettuale di creare un linguaggio visivo specifico per ogni opera che illustrava o della quale realizzava la copertina grazie alla scelta della casa editrice In Transito di utilizzare le copertine e le incisioni realizzate da Josef Čapek per le edizioni ceche di Zone (1919), in ceco Pásmo, titolo conservato nell’edizione italiana, e Il passante di Praga (1926) di Apollinaire. Entrambi i volumi sono usciti nel 2025 all’interno della collana “Praga magica”.
Forse meno conosciuto rispetto al fratello, Josef Čapek merita di essere ricordato, a prescindere dagli anniversari, per la vitalità originale e poliedrica di uno spirito artistico che rimase inestinguibile anche nelle tristi circostanze dei suoi ultimi mesi di vita. Oggi più che mai, visto le nuvole che si addensano nuovamente a velocità sostenuta sulla democrazia.