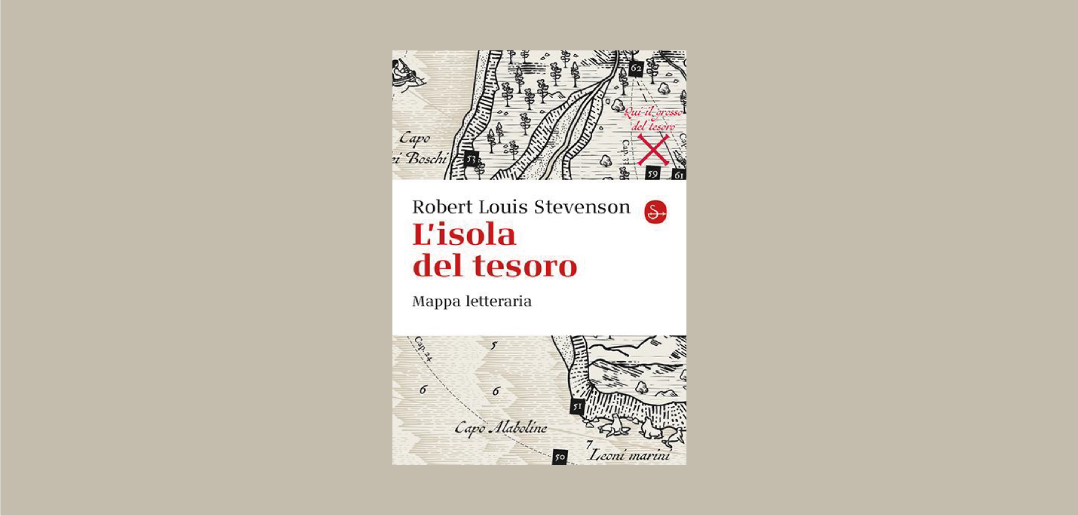Robert Louis Stevenson
L’isola del tesoro. Mappa letteraria
€ 5,
Il Saggiatore, Milano 2025
Universi chiusi e aperti insieme
di Luigi Marfé
Ogni libro è a suo modo un’isola, spazio in cui chi scrive può far crescere il proprio mondo d’invenzione, portarvi chi legge, farlo perdere e poi ritrovare, come in un labirinto. Di volta in volta, le isole hanno rappresentato in letteratura la terra cui tendere o la casa cui ritornare, lo spazio dell’utopia e della distopia, un paradiso edenico, il luogo dell’incontro, la reclusione del confino, lo scampo dal naufragio, il laboratorio metatestuale dello scrittore. Universi in sé conclusi eppure aperti al mare, limitati eppure completi, le isole sono per loro natura dispositivi narrativi perfetti e, al tempo stesso, specchio della pagina scritta. Di volta in volta, i personaggi che vi sono approdati hanno trovato in esse solitudine, esilio, felicità, nostalgia, desiderio.
Il potere di fascinazione dell’isola era ben noto a Robert Louis Stevenson – “scrittore di favole singolarmente cattivanti”, nella definizione di Giorgio Manganelli –, che ha cominciato a comporre Treasure Island (L’isola del tesoro, 1883), prima ancora che scrivendo, finendo il disegno di una mappa di Lloyd Osbourne, il figlio della donna per cui aveva lasciato tutto, Fanny Van de Grift. Mentre il ragazzo dipingeva un acquerello con un’isola di fantasia, Stevenson si divertì a immaginare un nome per vari luoghi della mappa (“Cala del Rum”, “Isola dello Scheletro”, “Fortino”, “Palude”, “Cimitero”), intendendoli come altrettanti detonatori della fantasia. Prese così forma la vicenda di Jim Hawkins, che da Bristol si imbarca sulla Hispaniola, insieme a una ciurma di marinai mal assortiti, per inseguire il miraggio di un tesoro indicato su una mappa. Una trama, nelle parole di Henry James, “perfetta come un gioco da ragazzi ben giocato”, in cui il proposito di prendere il mare diventa un modo per andare incontro al proprio destino, tra ammutinamenti, pirati e ogni genere di peripezie. Tutte le storie narrate da Stevenson, come in parte la sua stessa leggenda biografica, hanno il sapore del romance, fatto d’avventura e sentimenti, che distingue l’umano dalla lealtà e dal coraggio. Siamo abituati a prediligere le “opere aperte”, in cui al lettore è lasciata libertà d’interpretazione, rispetto a quelle “chiuse”, dal cui labirinto siamo liberati solo quando e come desidera l’autore. In verità, non c’è meno piacere nel lasciarsi trascinare nel mondo d’invenzione prodotto da quest’arte di prestidigitazione, la “letteratura come menzogna” per dirla ancora con Manganelli, di cui Stevenson era un maestro. Che poi, a ben vedere, non esclude la polisemia dell’“opera aperta”, ma solo ne sposta l’indeterminatezza dal piano diegetico a quello dei personaggi, sempre labili e inaccessibili nella loro elusività. Non a caso, Stevenson ha avuto lettori d’eccezione come Jorge Luis Borges, che nel ritmo della sua prosa trovava un motivo di felicità.
Questa mappa letteraria pubblicata dal Saggiatore, che riproduce in italiano quella realizzata dal progetto Literary Maps, ha su un lato la carta dell’isola e sull’altro quella di tutta la Terra, permettendo di seguire la geografia immaginaria degli spostamenti dei personaggi del romanzo. Scrittore dei luoghi prima ancora che del viaggio, anche Stevenson trascorse una vita itinerante, dislocata tra spazi molto diversi: la Scozia dell’infanzia, la Francia dei primi libri in canoa e a dorso d’asino, gli Stati Uniti del viaggio verso Fanny, i mari del Sud in cui sarebbe infine diventato “Tusitala”. Giocata tutta sulle polarità (il bene e il male, la luce e la tenebra), la sua scrittura trova nel viaggio nuove coppie oppositive (lontano e vicino, passato e presente), che si intrecciano, trapassando l’una nell’altra. Negli ultimi anni della sua vita, a Samoa, Stevenson si sentiva conteso tra la nostalgia per la Scozia e quella che avrebbero finito per suscitargli i mari del Sud, qualora fosse tornato in Europa. Come si legge in una delle poesie di Songs of Travel (Canti di viaggio, 1895), “svaniscono i tropici e in sogno mi pare di vedere” il rifrangersi del mare sulla costa scozzese. Da Vailima a Edimburgo, da un’isola all’altra, ognuna con il suo tesoro.
Clicca qui per uno sguardo alla mappa.
luigi.marfe@unipd.it
L. Marfè insegna critica letteraria e letterature comparate all’Università di Padova