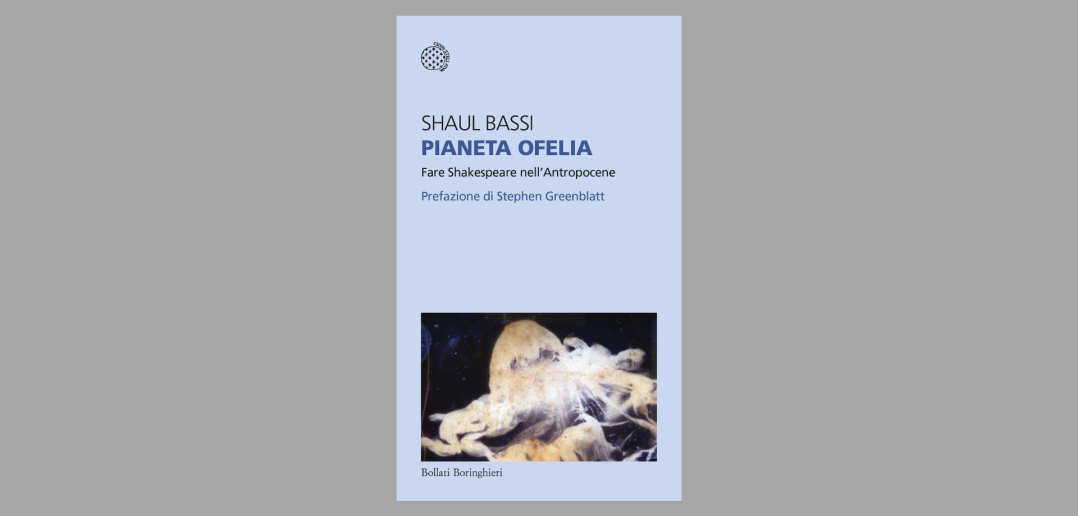Shaul Bassi
Pianeta Ofelia: fare Shakespeare nell’Antropocene
pp. 139, € 14,
Bollati Boringhieri, Torino 2024
A partire dal fortunato libro di analisi pragmatica del linguaggio How to Do Things with Words (Come fare cose con le parole, 1962) di J.L. Austin, sono molti gli scrittori che si sono interrogati sui modi in cui la cultura e la lingua riescono a ‘fare cose’, cioè incidono in modo materiale sulla realtà, trasformandola. È una ricerca che appassiona anche gli shakespeariani: Laurie Maguire, ad esempio, che ha pubblicato la raccolta di saggi How to Do Things With Shakespeare nel 2007. Shaul Bassi ci riporta su questa domanda con il suo Pianeta Ofelia, formulando un invito a “fare cose con Shakespeare, con grande libertà”.
Questo è, a essere onesti, un invito che teatranti, studiose e studiosi, studenti e traduttori hanno sempre accettato, aumentando di volta in volta la posta in gioco in sperimentazioni anche ardite. La novità è che Bassi intreccia la pratica del ‘fare con Shakespeare’ con una riflessione strettamente collegata al nostro tempo: O cursed spite, verrebbe da dire con Amleto, destino crudele, perché anche noi, a quanto pare, siamo nati in un tempo scardinato, fuor di sesto, out of joint. Siamo infatti “in tempi di crisi ambientale” e qualcuno teme sia già troppo tardi per invertire la rotta. La domanda, dunque, è se questa consapevolezza cambi il nostro modo di sperimentare con Shakespeare, e soprattutto se si possa trovare nel corpo dei suoi testi qualche momento che ci aiuti a pensare il nostro tempo, senza per questo volere attribuire al drammaturgo riflessioni del tutto anacronistiche (sebbene la crisi energetica, per esempio, fosse già realtà nell’Inghilterra elisabettiana). Possiamo usare Shakespeare per affrontare la crisi ambientale? Cosa ci direbbe, se potesse ragionarne con noi?
Shakespeare nei suoi drammi tende al nascondimento, non si mostra e non dà indizi sul proprio pensiero personale. Non sappiamo, ricorda Shaul Bassi, “cosa Shakespeare volesse dire; sappiamo cosa ha scritto e con le sue parole possiamo fare mille cose diverse”. È fin troppo facile precisare che, in realtà, i dubbi filologici anche su cosa esattamente abbia scritto si sprecano. Non è però di questo che il libro si occupa, muovendo dall’idea che ‘Shakespeare’ sia un universo fatto di testi preparati per la rappresentazione i quali, per la loro stessa natura, evanescente e impermanente, possono prestarsi alle più varie interpretazioni. Non si tratta di un libro didattico, ma si sente l’esperienza di chi ama insegnare e ‘fare cose’ in aula, trattando i testi senza troppa riverenza, non senza la giusta contestualizzazione, per il piacere di vederli rivivere: Bassi offre qui delle vere e proprie lezioni, nel senso di pubblici discorsi, dal tono colloquiale e accessibile. Il critico parla in prima persona e ragiona a voce alta con noi su alcuni dei drammi più noti, Amleto, Sogno di una notte di mezza estate, La tempesta, Re Lear, Il mercante di Venezia, Otello. Si sente in ogni rilettura ecocritica il dialogo che deve esserci stato tra l’autore e una generazione per la quale è diventato un obbligo fare i conti con il pensare nell’Antropocene (termine ormai consolidato, nonostante sia stato contestato nell’ambito delle scienze cosiddette dure).
Non si tratta affatto di dire che Shakespeare abbia previsto questo nostro tempo, ma di lasciare che alcune frasi echeggino in modo nuovo, come (per fare un solo esempio, forse il più ovvio, ma anche il più suggestivo) il lamento di Amleto, sono fin troppo sotto il sole. O permettere che alcune immagini lavorino in noi, come quella di Ofelia che cerca l’acqua: splendida l’immagine di copertina dell’artista Sara Lando, in cui un effetto speciale realizzato da muffe su carta fotografica ha creato una Ofelia che a me, per esempio, pare avvolta e strangolata da una piovra. È una voce, quella che si coglie in questo libro, piena di sapere ma anche schietta, che interpella e non esclude, e per questo raggiungerà, lo auspichiamo, anche un pubblico non strettamente accademico, che guarderà con occhi nuovi alla natura di Shakespeare, ma anche a certe sue lande desolate che hanno qualcosa da dirci, un monito da lasciare.
I. Plescia insegna lingua e traduzione inglese alla Sapienza Università di Roma
iolanda.plescia@uniroma1.it