Vocazioni gaddiane
recensione di Itala Vivan
dal numero di marzo 2017
Gianfranco Calligarich
LA MALINCONIA DEI CRUSICH
pp. 441, € 20
Bompiani, Milano 2016
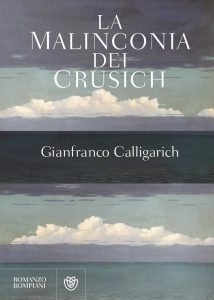
Triestini in Africa
I Crusich attraversano il primo e il secondo Grande Massacro, come vengono qui indicate le guerre mondiali, nonché la guerra d’Africa con relativa prigionia di Agostino, e il ventennio fascista, rimanendo ancorati alla loro inspiegabile malinconia e solo superficialmente curandosi dei contesti su cui mettono i piedi. L’Africa, poi, non è che un bel cartellone pubblicitario: l’idilliaca Asmara dai bianchi edifici frangiati di palme e dalla serenità “primordiale” insidiata dai “furenti selvaggi”, gli sciftà “neri come il buio della notte”, “i lenzuoli bianchi a farne fulminei e furibondi fantasmi”. Ancora una volta, la narrativa italiana che tocca la nostra storia coloniale ricade in consunti stereotipi. Accanto alle sagome indeterminate degli abitanti indigeni, il lavoro della colonizzazione che qui s’illumina di passione, “tanto che se un camion fosse stato qualcosa da sposare senza dubbio per lui [Agostino] sarebbe stato un Fiat 634. Alti tre metri e mezzo e lunghi quasi otto, dodici tonnellate di stazza e capaci di trasportare sul cassone anche un carro armato”.
Indifferenti al senso tragico dell’avventura coloniale, i Crusich non sembrano nutrire passioni civili durante la dittatura fascista, nel periodo della Resistenza (qui sempre chiamata “guerra civile” e dipinta come un indistinto azzuffarsi), e infine nel dopoguerra trascorso a Milano. Insomma, non certo una famiglia di eroi né di interpreti d’un secolo tanto drammatico. L’assenza di spessore storico viene compensata da una gran dovizia di dettagli di vite individuali, che però faticano ad animare il racconto e dopo la metà del romanzo addirittura lo soffocano in una ripetizione vuota della persistente malinconia del vivere e del morire.
Echi gaddiani in una storia coloniale
Il libro di Calligarich, tuttavia, si distingue per una accanita ricerca stilistica che sembra attingere all’esempio di Gadda. Quando Calligarich usa l’inversione (e lo fa lungo tutto il libro) non si può non riandare con la mente al timbro gaddiano. Per il vecchio Crusich, “Che la fortezza fosse una base navale inglese poteva stabilirlo dalla geometrica e arrogante bandiera bianca, rossa e blu che, in cima a un pennone, sembrava volersi imperialmente appropriare non solo della terraferma su cui era piantata ma anche del cielo azzurro in cui stava sventolando”. Nel racconto San Giorgio in casa Brocchi, Gadda scrive: “Che Jole, la cameriera del conte, uscisse ogni sera per far fare la passeggiatina a Fuffi (…); che, intanto, frotte di bersaglieri ritardatari trasvolassero in corsa (…); e che Jole, travista la monaca in tram, quella povera monaca le mettesse in tutte le vene un certo desolato sgomento: che tutto ciò accadesse, era, si potrebbe quasi arrischiare, nell’ordine quasi naturale delle cose, o, almeno, delle cose del 1928 p.C.”. Molti altri sono i risvolti espressivi che da Calligarich fanno risalire a Gadda, senza però che qui risuoni la nota profonda d’una cognizione del dolore che dava vastità e risonanza al mai concluso narrare gaddiano.
itala.vivan@unimi.it
I Vivan insegna studi culturali e postocoloniali all’Università degli Studi di Milano


