Sotto il velo, l’assurdo
recensione di Fausto Ciompi
dal numero di gennaio 2018
Hilary Mantel
OTTO MESI A GHAZZAH STREET
pp. 334, € 19
Fazi, Roma 2017
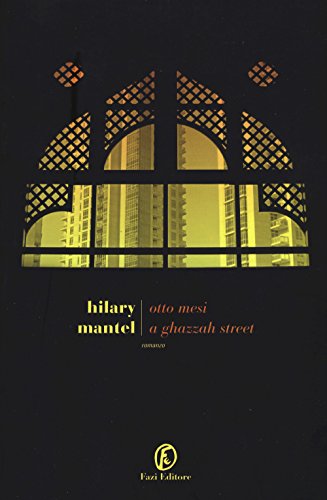 Ci sono almeno due modi di leggere Otto mesi a Ghazzah Street di Hilary Mantel, una delle scrittrici oggi più apprezzate in Inghilterra. Il modo più ovvio è prenderlo per un romanzo Baedeker, una guida all’alterità islamica, arabo-saudita, quale progressivamente si disvela alla sempre più inquieta osservazione di alcuni espatriati inglesi. Vecchia strategia: Mantel descrive una civiltà attraverso occhi estranei, stupendosi, come potrebbe un moderno Montesquieu che abbia letto il saggio di Said sugli abbagli del nostro orientalismo, di idiosincrasie e anacronismi. La seconda modalità di lettura, più sottile, è intendere il romanzo come una stralunata allucinazione metafisica che infine deflagra in non luoghi a seguito di non eventi. E, in effetti, cose misteriose, strane e persino perturbanti, accadono o sembrano accadere sotto i nostri occhi in spazi instabili, de-identitarizzati, arelazionali, quasi senza che ce ne accorgiamo o siamo in grado di razionalizzarle. Chi bazzica l’inaccessibile stanza del piano di sopra nel condominio di Ghazzah Street? Una coppia di amanti segreti, fratello di politicante lui, donna maritata lei? Cosa nasconde, semmai esista davvero, la cassa che appare e scompare dal terrazzo? Un cadavere? Che cosa faceva l’uomo con il fucile sulle scale del palazzo? Perché proprio questo pare di aver visto a Frances Shore, la protagonista della nostra storia. Sicché, stranezza dopo stranezza, cresce nel lettore la sensazione che il romanzo miri a transvalutare l’incertezza sugli eventi della quotidianità più trita in ontologia generale del dubbio, potente metafisica dell’assurdo o, come è parso a un critico, incubo orwelliano. E, almeno a tratti, l’upgrade riesce a Mantel.
Ci sono almeno due modi di leggere Otto mesi a Ghazzah Street di Hilary Mantel, una delle scrittrici oggi più apprezzate in Inghilterra. Il modo più ovvio è prenderlo per un romanzo Baedeker, una guida all’alterità islamica, arabo-saudita, quale progressivamente si disvela alla sempre più inquieta osservazione di alcuni espatriati inglesi. Vecchia strategia: Mantel descrive una civiltà attraverso occhi estranei, stupendosi, come potrebbe un moderno Montesquieu che abbia letto il saggio di Said sugli abbagli del nostro orientalismo, di idiosincrasie e anacronismi. La seconda modalità di lettura, più sottile, è intendere il romanzo come una stralunata allucinazione metafisica che infine deflagra in non luoghi a seguito di non eventi. E, in effetti, cose misteriose, strane e persino perturbanti, accadono o sembrano accadere sotto i nostri occhi in spazi instabili, de-identitarizzati, arelazionali, quasi senza che ce ne accorgiamo o siamo in grado di razionalizzarle. Chi bazzica l’inaccessibile stanza del piano di sopra nel condominio di Ghazzah Street? Una coppia di amanti segreti, fratello di politicante lui, donna maritata lei? Cosa nasconde, semmai esista davvero, la cassa che appare e scompare dal terrazzo? Un cadavere? Che cosa faceva l’uomo con il fucile sulle scale del palazzo? Perché proprio questo pare di aver visto a Frances Shore, la protagonista della nostra storia. Sicché, stranezza dopo stranezza, cresce nel lettore la sensazione che il romanzo miri a transvalutare l’incertezza sugli eventi della quotidianità più trita in ontologia generale del dubbio, potente metafisica dell’assurdo o, come è parso a un critico, incubo orwelliano. E, almeno a tratti, l’upgrade riesce a Mantel.
Viaggio a ritroso nella storia
Se il gioco non è spinto fino in fondo, è perché Mantel non è autrice di neppur lassa osservanza kafkiana o orwelliana. Più che a metafisiche apocalissi o onnipervasive distopie politiche, le viene naturale tener fede al modesto, inglesissimo senso del fuori posto. Non a caso Frances Shore fa la cartografa. È abituata a ordinare rigorosamente lo spazio: “Le piace trovare un senso al mondo compilando liste e scrivendo”. Ma, a Gedda, dove si è trasferita dall’Africa al seguito di un marito architetto attratto dalla prospettiva di lauti guadagni, ben presto scopre che le cartine della città sono inutili perché la realtà delle strade e degli edifici è, da sempre, impossibile da fotocopiare. Questa geografia mobile vive di una vita propria, incoercibile alla ragione. Gli edifici nascono e scompaiono nello spazio di un fiat. Le strade, anarchiche ed effimere, si ostinano a stare dove non dovrebbero, in barba agli sforzi dei cartografi. Se lo spazio è caos, il tempo è congelato e retroverso. Frances passa lunghe giornate, semireclusa nel suo appartamento, facendo poco o niente: ammazza scarafaggi, scrive un diario, cucina, leggiucchia, chiacchiera con le vicine islamiche, s’interessa ai costumi, alla dieta, alla vita affettiva e familiare di queste donne inspiegabilmente felici di vivere dietro porte serrate. Il tempo sembra sospeso in una stasi irreale, ma, in effetti, Frances sta compiendo un viaggio a ritroso nella storia. Al romanzo è del resto premessa una nota in cui si ricorda che il calendario islamico data a partire dal 622, quando Maometto si spostò dalla Mecca a Medina. Quando Frances arriva a Gedda, corre dunque l’anno 1405, ovvero il 1984 secondo il nostro calendario, sicché il tempo in Arabia Saudita sembra andare all’indietro. E subito Frances realizza che la sua esperienza è una reversione fino al cuore dello stato pre-moderno, nel quale le donne non escono da sole, non mostrano la nudità delle braccia, non testimoniano nei tribunali e possono essere congedate su due piedi dal marito che semplicemente pronunzi un performativissimo: “divorzio da te”.
Non sono solo le donne, però, a celarsi dietro un velo. “Era come se il mondo intero fosse velato”, ha scritto in un memoir la stessa Mantel rievocando i quattro anni da lei trascorsi in Arabia Saudita. C’era una cappa di convenzioni e rimozioni che tutto ovattava ed occultava finché la “maledetta realtà” esplodeva. La maledetta realtà esplode anche nella fiction di Otto mesi a Ghazzah Street. Corruzione politica, ipocrisia, deliberata manipolazione dei fatti da parte delle autorità producono una “tempesta” finale, come la definisce il nostro narratore. Ma le morte acque della routine levantina s’increspano appena a seguito di questi sconvolgimenti, per tornare subito all’inerzia consueta. Rimane, al più, un po’ di simbolico fango, nel quale continua stancamente a trascinarsi chi resta a Ghazzah Street. Per chi, come Frances, stremato e disilluso, alla fine parte, la realtà si fa invece vetrinata, derealizzata, omologata, come vuole la più tipica filosofia del non luogo. Attraverso il vetro di quattro finestre, nel finale del romanzo Frances scorge solo la superstrada, segno di una coazione al viaggio senza meta e senza prospettiva. Falso movimento. Incessante corsa verso la mercantilizzazione del paesaggio. Srealizzazione e perdita del sé, che si specchia nel proprio cupo negativo e si perde in non luoghi tutti uguali a tutte le latitudini, tutti parimenti insignificanti. Queste le modernissime suggestioni contenute nell’explicit del romanzo, che era invece cominciato, si ricorderà, come un tuffo nel passato.
fausto.ciompi@unipi.it
F Ciompi insegna letteratura inglese contemporanea all’Università di Pisa


