Quando si spezza la lastra di ghiaccio
recensione di Giuseppe Sertoli
dal numero di settembre 2016
Joseph Conrad
IL RITORNO
ed orig. 1898, trad. dall’inglese di Benedetta Bini (con testo inglese a fronte)
pp. 184, € 16
Marsilio, Venezia 2016
Nell’ultimo romanzo che scrisse e che lasciò incompiuto alla sua morte, Suspense (L’Indice 2013, n. 9), Conrad raccontò la storia, ambientata nella Genova del crepuscolo napoleonico, di una “gran signora” prigioniera di un matrimonio che si era rivelato un “fatale errore” e di un lussuoso palazzo nel quale viveva come in una “tomba sontuosa”. Questa storia, Conrad l’aveva desunta (quasi ricopiata) dalle Memorie di Adèle d’Osmond contessa de Boigne, aristocratica francese espatriata in Inghilterra al tempo della rivoluzione e diventata poi una delle più famose salonnières parigine negli anni della restaurazione borbonica, ma l’aveva rimodellata sulla vicenda di Isabel Archer, l’eroina (il termine non è fuori luogo) del Portrait of a Lady di Henry James, disegnando nella figura della protagonista il ritratto di una donna “radiosa” ma infelice, vittima di un matrimonio sbagliato che però lei sopporta con stoica abnegazione al fine di non venir meno a un impegno liberamente e pubblicamente assunto.
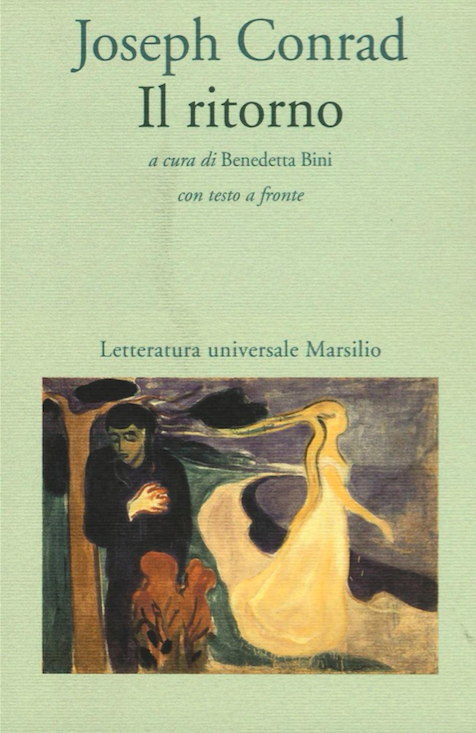 Non erano però solo le memorie della contessa e il romanzo di James a riecheggiare in Suspense: vi riecheggiava anche, sia pure più alla lontana, un racconto che Conrad aveva scritto quasi trent’anni prima, nel 1897, e che – rifiutato da più di una rivista per il suo argomento scabroso – aveva visto la luce nei Tales of Unrest pubblicati l’anno successivo. È questo racconto, Il ritorno, che oggi ci viene presentato in una nuova, elegante traduzione di Benedetta Bini, che vi ha preposto una altrettanto elegante prefazione tesa a rivalutare un’opera sulla quale Conrad stesso nutriva forti dubbi (arrivò persino a “vergognarsene”) e che tradizionalmente viene considerata la sua più anomala se non, addirittura, la peggiore che egli abbia scritto in tutta la sua carriera. Già nel 1966, però, in Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, Edward Said lo aveva giudicato – esagerando – il racconto più interessante degli esordi di Conrad, e dopo di lui non sono mancati altri, più sobri tentativi di rivalutazione. In ogni caso, qualunque sia il giudizio che se ne voglia dare, Il ritorno resta un testo assai poco “conradiano” nel senso che mette in scena un ambiente sociale – quello della upper middle class londinese – del quale Conrad non aveva la minima esperienza e che conosceva solo per sentito dire e per averne letto, oltre che sulla stampa scandalistica, in romanzi e racconti che hanno lasciato pesanti impronte “letterarie” nel suo testo. Impronte che vanno da Maupassant al sensation novel vittoriano, da James a Ibsen e magari a qualcos’altro che non è stato ancora individuato. Fra tutte, sono le ultime due a risultare le impronte più marcate.
Non erano però solo le memorie della contessa e il romanzo di James a riecheggiare in Suspense: vi riecheggiava anche, sia pure più alla lontana, un racconto che Conrad aveva scritto quasi trent’anni prima, nel 1897, e che – rifiutato da più di una rivista per il suo argomento scabroso – aveva visto la luce nei Tales of Unrest pubblicati l’anno successivo. È questo racconto, Il ritorno, che oggi ci viene presentato in una nuova, elegante traduzione di Benedetta Bini, che vi ha preposto una altrettanto elegante prefazione tesa a rivalutare un’opera sulla quale Conrad stesso nutriva forti dubbi (arrivò persino a “vergognarsene”) e che tradizionalmente viene considerata la sua più anomala se non, addirittura, la peggiore che egli abbia scritto in tutta la sua carriera. Già nel 1966, però, in Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, Edward Said lo aveva giudicato – esagerando – il racconto più interessante degli esordi di Conrad, e dopo di lui non sono mancati altri, più sobri tentativi di rivalutazione. In ogni caso, qualunque sia il giudizio che se ne voglia dare, Il ritorno resta un testo assai poco “conradiano” nel senso che mette in scena un ambiente sociale – quello della upper middle class londinese – del quale Conrad non aveva la minima esperienza e che conosceva solo per sentito dire e per averne letto, oltre che sulla stampa scandalistica, in romanzi e racconti che hanno lasciato pesanti impronte “letterarie” nel suo testo. Impronte che vanno da Maupassant al sensation novel vittoriano, da James a Ibsen e magari a qualcos’altro che non è stato ancora individuato. Fra tutte, sono le ultime due a risultare le impronte più marcate.
Da James, di cui aveva appena letto con entusiasmo The Spoils of Poynton, Conrad riprende la tecnica della focalizzazione interna al fine di restituire con più forza e aderenza lo stato d’animo del protagonista del racconto, un ricco uomo d’affari che, rientrando una sera a casa, trova una lettera della moglie dalla quale apprende che lei lo ha lasciato per un altro uomo. Conrad, però, maneggia male lo strumento adottato, mescolando focalizzazione interna ed esterna senza nemmeno farsi scrupolo di inserire impropri giudizi autoriali. A ragione Benedetta Bini sottolinea lo “sperimentalismo” di questa e di altre short stories scritte da Conrad nello stesso periodo: volendo scrollarsi di dosso l’etichetta di autore di adventure stories esotiche appioppatagli dai recensori dei suoi primi due romanzi, egli cerca di cambiare strada “provando” scenari, trame, tipologie di personaggi e metodi narrativi nuovi e diversi. E se i risultati sono abbastanza deludenti – cosa di cui Conrad stesso dovette rendersi conto perché in seguito non ripeterà i medesimi errori –, ciò non deve impedirci di cogliere quanto di valido, e magari di inatteso, Il ritorno ha da offrirci.
Per quel che riguarda Ibsen, va ricordato che Conrad, pur non amando il teatro (dove diede prove modestissime) si riconosceva una “immaginazione teatrale”, ed è questa immaginazione a fargli costruire Il ritorno come una pièce in tre atti che, dopo un prologo in esterni (le strade di Londra e la stazione della metropolitana), si svolge tutta all’interno della casa del protagonista, i cui ambienti e arredi fanno da cornice simbolica al doppio dramma che il racconto mette in scena. Di due drammi, infatti, si tratta: da un lato quello del marito, che scoprendosi abbandonato dalla moglie si sente crollare il mondo sotto i piedi (atto I), dall’altro lato quello della moglie, il cui improvviso ritorno segna l’avvio di un confronto verbale fra i due personaggi (atti II e III) che appare palesemente indebitato a Casa di bambola, di cui Il ritorno è al tempo stesso un’imitazione e un ribaltamento. L’intreccio di questi due drammi consente a Conrad, da un lato, di mettere a nudo l’ipocrisia e il cinismo dell’etica borghese (ed è l’aspetto sicuramente meno originale del racconto), e dall’altro – ciò che forse sorprenderà i lettori che hanno nell’orecchio i troppi luoghi comuni sul (presunto) “misoginismo” conradiano – offre una dolente rappresentazione della condizione della donna all’interno del matrimonio. Dei due drammi, infatti, quello del marito e quello della moglie, è quest’ultimo a costituire il vero cuore del racconto, un cuore tanto più intimo quanto meno esibito.
Esibito – non senza enfasi retorica ed eccessi melodrammatici imputabili all’inesperienza di Conrad – è il dramma di Alan Hervey (questo il nome del protagonista): un dramma che anticipa singolarmente (lo si è spesso notato) la vicenda di Kurtz che Conrad metterà in scena di lì a poco in Cuore di tenebra. Il contesto certo è diversissimo, ma la corrispondenza fra i due testi è indubbia ed è avvalorata da numerosi parallelismi verbali che non possono sfuggire all’attenzione di un lettore minimamente attento. La decisione della moglie di uscire di casa produce infatti su Hervey il medesimo effetto prodotto su Kurtz dalla wilderness africana: il collasso di tutto ciò che aveva sostenuto e nutrito la sua idea di sé e la sua stessa vita. Quando la lastra di ghiaccio su cui lui e la moglie avevano fin a quel momento pattinato si spezza, nell’abisso che si spalanca al di sotto sprofonda non solo la finzione/menzogna del loro matrimonio ma l’intera ideologia di una classe e di una società che in quel matrimonio si erano “rappresentate”. La stentorea retorica con cui Hervey reagisce al disastro accusando la moglie di avere criminalmente attentato ai “valori” del loro mondo ha lo stesso suono della retorica con cui Kurtz, nella Relazione per la soppressione dei costumi selvaggi, esalterà la missione civilizzatrice dell’imperialismo occidentale. Ma come lo scarabocchio finale sull’ultima pagina di quella relazione – “Sterminate tutti i bruti” – sarà la drammatica presa di coscienza della menzogna dell’ideologia imperialistica, così l’enfasi vociferante e scomposta di Hervey maschera appena l’affiorare di una nuova consapevolezza da cui discende la (peraltro ambigua) conclusione del racconto. Al termine del lungo, acrimonioso confronto con la moglie, nel cuore della notte Hervey uscirà di casa chiudendosi il portone alle spalle e, lui, non farà ritorno.
Nell’analisi più circostanziata e minuziosa che a tutt’oggi sia stata dedicata, in ogni lingua, a questo racconto (Riflessioni e rifrazioni di un borghese allo specchio, Forum, 2009), Roberta Borgna propone di leggere la conclusione come l’esito di un “processo di rinascita morale e sociale” che permette al protagonista di riscoprire quei valori dell’“amore” e della “fiducia” che, nelle ultime pagine, riempiono i suoi pensieri. Anche Benedetta Bini sembra incline a credere qualcosa del genere. Ma è davvero per questo che Hervey alla fine esce di casa: perché si rende conto – dopo che la moglie ha respinto con disprezzo le sue professioni d’amore (“Ti illudi. Tu volevi solo una moglie che pensasse, parlasse e agisse in un certo modo. Tu ami solo te stesso…”) – che in quella casa non c’è spazio per una (nuova) vita fondata su un rapporto di reciproco amore e fiducia? Nel momento in cui giustifica la propria decisione con l’argomento che la moglie “non ha il dono” dell’amore e della fiducia, Hervey non sta forse continuando a criminalizzarla facendo ricadere su di lei la colpa della fine del loro matrimonio? Perché, quel “dono”, lo pretende da lei e non è lui, invece, a darglielo per primo? La tenebra che nelle ultime bellissime pagine Hervey sente salire avvolgendo a poco a poco la casa, e che imputa all’incapacità della moglie di offrirgli quell’amore e quella fiducia che lui si aspetterebbe da lei, non è forse proprio lui a generarla col suo – immutato – egoismo ed egocentrismo? Se è così, allora anche nell’uso di questo dettaglio – di questa metafora – Conrad anticipa quanto farà in Heart of Darkness mostrando come la tenebra attribuita all’Africa sia in realtà quella che l’Europa esporta oscurando il cuore bianco dell’Africa.
Non ambigua, invece, è la conclusione del dramma di colei che nel racconto non ha nome perché è soltanto la “signora Alvan Hervey” (a riprova che nel mondo a cui i due protagonisti appartengono la moglie è una semplice appendice del marito o, meglio, una delle sue tante “proprietà” – come infatti Hervey l’ha sempre considerata). Un dramma, quello della “signora Hervey”, affidato alle poche, smozzicate parole che riesce a opporre alla verbosità incalzante del marito, alla sua rancorosa volontà di sapere: “È stato un errore… mi sono ingannata… non ho potuto… non ho avuto la forza”. Troppo tardi ha scoperto la finzione/menzogna del loro matrimonio e ha cercato di liberarsene con un atto che, però, si è rivelato superiore alle sue possibilità e l’ha costretta a tornare sui suoi passi. A tornare sconfitta ma consapevole – e lo dice – che proprio tale ritorno è ciò che non si perdonerà mai, perché è la pietra caduta sulla sua ultima chance di vita. Incarnazione, nella sua muta angoscia, del “nudo dolore dell’esistenza” (quasi il montaliano male di vivere declinato al femminile), è però pronta ad accettarlo. Al marito che le chiede se riuscirebbe a sopportare “tutto questo”, la sua risposta è sì: “Sì, lo posso”. Lo sopporterebbe – ha già cominciato a sopportarlo – con la “calma disperazione” che era stata della Isabel Archer di Ritratto di signora e che sarà di Adèle d’Armand in Suspense. Gli errori si pagano, tanto più se conseguenza di illusioni che ci si è fatti su se stessi. Lo sanno bene i personaggi conradiani, da Almayer a Jim a Heyst, e lo sa anche la protagonista di questo racconto. Proprio per questo, a differenza della Nora di Casa di bambola, non sarà lei ad andarsene chiudendosi alle spalle la porta di casa. Se ne andrà il marito – che in quanto uomo in una società di uomini può ciò che la donna non può – e la porta che egli si chiuderà alle spalle sarà la stessa che rinchiuderà lei, la moglie, nella “tomba oscura” della casa.
gsertol@tin.it
G Sertoli è professore emerito di Letteratura inglese all’Università di Genova


