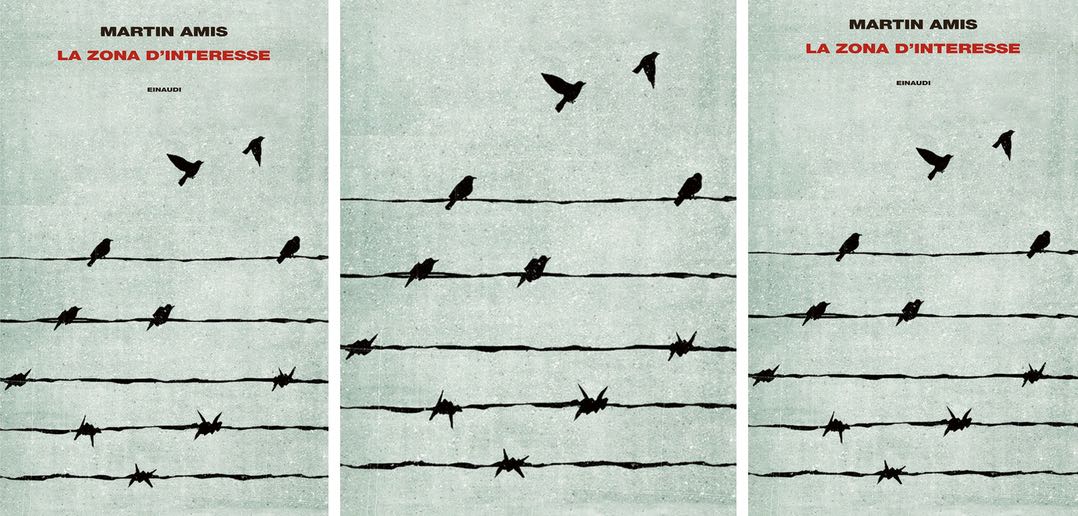Quell’incancellabile odore
recensione di Daniela Fargione
dal numero di dicembre 2015
Martin Amis
LA ZONA D’INTERESSE
ed. orig. 2014, trad. dall’inglese di Maurizia Balmelli,
pp. 306, € 20,
Einaudi, Torino 2015
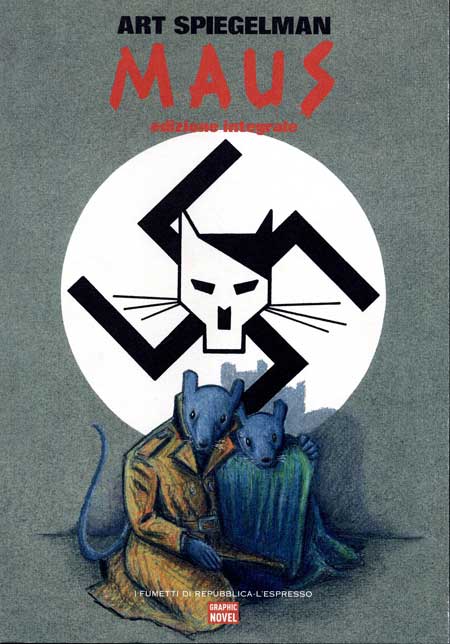 Quando a dieci anni dal suicidio della madre, sopravvissuta insieme al marito Vladek allo sterminio nazista, Art Spiegelman cominciò a disegnare gatti e topi, rane e maiali per illustrare la pagina più insensata della storia dell’umanità, nessuno (tantomeno lui) avrebbe mai immaginato che Maus (Einaudi 2000) sarebbe diventato un capolavoro. Com’era possibile descrivere l’orrore del lager senza scadere nell’osceno? E com’era possibile adoperare un linguaggio persuasivo capace di fornire rigorosa aderenza storica e dissipare, al contempo, le nostre più salde incrostazioni mentali? Dopo un lungo lavorio durato tredici anni, tra viaggi in Europa, continue riscritture e schizzi abbozzati su innumerevoli taccuini, Spiegelman era approdato a quel risultato: attraverso la stratificazione cronologica degli eventi e un lirismo calibrato dal dosaggio delle emozioni (forse, col passare degli anni, persino dal disincanto nei confronti della compassione), il suo graphic novel era riuscito a restituire l’integrità dell’inferno e i suoi minuscoli frammenti di umanità. E, soprattutto, era riuscito a restituire al suo ideatore non solo la testimonianza di un padre scomodo che “sanguina storia”, ma anche il senso stesso del proprio ruolo di memorialista obbligato a fare i conti con eredità storica ed eredità biologica. Ma i conti, si sa, non si fanno mai una volta per tutte quando si tratta di Olocausto.
Quando a dieci anni dal suicidio della madre, sopravvissuta insieme al marito Vladek allo sterminio nazista, Art Spiegelman cominciò a disegnare gatti e topi, rane e maiali per illustrare la pagina più insensata della storia dell’umanità, nessuno (tantomeno lui) avrebbe mai immaginato che Maus (Einaudi 2000) sarebbe diventato un capolavoro. Com’era possibile descrivere l’orrore del lager senza scadere nell’osceno? E com’era possibile adoperare un linguaggio persuasivo capace di fornire rigorosa aderenza storica e dissipare, al contempo, le nostre più salde incrostazioni mentali? Dopo un lungo lavorio durato tredici anni, tra viaggi in Europa, continue riscritture e schizzi abbozzati su innumerevoli taccuini, Spiegelman era approdato a quel risultato: attraverso la stratificazione cronologica degli eventi e un lirismo calibrato dal dosaggio delle emozioni (forse, col passare degli anni, persino dal disincanto nei confronti della compassione), il suo graphic novel era riuscito a restituire l’integrità dell’inferno e i suoi minuscoli frammenti di umanità. E, soprattutto, era riuscito a restituire al suo ideatore non solo la testimonianza di un padre scomodo che “sanguina storia”, ma anche il senso stesso del proprio ruolo di memorialista obbligato a fare i conti con eredità storica ed eredità biologica. Ma i conti, si sa, non si fanno mai una volta per tutte quando si tratta di Olocausto.
Questo duplice ingombro, infatti, era tornato in L’ombra delle torri (Einaudi, 2004) che, raccontandoci l’orrore dell’11 settembre, ci aveva fatti ripiombare nel baratro del lager. In alcune scarne tavole in bianco e nero, il topo Art scivola in una dolente sacca della memoria e sovrappone l’Auschwitz del padre alla lower Manhattan degli attentati: l’aria tremenda di Ground Zero ha lo stesso “indescrivibile” odore del fumo dei camini e sa di “amianto, di fenile, piombo, diossine e brandelli umani…”. Eppure la restituzione di questo trauma collettivo era risultata inizialmente scabrosa, l’ondata di ironia corrosiva che investiva la politica americana troppo irriverente, al punto da rendere impossibile il consenso unanime degli editori.
La zona d’interesse
È curioso come tutte queste vicende accomunino due artisti tanto diversi quanto Art Spiegelman e Martin Amis. Anche per quest’ultimo, infatti, si solleva un polverone per il suo nuovo romanzo sulla Shoah, La zona d’interesse, tanto che Gallimard in Francia e Hanser Verlag in Germania si rifiutano di pubblicarlo malgrado l’accuratissima ricostruzione storica e la decisione di evocare, senza mai menzionare, tutti i personaggi di spicco. Quel nome, per esempio, non è mai citato. Occorre giungere alla postfazione perché Adolf Hitler faccia la sua comparsa scortato da virgolette; solo così, infatti, “sembra leggermente più gestibile”. Smessi i panni del romanziere, in Quel che è accaduto Amis indossa quelli del ricercatore, e squaderna una mole consistente di letture per ribadire tutta la sua incredulità. L’ingresso in scena del “Liberatore” è inevitabile quando si rende esplicita l’ineluttabile domanda che attraversa strisciante l’intera narrazione: “perché?”. “Qui non c’è perché” è la risposta, la stessa – ricorda Amis – che si sente dare Primo Levi nel febbraio 1944, quando, appena arrivato ad Auschwitz, spogliato, lavato, rasato, tatuato e rivestito di stracci, apre una finestra della baracca in cui sono stati ammassati i prigionieri italiani. Il suo audace tentativo di afferrare un ghiacciolo e attenuare l’arsura è vanificato dal gesto brutale di una guardia che glielo strappa di mano, ricacciandolo dentro con uno spintone. “Warum?”, gli domanda Levi. “Hier ist kein Warum” si sente rispondere.
Se la conclusione a cui Amis approda (e non senza una certa cautela) è che “l’unicità del Terzo Reich risiede nella sua inflessibilità, nell’elettrica severità con cui respinge i nostri tentativi di contatto o comprensione”, l’allineamento con Michael André Bernstein lo induce a scrivere che “il genocidio nazista è centrale per la nostra comprensione di noi stessi”. Lo aveva già suggerito nel 1990, quando con La freccia nel tempo – la storia a ritroso di un medico nazista e delle torture inflitte agli ebrei – era stato candidato al Booker Prize e riconosciuto quale scrittore più scomodo dell’intero olimpo letterario britannico. Con La zona d’interesse, che Maurizia Balmelli traduce con consueta precisione restituendo integralmente la sua urticante sgradevolezza, Amis torna ad affilare la lama del dark humor per affondarla in una carne marcia e maleodorante. Ruvido (tutte quelle parole conservate nella versione tedesca), spesso tranciante, talvolta persino grossolano, dimostra per l’ennesima volta la sua idiosincrasia per tutto ciò che odora di convenzione ed è il fetore, in effetti, ciò che ci investe per primo, a partire da quello dell’acqua tanto agognata dai prigionieri ma che “sa di carogna”.
L’odore della cattiveria
E poi c’è l’odore nel Blocco 4 (VI), l’odore acre di putrefazione del Prato di Primavera e quello diffuso dalle ciminiere “di cartone misto a marciume bagnato”, il “fetore della fame” e il “sentore strisciante di urina” e, alla fine, persino quello del respiro pesante di Berlino che soffre per l’appunto di alitosi, un odore così diverso da quello buono, all’inizio del romanzo, degli ariani. Perché è questa la prospettiva da cui Amis racconta le vicende del Kat Zet (abbreviazione di Konzentrationslager, la zona d’interesse entro cui vivono i tedeschi e alcune loro famiglie) per bocca di tre personaggi: Angelus “Golo” Thomsen, nipote del segretario privato di Hitler e collaboratore presso l’azienda chimica IG Farben; Paul Doll, il Comandante del campo e “uomo normale con sentimenti normali”, e l’ebreo polacco Szmul, uno dei Sonderkommando incaricati di riempire e svuotare le camere a gas del campo e pertanto “infinitamente disgustosi, e anche infinitamente tristi”. Sarà il corrotto e spregevole Doll a intuire che si tratta né più né meno dell’odore della cattiveria: “Se quella che stiamo facendo è una cosa buona, perché ha un odore così pervicacemente cattivo?… Perché facciamo diventare marrone la neve? Perché facciamo questo? Rendere la neve simile a merda d’angelo?”. E sarà ancora per via di quell’odore che sua moglie Hannah, una “sorta di Giove di erotica gravità”, pur illudendosi di vedere in Thomsen “la decenza e la normalità e la civiltà” e intrattenendo con lui un perverso gioco di corrispondenze amorose, dopo la sconfitta della Germania fa perdere le tracce di sé. Dopo anni di ricerche, Thomsen riesce a scovarla, ma solo per sentirsi dire che è tempo di arrendersi: “Quando la vedo sono di nuovo là. Quando la vedo sento l’odore. E non voglio sentire l’odore”. Ma si sbaglia Frau Doll quando si arroga il diritto di sentirsi una vittima, persino quando diventa consapevole di essere stata sposata a uno dei più prolifici assassini della storia: “Solo una vittima ha il diritto di dire che da lí non c’è possibilità di ritorno… Lei ha forse perso i capelli e la metà del suo peso? Ride forse ai funerali perché fanno tante storie per un solo morto? La sua vita è mai dipesa dallo stato delle sue scarpe?” le spiattella crudelmente Thomsen.
La vittima per eccellenza è il “fidatissimo” Szmul, il “corvo del crematorio” e terzo io narrante del libro. È di nuovo Primo Levi a ricordare in I sommersi e i salvati che l’organizzazione dei Sonderkommando “è stato il delitto più demoniaco dei nazionalsocialisti” poiché era su di loro, sulle vittime, che “si spostava il peso della colpa, talché, a loro sollievo, non rimanesse neppure la consapevolezza di essere innocenti”. Quella consapevolezza, Szmul, non la perde, e neanche la speranza nella quale imbeve il pennino per lasciare di sé, della sua esistenza, una traccia scritta che seppellirà in un thermos sotto l’arbusto di uva spina: “E per questa ragione non tutto di me morirà”. Nemmeno il suo incancellabile odore.
daniela.fargione@unito.it
D Fargione insegna lingua e letteratura angloamericana all’Università di Torino