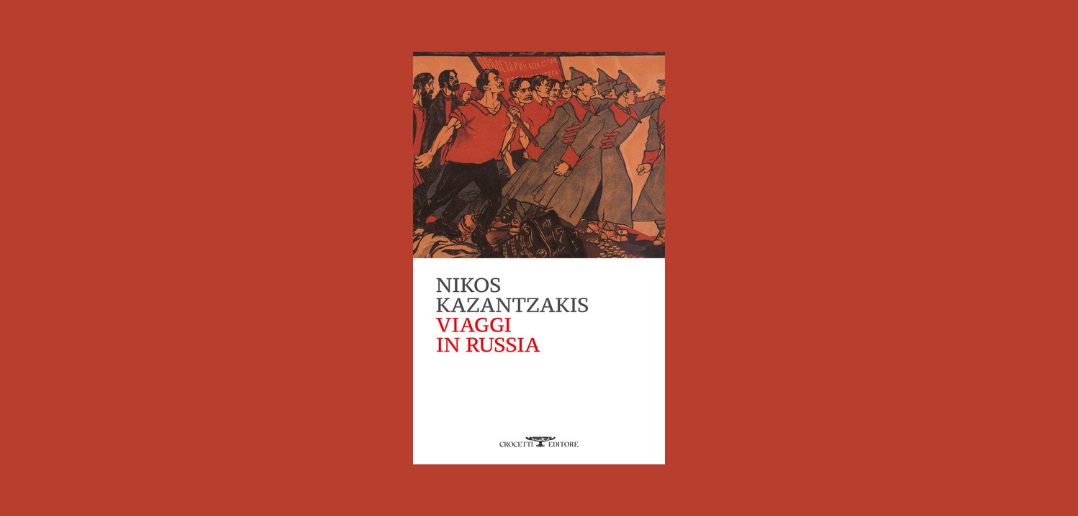Nikos Kazantzakis
VIAGGI IN RUSSIA
ed. orig. 1956, trad. dal greco e introd. di Gilda Tentorio,
pp. 304, € 18,
Crocetti, Milano 2025
Trovare la verità tra cartone, attori e balalaike
di Giulia Baselica
Lenin è morto da circa un anno e l’autorità di Stalin si afferma gradualmente, ma con inesorabile forza, in un contesto dominato da conflitti economici e da violenti contrasti interni al partito, quando – tra l’ottobre del 1925 e il gennaio del 1926 – Nikos Kazantzakis visita il paese dei soviet. Se per i bolscevichi la diffusione della cultura e la formazione di una propria intelligencija sono un dovere imprescindibile, permane tuttavia mediocre il livello culturale della stampa ufficiale e delle manifestazioni pubbliche volte a incoraggiare le masse a un ateismo militante.
Sono gli anni della Nuova politica economica, esperimento avviato da Lenin nel 1921 in sostituzione del comunismo di guerra e abolito da Stalin nel 1929: viene reintrodotta la piccola proprietà privata, soprattutto in agricoltura, mentre alle imprese, benché totalmente nazionalizzate, è concesso il diritto all’autonomia gestionale. Ma al successo produttivo ed economico della Nep si contrappone l’esplosione di nuovi conflitti sociali, determinati soprattutto dall’operato dei soggetti arricchitisi con il libero commercio.
L’autore dei Viaggi in Russia incontra dunque un “paese pioniere”, nel quale il comunismo non si è ancora realizzato e dove è talvolta “necessario l’uso della forza” per risolvere definitivamente – e al tempo stesso – due situazioni problematiche: l’industrializzazione e la questione contadina. L’originalità degli scritti di viaggio che Kazantzakis dedica alla Russia risiede, almeno in parte, nell’individuazione del ruolo svolto dallo “Spirito dell’epoca storica […] – terribile, insanguinato, assetato di luce, spietato”. È dunque il Weltgeist, lo Spirito assoluto – celebre intuizione hegeliana – ad aver determinato, nella visione di Kazantzakis, la distruzione della vecchia Russia imperiale e i presupposti per l’edificazione della nuova Russia sovietica.
Già negli anni trenta e quaranta dell’Ottocento, intorno all’azione dello Spirito della storia, si era animato il dibattito dell’allora nascente intelligencija, divisa fra slavofili e occidentalisti. Se nella “rossa arena del Cremlino” Kazantzakis riconosce i segni della lotta fra due “forze eterne, antagoniste e alleate, cioè lo Spirito e la Materia”, nell’intera città egli avverte la fatica e la tenacia dei russi determinati ad assoggettare il caos orientale, dentro e fuori di loro, in “un’Idea rigorosa e assemblata secondo la logica”. Ammira Lenin, che ha salvato “l’Idea sovietica” nel difficile confronto con l’atteggiamento antirivoluzionario dei contadini, ed elogia l’operato di Stalin – senza poter immaginare che di lì a pochi anni, tra il 1930 e il 1931, avrebbe avuto luogo una violentissima campagna repressiva contro i contadini che avessero opposto resistenza alla collettivizzazione – per favorire “l’applicazione pacificata dell’Idea”.
Nelle pagine che l’autore riserva alla letteratura russa – della quale è profondo e appassionato conoscitore – lo Spirito, l’Idea acquisisce la sua più compiuta fisionomia e diventa Logos, condannato al martirio in particolare dopo la svolta reazionaria di Caterina II in seguito alla rivoluzione francese e durante il brevissimo regno del successore, Paolo I. Kazantzakis pensa “con reverenza alla linea sanguinosa tracciata dal Logos durante l’impero degli zar, immerso nella barbarie e nella tirannia” e comunque determinato ad avanzare “insanguinato ma immortale” per ispirare i poeti e i prosatori della Rivoluzione, autentici capi spirituali, e a infondere in loro la forza per esprimere un insopprimibile anelito di libertà. In Russia, dunque, a partire dalle parole, lo Spirito si è concentrato nell’azione, conclude Kazantzakis. Del teatro ebraico russo, sul quale si concentra in modo particolare, egli ammira l’espressione di “un Logos elevato e sobrio”, che rinuncia alla ricerca estetica, ma permette all’Idea di “salire in scena, combattere i nemici e trionfare”.
La sua lettura della realtà russa, ancorché nutrita di ammirazione ed entusiasmo, non è tuttavia priva di lucidità rigorosa. Kazantzakis incontra una “Russia crocifissa”, una Russia che soffre, condannata a sacrificare innumerevoli vite negli anni della transizione, quando “la libertà del Logos deve sottostare alla Necessità”. Se da un lato Mosca gli appare come la “nuova Gerusalemme del dio operaio”, dall’altro la capitale è l’immensa vetrina di una Russia “fatta di cartone, attori e balalaike”, dominata da una religione nuova, l’ateismo, che si sostituirà alla vecchia, ormai languente, ma altrettanto mistica e dogmatica, oltre che selvaggia e spietata.
Kazantzakis si avvicina alla Russia con l’intento di “trovare e riferire la verità”, spinto da una visione nuova, incontaminata dai pregiudizi che fino a quel momento avevano condizionato lo sguardo dei viaggiatori europei. Coglie la distanza – a tratti incolmabile – tra l’anima slava e l’anima occidentale: se il russo sa conciliare dentro di sé “antinomie incomprensibili”, l’europeo “sopra ogni cosa pone la mente lucida, la sequenza logica, la feconda applicazione pratica del concetto astratto”. Ma lo scrittore e viaggiatore greco proviene da una cultura altra, che circa dodici secoli fa stabilì con il primo Stato russo un dialogo fecondo, potente ispiratore dei valori su cui si fondò una civiltà rinnovata, un’epoca di fioritura artistica e di sviluppo dei saperi: un’epoca di pace.
G. Baselica insegna lingua e letteratura russa all’Università di Torino
giulia.baselica@unito.it
Da un estremo all’altro dell’anima
di Jacopo Mosesso
Fino a circa un decennio fa in Italia Kazantzakis era noto soprattutto per una parte della sua produzione letteraria: i romanzi. Di questi il più famoso è Zorba il Greco (Crocetti, 2021) che, anche grazie alla sua trasposizione cinematografica, ha contribuito a delineare alcuni tratti con cui la Grecia moderna si presenta – forse ingiustamente idealizzata o trasfigurata – nell’immaginario collettivo di chi la osserva dall’esterno.
Con una recente inversione di tendenza, in particolare grazie a Crocetti, è finalmente accessibile al pubblico italiano un’altra parte importante e meno conosciuta dell’opera di Kazantzakis. Tra le varie nuove traduzioni, degna di nota è quella dell’Odissea (Crocetti, 2020), recensita su “L’Indice”, 2021, n. 4. Dei resoconti di viaggio, invece, Viaggi in Russia è il terzo che Gilda Tentorio traduce in italiano, affrontando le peculiarità della lingua kazantzakiana – vernacolare e ricca di dialettalismi, ma raffinata – con grande cura del dettaglio, scelte traduttive mai lasciate al caso e profonda conoscenza dell’autore.
Il libro non ripercorre cronologicamente un viaggio lineare, ma raccoglie una serie di scritti prodotti in quattro viaggi fatti a seguito della rivoluzione d’ottobre tra Mosca e San Pietroburgo, oltre che in varie località dell’attuale Ucraina, Azerbaigian e Georgia, tra il 1919 e il 1929, principalmente con lo scopo di riportare in Grecia notizie e riflessioni sugli esiti dell’esperimento comunista.
Anche a chi non abbia familiarità con la vasta opera di Kazantzakis, Viaggi in Russia può offrire un ampio sguardo sul pensiero e sulla poetica dell’autore. L’esperienza russa stimolò la sua creatività al punto che su di essa si basano anche altre opere in aperto dialogo tra loro, come il romanzo Toda-Raba (1934), non tradotto in Italia, la Storia della letteratura russa (1930: Edizioni Studio Tesi, 1990) e un capitolo importante del testamento letterario Rapporto al Greco (1957: Crocetti, 2022). Talora entusiasta per la primordiale e “barbara” vitalità che vede nel popolo russo intento a demolire il presente per creare un nuovo futuro, talora profondamente disilluso – scorgendo seri limiti sia etici sia pratici nell’utopia rivoluzionaria – Kazantzakis articola nei Viaggi in Russia il suo pensiero “metacomunista”, giudicato da molti incomprensibile o addirittura blasfemo.
Tentando di rimanere oggettivo, condivide con noi ciò che lo seduce e ciò che lo inquieta della Russia di un secolo fa, consapevole di assistere – come forse anche noi oggi – a un momento critico per le sorti di Oriente e Occidente. A cavallo tra questi due mondi egli sente di poter collocare la propria identità di cretese e di greco, sospesa tra Europa e Asia, tra antichità classica e modernità. Confrontandosi con la varietà culturale che costituisce l’immenso mosaico del popolo russo, Kazantzakis si rispecchia nel calore e nella cordialità fraterna che riconosce in questo popolo d’Oriente.
Con ironia parla della propria grecità ai russi che incontra, come quando durante una lezione di sociologia all’Università comunista di Mosca si fa rimbrottare da un giovane professore che sostiene che il sorriso delle korai dell’Acropoli di Atene sia da ricondurre al benessere economico della Grecia antica. A quell’idea reagisce divertito, poi si giustifica sardonico: “Vi assicuro, compagno professore, che il mio sorriso non è dovuto a cause economiche”. Assistendo al cambiamento storico innescato dalla rivoluzione russa e attraversando gli ampi territori in essa coinvolti, Kazantzakis si accorge di aver ripensato la sua idea del mondo, della libertà individuale e collettiva, e di vedere con occhi nuovi la forza dell’ideologia e della scrittura, per lui trascendente fonte di salvezza che dà un senso poetico all’esistenza umana: “Era la fine del viaggio. La Russia, dalle nevi di Mosca fino al caldo sole di Batumi, brillava ora immortale nella nostra mente, come se avessimo viaggiato da un estremo all’altro della nostra anima”.
J. Mosesso è dottorando di letteratura italiana all’Università di Atene
jacopo.mosesso@gmail.com