Quando gli afghani cacciarono gli inglesi
recensione di Luigi Marfé
dal numero di novembre 2015
William Dalrymple
IL RITORNO DI UN RE
La battaglia per l’Afghanistan
ed. orig. 2002, trad. dall’inglese di Svevo D’Onofrio
pp. 663, € 34
Adelphi, Milano 2015
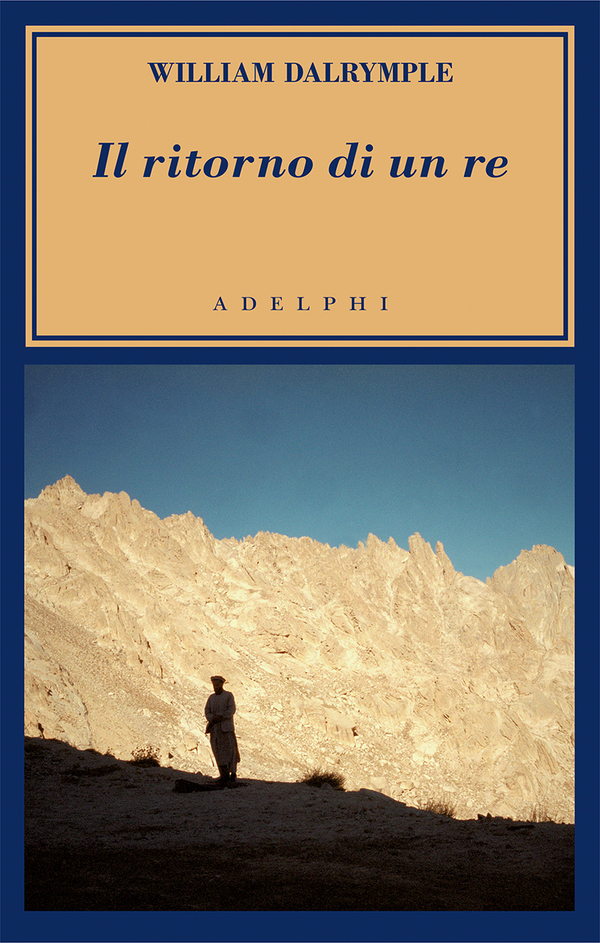 “Porterete un esercito nel nostro paese. Ma come pensate di riportarlo fuori?”. Più o meno così, pare, si sarebbe sentito apostrofare Alexander Burnes, viaggiatore, spia e diplomatico inglese, autore di Travels into Bokhara (1834) – la bibbia di Robert Byron e di tutti i viaggiatori in Asia centrale – da un signore della guerra del Khorasan, più o meno corrispondente all’attuale Afghanistan, alla notizia dell’invasione britannica del 1839.
“Porterete un esercito nel nostro paese. Ma come pensate di riportarlo fuori?”. Più o meno così, pare, si sarebbe sentito apostrofare Alexander Burnes, viaggiatore, spia e diplomatico inglese, autore di Travels into Bokhara (1834) – la bibbia di Robert Byron e di tutti i viaggiatori in Asia centrale – da un signore della guerra del Khorasan, più o meno corrispondente all’attuale Afghanistan, alla notizia dell’invasione britannica del 1839.
Stava allora entrando nel vivo il “grande gioco” per il controllo dell’Asia centrale: una partita diplomatica fondata sulla paura reciproca, che per quasi un secolo avrebbe portato inglesi e russi a scatenare rovinose imprese militari e a sperperare enormi risorse finanziarie senza alcun costrutto. Del resto, come avrebbe poi osservato Rudyard Kipling alla fine di Kim (1901), con la consueta, laconica crudeltà, “il Grande Gioco è concluso quando sono morti tutti. Non prima”.
Storico, orientalista e scrittore di viaggio scozzese, William Dalrymple è autore di numerosi libri sul subcontinente indiano e sull’Asia centrale, come Nella terra dei Moghul bianchi (Rizzoli, 2002) e Nove vite (Adelphi, 2011). Con Il ritorno di un re, appena uscito da Adelphi nell’ottima traduzione di Svevo D’Onofrio, si concentra ora su un episodio centrale di questo “grande gioco”: la prima guerra anglo-afghana (1839-1842), tra le peggiori disfatte della storia dell’impero britannico.
Inviato a Kabul per sorvegliare le intenzioni dei russi, Burnes cercò in ogni modo di evitare l’invasione britannica. Del resto, chiunque conoscesse la situazione afghana sapeva che la guerra avrebbe portato soltanto guai. La stessa Compagnia delle Indie Orientali era stata a lungo restia a impegnarsi su uno scacchiere così periferico. Ma la comparsa di una spia russa, l’ineffabile Alexander Vitkevic, mutò lo scenario. I falchi dell’amministrazione inglese soffiarono sul fuoco, vagheggiando l’esistenza di acerrime armate russe pronte a fiondarsi sull’India. L’intervento divenne inevitabile e per l’occasione fu tirato fuori un re deposto anni prima, Shah Shuja, ultimo erede di Tamerlano, da imporre come sovrano fantoccio.
La conquista fu rapida. Il sovrano afghano, Dost Mohammad, si affrettò a proclamare il jihad contro gli infedeli, ma le tribù afghane, vedendo la forza degli inglesi, passarono dalla parte di Shuja. Il “ritorno del re”, tuttavia, fu seguito da problemi insolubili. L’occupazione inglese si rivelò un fallimento. Le tribù furono umiliate e portate all’esasperazione. Nell’autunno 1841 scoppiò la rivolta e, in un crescendo di incomprensioni e di inerzia, la situazione sfuggì di mano. Gli inglesi dovettero negoziare una ritirata umiliante con Akbar Khan, figlio di Dost Mohammad, che si risolse in uno stillicidio di agguati nelle gole verso Jalalabad, come mostra il quadro Remnants of an Army (1879) di Elizabeth Thompson, in cui è raffigurato lo sconsolato caracollare di un unico, esausto cavaliere. Il massacro non poteva rimanere impunito e nel 1842 fu organizzata una spedizione di vendetta. Gli inglesi liberarono gli ostaggi e si diedero alla rappresaglia, per poi ritirarsi, lasciando a se stessi gli afghani, che a quel punto rimisero sul trono il vecchio Dost Mohammad, il sovrano di prima della guerra. Dalrymple ricostruisce la vicenda con rigorosa documentazione, e molte delle sue fonti, storiche e letterarie, sono rarissimi testi afghani del XIX secolo, tratti da collezioni private e ritrovati a Kabul, da cui risulta un conflitto ben diverso da quello descritto nelle fonti inglesi coeve.
Eppure Il ritorno di un re è prima di tutto un romanzo d’avventura. Dalrymple ha la sicurezza e la sensibilità del narratore, e racconta il “grande gioco” come una storia al cui centro non stanno le ragioni della grande politica, ma uomini e donne in carne e ossa: spie colte e coraggiose, fieri e implacabili signori della guerra, decadenti corti orientali, vecchi e pavidi generali, frivole ladies inglesi al seguito dei mariti. Secondo Dalrymple, l’esito della guerra dipese in misura non piccola dalla somma delle ambizioni e delle debolezze di ciascuna di queste dramatis personae. Il “grande gioco” è stato anche, prima di tutto, una partita di caratteri, frutto di civiltà tra loro tanto diverse.
Un ruolo speciale spetta nel libro a capi afghani come Shah Shuja e Dost Mohammad, capofila dei due clan in lotta per il trono, i Sadozai e i Barakzai, cui Darlymple presta persino più attenzione che agli inglesi. Mentre Shuja rappresenta la tradizione, l’ultima traccia dell’antico splendore del paese, Dost Mohammad esprime l’insofferenza per le nuove ingerenze straniere: “Queste tribù costituiscono la mia nazione, proteggerle e difenderle è per me tanto un dovere politico quanto un obbligo morale”, scrisse al governatore generale dell’India, Lord Auckland, “rifletta e consideri se gli afghani potrebbero mai tollerare in silenzio di essere insultati e oppressi senza opporre resistenza”.
Il mondo degli europei è quello vuoto e futile del governo estivo di Simla, più interessato alle partite di polo e ai ricevimenti che all’amministrazione del paese. Fanno eccezione personaggi di grande acume politico come lo stesso Burnes (tuttavia causa scatenante, suo malgrado, della rivolta del 1841, per via delle frequentazioni con donne afghane), o come il tenente Henry Rawlinson che, mandato ad addestrare un reggimento persiano, ebbe la costanza, ogni sera, di arrampicarsi su una parete di roccia per decifrare un’incisione achemenide, corrispettivo persiano della stele di Rosetta. La cacciata degli inglesi rappresenta tuttora un riferimento essenziale per l’identità nazionale afghana. Per comprendere meglio lo scenario della storia che aveva intenzione di raccontare, Dalrymple ha visitato recentemente le valli della ritirata del 1842, le stesse della guerra del 2001. Alla domanda “perché ci odiate?”, la sua guida afghana avrebbe paragonato esplicitamente le due guerre: “Perché sfondate le nostre porte, ci entrate in casa, tirate le nostre donne per i capelli e prendete a calci i nostri figli. Non possiamo accettarlo. Ci difenderemo, vi spezzeremo i denti, e quando avrete i denti rotti ve ne andrete di qui come gli inglesi prima di voi. È solo questione di tempo”.

William Dalrymple
L’invasione del 1839 presenta non poche analogie con l’attuale missione internazionale. Non a caso, Dalrymple racconta di aver ricevuto dall’amministrazione americana la richiesta di un parere sulla situazione odierna dell’Afghanistan: “Più guardavo e più mi sembrava che la prima disastrosa intromissione dell’Occidente in Afghanistan contenesse echi distinti delle avventure neocoloniali dei giorni nostri”, ha scritto nel libro, “Anche la guerra del 1839 era stata dichiarata sulla base di informazioni falsificate in merito a una minaccia pressoché inesistente (…) Centosettant’anni dopo, le stesse rivalità tribali, le stesse battaglie si consumavano negli stessi luoghi all’ombra di nuove bandiere, nuove ideologie e nuovi burattinai”. Persino il noto dibattito sull’“esportazione” della democrazia (anche se allora non si usava quest’espressione) era in fondo già al centro delle riflessioni degli invasori, come mostrano queste domande di un ufficiale britannico: “Bisogna cercare di promuovere gli interessi dell’umanità e favorire le riforme sociali e di genere, mettendo al bando tradizioni come la lapidazione delle adultere? Oppure è meglio concentrarsi esclusivamente sul governo del paese, senza impelagarsi in inutili complicazioni?”. Sarebbe troppo semplice dire che la storia si ripeta. Eppure a volte – avverte Dalrymple – le sue tragedie non sono che stanche esecuzioni di spartiti già noti: “Non è cosa facile”, osservava Mirza Ata, scrittore afghano della corte di Shah Shuja, “invadere o governare il regno del Khorasan”.
luigi_marfe@hotmail.it
L Marfé è traduttore e dottore di ricerca in letterature comparate all’Università di Torino



