Il testo ritrovato
All’interno dello Speciale del numero di ottobre 2016 dedicato alla scrittrice, proponiamo un testo di Natalia Ginzburg che non è mai stato raccolto in volume. Lamento di Portnoy uscì su “La Stampa” il 22 marzo 1970. Non fu incluso nella raccolta Mai devi domandarmi, apparsa da Garzanti nell’autunno di quell’anno. Gli articoli di Cassola citati nel testo sono intitolati entrambi Fogli di diario: uscirono sul “Corriere della Sera” il 6 febbraio e il 12 marzo 1970 e non sono mai stati ripresi in volume.
Lamento di Portnoy
Leggo sempre con grande interesse i “Fogli di diario” di Carlo Cassola. Certe volte sono d’accordo, certe volte non sono d’accordo, certe volte non capisco. Certe volte vorrei rispondergli subito. Per il libro di Philip Roth, Lamento di Portnoy, Cassola ha avuto parole di esecrazione. In un secondo articolo, dove ne parla di nuovo un poco, dice di essere stato accusato di non aver capito “il carattere parodistico” di questo libro. Dice che la parodia lui “la fiuta da lontano” e che non gli interessa affatto. Anche a me non interessa affatto, nei romanzi, la parodia. Ma io non la fiuto da lontano: anzi di solito me la trovo sotto il naso e non riesco a vederla; anche qui, non l’avevo vista. Quando qualcuno me la sottolinea, rimango fredda, come qualcosa che mi è estraneo.
Cassola, nello stesso articolo, mette insieme la parodia e l’ironia. Ma la parodia non è l’ironia. La parodia è l’imitazione grottesca d’una cosa vera e seria. L’ironia è invece il guardare la realtà in ogni sua dimensione possibile, anche comica. L’ironia non ignora la tragedia, non la sfugge, ma la affronta e va oltre. Essa vince il dolore e lo supera sorridendo. A me l’ironia sembra una cosa meravigliosa. Penso che Dio, se esiste, sia molto ironico.
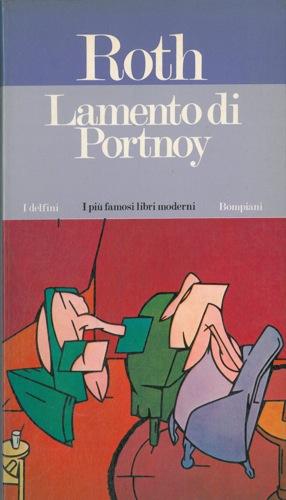 Sul libro di Philip Roth, Lamento di Portnoy, romanzo americano di grande successo uscito in Italia da Bompiani, non divido l’esecrazione di Cassola. Amo in questo romanzo alcuni tratti che trovo vitali. Non lo amo però completamente. Amare un libro solo in parte è una cosa che trovo triste. L’operazione di sezionare un libro, estrarne dei frammenti, dei segmenti, dei tratti o dei volti, e respingere il resto come ciarpame, è un’operazione che non mi è mai congeniale e mi affatica e rattrista. È un’operazione che penso non mi appartenga. Penso spetti ai critici.
Sul libro di Philip Roth, Lamento di Portnoy, romanzo americano di grande successo uscito in Italia da Bompiani, non divido l’esecrazione di Cassola. Amo in questo romanzo alcuni tratti che trovo vitali. Non lo amo però completamente. Amare un libro solo in parte è una cosa che trovo triste. L’operazione di sezionare un libro, estrarne dei frammenti, dei segmenti, dei tratti o dei volti, e respingere il resto come ciarpame, è un’operazione che non mi è mai congeniale e mi affatica e rattrista. È un’operazione che penso non mi appartenga. Penso spetti ai critici.
Mi si chiederà allora perché parlo di questo libro, di cui ho detto di amare solo alcuni tratti. Ne parlo perché, pure amandolo solo in parte, non lo odio, e non mi è indifferente. E anche perché le impressioni che mi ha lasciato sono confuse, e spero che mi si chiariscano. D’altronde il libro stesso è un libro confuso. Philip Roth, quando l’ha scritto, doveva avere in testa una gran confusione.
Questo romanzo è la confessione d’un uomo, sul divano d’un analista. È una confessione torrenziale. L’uomo parla senza sosta, chiamando l’analista a testimonio dei disastri che ha provocato sulla sua persona la figura materna. L’analista non ha voce, e non ha consistenza né dimensione. Potrebbe tacere sempre – come tace – ed essere però una presenza. Potrebbe avere una sua oscura e misteriosa realtà. Non ne ha nessuna. È una sedia vuota. Certo l’autore non aveva in testa, per questo analista, nessun volto umano. Se avesse un volto, lo sentiremmo respirare nell’ombra. Invece no. In quel vuoto, si avverte invece l’autore con una sua volontà cartacea, la volontà di metter là un analista perché la confessione di Portnoy sembri più vera. Oppure forse per fare una parodia dei romanzi moderni. Oppure perché alla gente i romanzi con gli analisti piacciono.
L’analisi è dunque solo un nome e una sedia vuota. La sua vuota non-presenza è là soltanto come chiave per la confessione. Chiave inutile, perché uno può confessarsi così anche a se stesso. L’analista in questo romanzo è ciarpame. Qualcuno a cui dissi che mi sembrava ciarpame rispose che non aveva importanza, che l’analista si poteva anche tagliar via con le forbici. Le forbici non deve usarle chi legge, deve usarle chi scrive. Il ciarpame, nei romanzi, è pericoloso e contagioso, ammalando di inutilità tutto quello che gli sta vicino.
Quando invoca l’analista, quando supplica il suo assentimento, anche Portnoy diventa ciarpame. Si perde in un cicaleccio lagnoso, pigola noiosamente. Si impietosisce sulla propria sfortuna. Smette di raccontarla per commiserarla. Commenta, disserta, esclama. Doveva forse apparire, nelle intenzioni dell’autore, patetico e grottesco. Ma nei suoi vaniloqui di autocommiserazione, Portnoy non è grottesco, è ciarpame. L’autore non sa guardarlo con un’ombra di vera ironia. Invece si mescola in lui, si identifica in lui e frana nella sua sfortuna. La sfortuna di Portnoy è di avere una madre insopportabile, e di non riuscire a sopportarla. Quello che non è ciarpame, in questo romanzo, è la madre.
Essa è veramente insopportabile. Rossa di capelli, con un lungo naso ebreo, essa occupa l’universo di Portnoy e vi infuria con la sua loquela, con la sua ossessiva, infernale e insieme innocente persecuzione materna. Innocente perché, pur provocando disastri, non saprà mai e non capirà mai di averli provocati. È troppo assorta nell’elogio di sé, nell’esaltazione verbosa della sua efficienza e abnegazione.
“Oramai è una storiella di famiglia che io, quando ero un bambinello alto così, mi girai dalla finestra da cui ero stato a guardare una bufera di neve, e domandai con voce piena di speranza: ‘Mamma, noi crediamo nell’inverno?’”. È un tratto molto bello, che vorremmo poter ricordare; vi è espressa con grande naturalezza l’essenza del rapporto madre-bambino; vi ritroviamo la nostra infanzia; chi mai non si è raccolto, da piccolo, nel pensiero materno per giudicare l’universo, chi mai non ha domandato in qualche modo a sua madre se era bene “credere nell’inverno”? Però l’autore sciupa tutto subito. Non si ferma, continua a perorare a perdifiato, chiede pietà, invoca l’analista: “Capisce quello che sto dicendo? Io sono stato cresciuto dagli ottentotti e dagli zulù!”. Che ce ne importa qui degli zulù?La realtà di un personaggio, in un romanzo, si scorge nella realtà e concretezza che diffonde intorno a sé. Qui tutto quello che circonda questa madre è concreto e vitale: la casa, con i tappeti arrotolati nei giornali, lungo il corridoio in penombra; la cucina con i cibi ebraici, i biscotti e i purganti; il padre stitico e la sorella mansueta; il bicchiere di ginger ale sul tavolino da notte, bevanda gradita alla madre e che il figlio rifiuta di toccare, per un ribrezzo del corpo materno, delle sue malattie segrete; l’eterno ribrezzo dei figli per le madri, annidato nelle profondità dell’affetto, intriso di rancore, di terrore, di gratitudine, di rimorso. In qualche momento, sembra che l’autore raggiunga qualcosa di eterno e di universale. Sono però solo dei momenti, e poi si distrae, si disperde, ricade nel cicaleccio e nel pigolìo.
Philip Roth ha guardato alla madre con lo sguardo acuto e torvo del ragazzo e del servo. L’ha guardata con l’intelligenza velenosa, con l’antipatia penetrante del ragazzo che guarda e condanna i genitori senza sapersene staccare di un passo. Senza tolleranza, né ironia, né perdono. Ne è nato un ritratto vitale, lampante, pieno di forza, ma impietoso. Questo è uno dei vizi di questo romanzo; forse l’essenziale. Mi si dirà che è appunto la storia di uno che, a causa di un’educazione sbagliata, non riesce a liberarsi dei genitori, non riesce a diventare adulto. Ma quando raduniamo dei personaggi, quando scriviamo un romanzo, il nostro giudizio sulla realtà deve essere adulto, virile e fermo, anche se raccontiamo di chi adulto non riesce a essere. Il nostro giudizio dev’essere insieme chiaro, inesorabile e pietoso. In questo romanzo invece il giudizio sulla realtà è confuso e incerto, molle, femmineo e impietoso.Penso che Philip Roth, scrivendo questo romanzo, non si fosse pienamente liberato dell’immagine materna. Il romanzo è essenzialmente la storia di un’insofferenza: l’insofferenza dei figli verso i genitori. Tutti abbiamo provato, da ragazzi, questa insofferenza. Adulti, la superiamo, andiamo oltre, guardiamo a quell’antica sofferenza, alle nostre servitù antiche, e a noi stessi, con ironia. Guardiamo ai genitori con pietà. Li perdoniamo. Li perdoniamo di colpe che magari non hanno mai commesso; ma perdonandoli, perdoniamo in verità noi stessi, per l’insofferenza, il ribrezzo, i rancori che ci hanno a lungo tormentato, e che erano i vincoli della nostra servitù infantile.
Dimenticavo di dire che Portnoy è un romanzo per così dire osceno. Mi dispiace dover usare questa parola perché è una parola che sembra esprimere sdegno. In verità è ovvio che un romanzo può essere osceno e bellissimo: si sa che l’oscenità in sé non è né una qualità, né un difetto. Però qui l’oscenità è strabordante, è cicalante, pigolante e vana. È una sorta di balbettio nervoso, insieme calcolato e incontrollato. L’oscenità sembra qui una fuga dalla realtà, un alibi per balbettare e non raccontare.
Penso inoltre che Cassola abbia ragione quando dice che Roth ha pensato al successo. In sé non c’è niente di strano; uno quando scrive un romanzo è così contento che vuole tutto, denaro, successo, amore, spera in ogni specie di cose. Soltanto bisogna che siano di quei desideri sbadati e allegri che usiamo metterci attorno quando scriviamo. Simili alle sigarette che si fumano, alle mentine che usiamo inghiottire contenti e distratti. Tali desideri non hanno nulla da fare né con quello che scriviamo, né con la nostra volontà.
Quello che aveva era più che abbondanza, ma lui ha temuto che fosse poco. Ci ha aggiunto altro: e con questo altro ha sfasciato il libro. Perciò siamo costretti a ripescare, in un suolo franante, i fiori verdi e freschi della sua iniziale ispirazione. Non mi stancherò di ripetere che è un immenso peccato.Roth deve aver pensato al successo in maniera diversa. Si è circondato accuratamente e nervosamente di tutti gl’ingredienti che gli risultavano utili a questo scopo. Deve avere avuto paura di fare un romanzo vecchio. O un romanzo di cui non s’accorgesse nessuno. Perciò s’è messo a scrivere suonando trombe, fanfare e tamburi. Aveva a sua disposizione alcune immagini bellissime. Aveva: una madre; un padre; una sorella; e la memoria d’un cerchio familiare ebraico in America. Aveva anche un’amante. Nel romanzo c’è una gran folla di ragazze, ma una è straordinaria, piena di candore e di grazia, e le fioriscono attorno episodi e battute di un estremo divertimento.


