Mi sento come un aspide camuffato in una vestaglia di voile
di Cristina Iuli
dal numero di marzo 2016
 “Trova la prima frase, e il pezzo è fatto (…). Ma l’ultima è tutta un’altra avventura. Dovrebbe aprirlo, il pezzo. Farti tornare indietro e rileggere tutto da capo”. Quattro scarni enunciati racchiudono una dichiarazione poetica che è al contempo anamnesi del processo compositivo e indizio di stile. In un’intervista di agosto 1977 a “Paris Review”, Joan Didion spiegava così la morfologia essenziale dei suoi scritti: saggi letterari, reportages d’autore o romances, come definiva, con insistenza e non senza compiacimento, le sue narrazioni di finzione.
“Trova la prima frase, e il pezzo è fatto (…). Ma l’ultima è tutta un’altra avventura. Dovrebbe aprirlo, il pezzo. Farti tornare indietro e rileggere tutto da capo”. Quattro scarni enunciati racchiudono una dichiarazione poetica che è al contempo anamnesi del processo compositivo e indizio di stile. In un’intervista di agosto 1977 a “Paris Review”, Joan Didion spiegava così la morfologia essenziale dei suoi scritti: saggi letterari, reportages d’autore o romances, come definiva, con insistenza e non senza compiacimento, le sue narrazioni di finzione.
Sono parole sicure, pronunciate con la consapevolezza di chi ha affinato il proprio metodo critico nel corso di un ventennio di collaborazioni con “Mademoiselle”, “Vogue”, “Esquire”, “The Saturday Evening Post”, “Life”, e alle spalle ha già tre romanzi – Run, River (1963), Play It as It Lays (Prendila così, ed. orig. 1970, trad. dall’inglese di Adriana Dell’Orto, pp. 172, € 18, Il Saggiatore, Milano 2014), A Book of Common Prayer (Diglielo da parte mia, ed. orig. 1977, trad. dall’inglese di Adriana Dell’Orto, pp. 266, € 15, e/o, Roma 2013) – nonché un’pocale raccolta di saggi, Slouching Towards Bethlehem (Verso Betlemme. Scritti 1961-1968, ed. orig. 1968, trad. dall’inglese di Delfina Vezzoli, pp. 172, € 15, Milano, Il Saggiatore 2008). Uno schema collaudato, dunque, quello che Didion descriveva nell’intervista. Chiaro come la doppia lista – “da mettere in valigia:”, “da portare a mano:” – che in un periodo di partenze frequenti aveva fissato all’interno dell’anta del suo armadio di Hollywood per preparare la valigia senza pensare a cosa metterci dentro, essendo “gonna, body, e calze” il suo passe-partout in ogni ambiente della cultura. Solo l’essenziale, dunque, perché abito e parole sono fatti estetici, questioni di stile, e lo stile è carattere, e il carattere, cioè “la volontà di accettare la responsabilità della propria vita”, è la fonte di una delle virtù fondamentali nell’etica di Didion: il rispetto di sé.
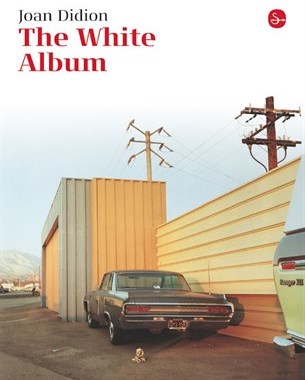 Lo aveva scritto sulle pagine di “Vogue” nel 1961, in un saggio poi ripubblicato in versione ampliata in Verso Betlemme e destinato a diventare pietra miliare del New Journalism; lo ribadiva sulle pagine di The White Album (ed. orig. 1979, trad. dall’inglese di Delfina Vezzoli, pp. 222, € 20, Il Saggiatore, Milano 2015), la sua seconda e non meno memorabile raccolta di saggi, oggi finalmente presentata ai lettori italiani dalla casa editrice Il Saggiatore nella sapiente traduzione di Delfina Vezzoli: il carattere è l’abito mentale che si rivela in ogni scelta dell’artista, dello scrittore, del politico, dell’attore, ma anche di ciascuno di noi. Didion lo intuisce nelle nuvole “di quasi sessanta metri quadrati” che Georgia O’Keefe impone ai curatori museali di Chicago; lo riconosce negli incipit secchi di Hemingway, che mima nei suoi – “1969. È meglio che vi dica dove sono e perché” –, e lo coglie – anche in senso negativo – nella deriva mortifera che collega la decadenza dell’Hotel Royal Hawaiian di Waikiki Beach, Hawaii, “una delle poche tracce ancora esistenti di un certo tipo di vita americana”, alla ritualità sepolcrale e definitivamente post-coloniale con cui vengono smistati gli “arrivi dal Vietnam”. Da quel punto di osservazione tra Vietnam e California, infatti, la dimensione violenta, militare della storia dell’espansionismo americano e delle sue conseguenze non può non rivelarsi come fatto storico e politico che l’esotismo balneare non riesce a rimuovere completamente. Osservando nel cratere dell’estinto Pouwania le tombe dei caduti nell’ennesima guerra americana, diventa “meno facile credere che cifre settimanali di caduti in battaglia inferiori a cento potessero, come per magia, ammontare a zero, una guerra inesistente”. Il soggiorno alle Hawaii offre dunque a Didion lo spunto per un’analisi – culturale, politica, e storica – del costume nazionale, condotta attraverso un metodo che esplora la significatività politica del dettaglio culturale, e che rivela l’autrice come pioniera degli studi culturali.
Lo aveva scritto sulle pagine di “Vogue” nel 1961, in un saggio poi ripubblicato in versione ampliata in Verso Betlemme e destinato a diventare pietra miliare del New Journalism; lo ribadiva sulle pagine di The White Album (ed. orig. 1979, trad. dall’inglese di Delfina Vezzoli, pp. 222, € 20, Il Saggiatore, Milano 2015), la sua seconda e non meno memorabile raccolta di saggi, oggi finalmente presentata ai lettori italiani dalla casa editrice Il Saggiatore nella sapiente traduzione di Delfina Vezzoli: il carattere è l’abito mentale che si rivela in ogni scelta dell’artista, dello scrittore, del politico, dell’attore, ma anche di ciascuno di noi. Didion lo intuisce nelle nuvole “di quasi sessanta metri quadrati” che Georgia O’Keefe impone ai curatori museali di Chicago; lo riconosce negli incipit secchi di Hemingway, che mima nei suoi – “1969. È meglio che vi dica dove sono e perché” –, e lo coglie – anche in senso negativo – nella deriva mortifera che collega la decadenza dell’Hotel Royal Hawaiian di Waikiki Beach, Hawaii, “una delle poche tracce ancora esistenti di un certo tipo di vita americana”, alla ritualità sepolcrale e definitivamente post-coloniale con cui vengono smistati gli “arrivi dal Vietnam”. Da quel punto di osservazione tra Vietnam e California, infatti, la dimensione violenta, militare della storia dell’espansionismo americano e delle sue conseguenze non può non rivelarsi come fatto storico e politico che l’esotismo balneare non riesce a rimuovere completamente. Osservando nel cratere dell’estinto Pouwania le tombe dei caduti nell’ennesima guerra americana, diventa “meno facile credere che cifre settimanali di caduti in battaglia inferiori a cento potessero, come per magia, ammontare a zero, una guerra inesistente”. Il soggiorno alle Hawaii offre dunque a Didion lo spunto per un’analisi – culturale, politica, e storica – del costume nazionale, condotta attraverso un metodo che esplora la significatività politica del dettaglio culturale, e che rivela l’autrice come pioniera degli studi culturali.
“Avrei dovuto sapere la trama, invece sapevo solo quel che vedevo”
Stile è quindi anzitutto pratica conoscitiva, esercizio di interrogazione e comprensione del mondo che modella il racconto in una forma praticabile una volta estinta la possibilità di credere nella verità delle sue premesse, crollate sotto il peso di una disfatta culturale, antropologica forse, che per Didion ha precisa datazione storica: “Sto parlando di un periodo in cui ho iniziato a dubitare delle premesse di tutte le storie che mi fossi mai raccontata, una condizione comune, ma che trovavo preoccupante. Suppongo che questo periodo sia iniziato verso il 1966 per continuare fino al 1971”. Un quinquennio fitto di eventi cruciali nella storia nazionale: la guerra in Vietnam, My Lai e il ritiro delle truppe, gli assassinii di Robert Kennedy e Martin Luther King, la Presidenza Nixon, i Pentagon Papers e il Watergate, il movimento degli studenti e quello femminista, la droga tra i giovani della classe media; eventi intorno ai quali si consuma lo scollamento definitivo tra fatti accaduti, realtà dei massmedia e fiducia dei lettori-spettatori-cittadini nei confronti delle verità istituzionali e pubbliche. Didion esplora questo scollamento nelle cinque sezioni del libro, intitolate: The White Album, California Republic, Donne, Soggiorni e La mattina dopo i Sessanta.

Richard Nixon
A essere messi in dubbio non sono i fatti, ma la loro significatività, che non trova più ancoraggio né nelle false verità ufficiali, né nelle malriposte aspettative personali: i fatti restano muti. La loro “linea narrativa” sfugge all’interprete, a cui restano solo indizi senza movente, fenomeni non riconducibili a una visione storica coerente, accadimenti che evidenziano, da un lato, l’impossibilità di pervenire a una descrizione oggettiva e affidabile del mondo – “Avrei dovuto sapere la trama, invece sapevo solo quel che vedevo” – e, dall’altro, la persistenza dell’imperativo etico a non rinunciare alla possibilità di comprenderlo, quel mondo, attraverso la scrittura. Ma in condizioni di totale disorientamento ermeneutico, scrivere per comprendere ciò che accade significa, per Didion, rovesciare la prospettiva, passare dal racconto impersonale e oggettivo dei fatti al primo piano assoluto di una soggettività “implacabile”, sgranata fino all’esibizione oscena della propria anamnesi psichiatrica e della propria sofferenza neurologica, elementi che la scrittura elegge a sintomi di disorientamento generazionale e trasforma in paradossale strumento di conoscenza.
Infatti, tra l’incipit dei saggi (“Noi ci raccontiamo storie per vivere”) e le conclusioni (“ma scrivere non mi ha aiutato a capire”), la forza suggestiva dei ragionamenti di Didion può solo autofondarsi, deve essere autosufficiente, poggiare su un esordio imperioso che fonda il predicato e orienta la sequenza di frasi perfette, asciutte, che vi si innestano in “una serie di inquadrature in sequenza variabile”, immagini senza alcun “significato” al di là della loro “disposizione temporanea”. Sono infatti le frasi, assertive, sicure – e non i paragrafi – a scandire il ritmo della prosa di Didion: guidano i lettori verso gli snodi del pensiero dell’autrice, poi li trattengono sulla soglia di chiuse perentorie e suggestive come distici di sonetti, e infine li rimandano a capo, a cercare a ritroso una spiegazione che non sarà mai data se non nella forma elusiva del suggerimento, sfuggente come le impressioni personalissime, fondate ma mai dimostrate, che la scrittura proietta sul teatro d’ombre della storia – privata e pubblica – di una scrittrice incontestabilmente “figlia del proprio tempo”, che la storia, una storia, la racconta non come un film, ma come “un’esperienza di montaggio”.
L’analisi della società e della politica americana negli anni settanta
Anche il titolo del volume, che si riferisce all’album dei Beatles titolato The Beatles (1968), anche noto come The White Album per la copertina interamente bianca spezzata solo dall’impressione in rilievo del nome del gruppo, evoca la mitologia dei tardi anni sessanta e mobilita eventi, luoghi, simboli, culture, stili di vita della California di quel periodo, come per cercare in un repertorio simbolico condiviso la causa sufficiente di azioni apparentemente insensate, compiute “in un mondo di gente mossa da motivazioni strane, contrastanti, comprese a malapena e, soprattutto ambigue”.
 L’espressione Helter Skelter, ad esempio, è simultaneamente una traccia dell’album e la traccia di sangue che i Manson Murderers, cioè gli omicidi di Sharon Tate Polanski e dei suoi ospiti, e dei coniugi LaBianca, lasciano a testimonianza del loro indecifrabile progetto di morte sulle pareti delle case delle loro vittime. Simbolo delle ossessioni omicide di Robert Manson e della Manson Family e occasione di sperimentazione un po’ più “hard” nella musicografia dei Beatles, Helter Skelter è un messaggio che evoca, ma non spiega. Anzi, l’impossibilità di stabilire relazioni di causa-effetto tra titolo e azioni getta sulla narrazione degli eventi connessi a quegli omicidi e, per sineddoche, sui “casi” analizzati nella raccolta, l’ombra sinistra e inquietante di un vuoto o di un mistero impenetrabile al centro delle azioni umane, e rimette il caso “privo di un disegno” al centro di quel centro.
L’espressione Helter Skelter, ad esempio, è simultaneamente una traccia dell’album e la traccia di sangue che i Manson Murderers, cioè gli omicidi di Sharon Tate Polanski e dei suoi ospiti, e dei coniugi LaBianca, lasciano a testimonianza del loro indecifrabile progetto di morte sulle pareti delle case delle loro vittime. Simbolo delle ossessioni omicide di Robert Manson e della Manson Family e occasione di sperimentazione un po’ più “hard” nella musicografia dei Beatles, Helter Skelter è un messaggio che evoca, ma non spiega. Anzi, l’impossibilità di stabilire relazioni di causa-effetto tra titolo e azioni getta sulla narrazione degli eventi connessi a quegli omicidi e, per sineddoche, sui “casi” analizzati nella raccolta, l’ombra sinistra e inquietante di un vuoto o di un mistero impenetrabile al centro delle azioni umane, e rimette il caso “privo di un disegno” al centro di quel centro.
Non sono i fatti e gli incontri che spiegano la storia, sembra suggerire Didion; al contrario, è la teoria delle probabilità che distribuisce e accomuna i fatti, la storia e possibilità di osservarla, e che fa sfilare lungo la vita dell’autrice una lunga schiera di personaggi – Linda Kasabian, Huey Newton, Stokey Carmichael, Nancy Reagan, Doris Lessing –, eventi e situazioni – la morte di James Dean, l’emicrania, le tournée promozionali, i centri commerciali – e luoghi – Bogotà, Hollywood, le Hawaii, Malibu, la Hoover Dam, il Getty –, che diventano i suoi oggetti di analisi. Al centro dei saggi c’è la cultura, ovvero la società e la politica degli Stati Uniti negli anni settanta, che Didion analizza dalla prospettiva epistemologicamente problematica, ma poeticamente rivoluzionaria, dell’osservatore partecipe, che agisce come soggetto consapevole ma pur sempre coinvolto, tanto nel processo di osservazione quanto nel campo osservato, e che non può che interpretare i fenomeni a partire dal proprio (alto) grado di coinvolgimento – affettivo, sociale, politico, estetico, professionale, sessuale – nel processo analizzato. Si tratta, per Didion, di rendere retoricamente operativo un principio che in quegli anni il femminismo aveva energicamente introdotto nella riflessione politica, rivoluzionandone il linguaggio e l’orizzonte: il privato è sempre politico.
Ma Didion non può allinearsi ai codici espressivi del femminismo militante – terza sezione della raccolta –, al quale non perdona l’ottusità immaginativa, la sclerotizzazione ideologica dell’analisi in un “determinismo angusto e sgradevole” e in una “litania di banalità”, che impediscono l’esplorazione delle ambiguità morali e finiscono sia per negare il nesso tra identità femminile e identità di “classe”, sia per rimuovere dall’agenda politica la comprensione autentica “di cosa significhi essere donna, la differenza irriconciliabile di questa condizione: il senso di vivere la propria vita sott’acqua, l’oscuro legame con il sangue, la nascita e la morte”. E benché affiori l’affinità tematica con le questioni sollevate dal femminismo, sono altri i codici espressivi che Didion mobilita mescolando registri, media, e riferimenti culturali, e imponendo il suo stile come anticipazione esemplare di una pratica critica che ci è stata resa familiare dal new journalism e dagli studi culturali, ma che Didion si è inventata dal nulla, elaborando un genere a partire da sé stessa, dalla propria idiosincrasia politica e dalle proprie inclinazioni estetiche. C’è un solo precedente a The White Album, ed è, appunto, Verso Betlemme, di cui si dice stia agli anni sessanta come The White Album sta ai settanta. Ma più che esserne la continuazione, The White Album costituisce la messa a punto metodologica, l’affermazione stilistica e la conferma del carattere imposti con Verso Betlemme.

Joan Didion in una foto del 1968 di Julian Wasser e la campagna di Céline del 2015
Il binomio stile/carattere che Didion ha eletto a programma estetico e pratica critica nell’arco di tutta la sua lunga carriera, noi lettori stanchi, consumatori assidui di immagini, lo riconosciamo anche nelle fotografie che di lei si sono sedimentate nell’iconografia americana degli anni sessanta e settanta consacrandola diva del casual cool e icona transgenerazionale: la sua figura esile immortalata ancora giovane sotto uno sguardo scettico, seduta accanto alla macchina per scrivere o mentre cammina lungo la spiaggia, la sigaretta tra le dita, o appoggiata alla Corvette Daytona, è stata recentemente riproposta, in versione âgée nella serie di scatti per la maison di alta moda Céline, che l’ha canonizzata definitivamente come icona classica del secolo americano.
cristina.iuli@uniupo.it
C Iuli insegna letteratura nordamericana all’Università del Piemonte Orientale


