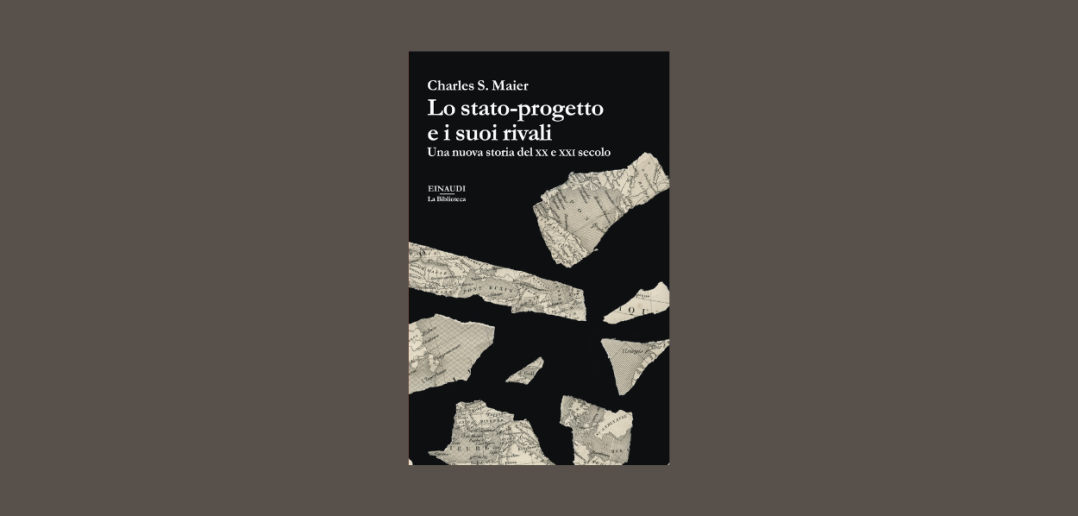Un’entità politica trasformatrice
di Daniela Luigia Caglioti
Charles S. Maier
Lo stato-progetto e i suoi rivali
Una nuova storia del XX e XXI secolo
ed. orig. 2023, trad. dall’inglese di Gian Luigi Giacone,
pp. XVI-648, € 34,
Einaudi, Torino 2024
Charles Maier, professore emerito di storia all’Università di Harvard, non è nuovo ai libri-affresco, che raccontano cioè, attorno a un’idea interpretativa forte, la storia mondiale su un lungo arco temporale. Questa sua nuova fatica, un tour de force di 650 pagine, complementa e completa, quasi come in una trilogia, i suoi lavori anteriori, anch’essi tempestivamente e fortunatamente tradotti in italiano – Leviatano 2.0 e Dentro i confini (Einaudi, 2018 e 2019) – e si inscrive in una carriera scientifica caratterizzata da un’attenzione costante ai temi dello stato e dell’economia o meglio della politica economica e finanziaria. Lo stato-progetto e i suoi rivali, pur muovendosi su un arco cronologico più limitato rispetto ai due precedenti, è un libro altrettanto complesso e non solo per l’originalità interpretativa, ma anche per la vastità dei riferimenti, della letteratura in più lingue dominata da Maier (una rarità nella storiografia americana sempre più schiacciata, anche quando si affrontano temi e problemi di storia globale e mondiale, sulla sola lingua inglese), delle fonti e delle idee. È questo un libro d’approdo e che, in un certo senso, chiude un cerchio aperto nel 1975 con la pubblicazione de La rifondazione dell’Europa borghese, edito in Italia da De Donato nel 1979. In questi cinquant’anni lo sguardo di Maier da comparativo si è fatto globale, anzi meglio, la comparazione, che resta un pilastro del suo rigoroso metodo di lavoro, è stata messa al servizio di una storia che è mondiale nel senso pieno del termine perché si muove con agilità e sicurezza di conoscenze da un lato all’altro del globo terrestre. Lo stato-progetto e i suoi rivali propone una nuova lettura della storia del XX secolo e dei primi decenni del XXI. Il filo conduttore è quello enunciato nel titolo, lo “stato-progetto” cui nel corso del libro si aggiunge un aggettivo fondamentale, quello di “militante”. Perché ci sia stato-progetto deve esserci anche attivismo, una militanza per l’appunto, quasi un’idea messianica, che il progetto sostiene, avanza e implementa nelle sue varie forme. Ma che cos’è questo “stato-progetto militante” e perché esso rappresenta una novità che distingue una larga parte del XX dai secoli precedenti? È un’entità politica che, sulla scorta di una spinta interna spesso accelerata e aumentata dalla competizione internazionale, cerca attivamente di trasformare la società piuttosto che limitarsi ad amministrarla, di rimodellarla attraverso idee e riforme ambiziose. Gli stati-progetto, dice Maier, sono in genere il prodotto di “una guerra, una rivoluzione o una profonda crisi nazionale”, e si pongono come risposta a crisi o a carenze nazionali percepite. La prima guerra mondiale e la rivoluzione bolscevica, la Grande depressione e quindi la seconda guerra mondiale hanno dato slancio a nuovi progetti di costruzione statuale. Lo stato-progetto è un tipo di formazione che cerca “di infondere energia nella cittadinanza” e che “non esclude nessuna linea politica dura e incalzante, ma comporta un certo grado di consapevole ambizione”. È quindi per questo fondamentalmente diverso dal developmental-state (tradotto nell’edizione italiana come “stato di sviluppo” cui è forse preferibile l’espressione “stato sviluppista”), orientato essenzialmente alla modernizzazione economica, e dallo “stato amministrativo”. La categoria di stato-progetto consente a Maier di guardare al Novecento in maniera originale e fuori dalla classica dicotomia democrazie vs totalitarismi che ne ha caratterizzato buona parte dell’interpretazione. Lo stato-progetto non è né democratico né autoritario di per sé, ma può assumere e assume entrambe le forme. In questo senso fascismo, nazionalsocialismo, stalinismo e New Deal rappresentano altrettanti esempi di stati-progetto in contrasto tra loro ma accomunati da varie caratteristiche come la presenza di leader forti e carismatici, di intellettuali che hanno aiutato a concepirne il disegno e a propagandarlo, di risorse mobilitate, magari estratte altrove e fuori dal territorio, di interventi massicci dello stato con l’obiettivo di dare nuova forma alla società civile. Il libro esamina l’evoluzione storica, le ambizioni e le conseguenze di molteplici stati-progetto, confrontandoli con altre forme di governance alternative, i rivali del titolo, che spesso hanno impedito il pieno dispiegarsi dei primi, tra cui gli imperi delle risorse e le economie di mercato. La struttura è cronologica – il periodo delle guerre mondiali, la “metà del secolo” (il periodo compreso tra il 1945 e la metà degli anni settanta) e gli ultimi cinquant’anni – ma questa periodizzazione, funzionale all’interpretazione, non è affatto rigida. Maier si muove in un continuo va e vieni temporale che dà vita a una fitta trama di comparazioni, associazioni, e relazioni in cui collega diacronicamente idee, modelli ed esiti. Le prime due fasi sono quelle in cui si registra la più ampia proliferazione e varia affermazione di stati-progetto che entrano in conflitto con gli imperi delle risorse. Nella terza fase, gli stati-progetto segnano una battuta d’arresto, lasciando il campo ad altri due importanti soggetti collettivi – il regno della governance e la rete del capitale – che prendono il sopravvento determinando un ridimensionamento e un’erosione dei “progetti” e una trasformazione politica profonda delle ideologie, dei partiti, specie quelli socialdemocratici e liberal che, all’inseguimento di efficienza economica e primato del mercato, hanno ridefinito, fino a perderla, la loro identità, la loro capacità creativa, propositiva e propulsiva e la loro presa sulla società civile. È infatti a partire dagli anni settanta che entra in crisi lo stato-progetto che riscuote le maggiori simpatie di Maier, quello che, soprattutto nell’emisfero occidentale a seguito del piano Marshall, ha sostenuto la straordinaria affermazione di un ordine democratico-parlamentare basato sul welfare, sulla lotta alla povertà e sull’idea di uguaglianza.
Lo stato-progetto permette all’autore di tenere insieme politica ed economia in un intreccio, inscrivendosi in una rinnovata attenzione della storiografia americana e non solo (si pensi all’ultimo libro di Jürgen Kocka, Capitalismo. Una breve storia, Carocci 2022) per la storia del capitalismo. Maier, la cui principale preoccupazione è di offrire una spiegazione sul nostro presente e immaginare un futuro, presenta lo stato-progetto come un modello storicamente significativo e ambizioso che progressivamente perde di rilevanza per lasciare spazio alla proliferazione di populismi di vario tipo e all’emersione di leader con attitudini e ambizioni autoritarie che si sono sostituiti ai partiti e alle forme novecentesche di mediazione tra politica e cittadinanza, e che hanno lasciato alla governance amministrativa le principali funzioni dello stato. C’è ancora spazio, si chiede Maier nell’ultimo capitolo, dopo la crisi economica del 2008, la crisi mondiale innescata dalla pandemia, e il ritorno della guerra in Europa con l’invasione russa dell’Ucraina, per un nuovo progetto che al grido di “Osate più stato” salvi il modello democratico liberale? La risposta è affermativa e allo stesso momento speranzosa perché “Lo stato-progetto, nella sua forma migliore, è stato un mezzo del XX secolo per far progredire quello che potremmo chiamare il bene comune”.
caglioti@unina.it
D. L. Caglioti insegna storia contemporanea all’Università Federico II di Napoli
Rileggere il Novecento per alimentare nuove speranze
di Marco Bresciani
L’esigenza di ripensare la storia recente per dar conto di un presente caotico è quanto mai urgente. Da molto tempo, un insieme di narrazioni storiche intrise di istanze etico-politiche ha rintracciato il filo conduttore del Novecento nei duelli bipolari tra dittatura e democrazia o nei conflitti triangolari tra fascisti, comunisti e liberaldemocratici. Secondo una visione diffusa, cicli successivi di ascesa e crisi, di espansione e contrazione delle democrazie liberali avrebbero scandito la fuoruscita dalla Grande guerra, dalla seconda guerra mondiale e dalla guerra fredda. Ed ecco invece un volume che punta a spostare i termini del discorso in una direzione irriducibile alle rappresentazioni politiche-ideologiche contemporanee.
Con il suo ricchissimo bagaglio di studi storici e di economia politica, Maier azzarda una mossa alla Tocqueville nella convinzione, non priva di dilemmi morali, che “se si va oltre la distinzione tra regimi liberaldemocratici e autoritari, o addirittura totalitari, si rilevano più facilmente le dinamiche della storia recente”. Molti dei suoi precedenti temi di riflessione – la ricomposizione “corporatista” degli interessi privati, le dinamiche di transizione e stabilizzazione, i nessi tra sovranità territoriale e identità nazionale – si riconfigurano in una lettura originale del XX e XXI secolo. Il suo punto di partenza è la ricerca, alla Montesquieu, del “nuovo spirito delle leggi” in un “momento di disincanto della democrazia”.
Sfumando, senza mai cancellare, la distinzione tra forme di governo, Maier delinea quattro attori collettivi del XX e XXI secolo, a volte impegnati ad agire in opposizione, altre volte in cooperazione: lo “stato-progetto”, gli “imperi delle risorse”; i domini transnazionali del “capitale”, le organizzazioni internazionali della governance.
Dei tanti filoni che compongono questo testo fittissimo, qui si privilegerà soltanto “lo stato-progetto militante” come “un’entità politica che aspirava consapevolmente a influenzare il corso della storia”. Mentre lo “stato di sviluppo” puntava alla modernizzazione economica, gli ambiziosi programmi dello stato-progetto tentavano di “riformare istituzioni o società ormai sclerotizzate”, “infondere energia nella cittadinanza”, “creare un mondo ospitale per i loro valori, espressi in termini di una superiore civiltà, razza o perfezione ideologica”. Forgiato dall’esperienza di mobilitazione totale della Grande guerra, quel primo stato-progetto era caratterizzato da “una componente militare e competitiva”. Ma già le rivoluzioni che avevano sconvolto, dal 1905 in poi, l’impero russo, quello cinese e quello ottomano, e poi il Messico, avevano gettato le premesse per nuovi regimi trasformativi. Gli stati-progetto si moltiplicarono negli anni venti e trenta, dalla Turchia di Kemal all’Italia di Mussolini, dall’Unione sovietica di Stalin alla Germania di Hitler fino agli Stati Uniti di Roosevelt, con l’intento di riplasmare l’intera società e di affrontare una nuova guerra. Sulla scia della seconda guerra mondiale, che rinverdì le pretese dello stato nazionale, emerse “uno stato-progetto di seconda generazione”, che tentò invano di salvare gli imperi, mentre riuscì a elargire programmi di welfare state. Questo “attivismo governativo” si scontrò con difficoltà crescenti a partire dalla fine degli anni settanta, sollevando la necessità di “reinvenzioni” nei rapporti tra stato e società, politica ed economia.
Resta da capire meglio in quale misura la definizione di stato-progetto, che getta luce inedita sugli esperimenti politici radicali del Novecento, possa spiegare i fenomeni populisti, illiberali, autoritari recenti. Tuttavia, seminando dubbi sulla centralità (utopica o retrospettiva) della democrazia nella storia globale contemporanea, Maier offre suggestioni utili per un approccio pragmatico e disincantato. E si chiude questo suo libro di vasto respiro con la sensazione che l’esperienza post 1945 di istituzioni e società relativamente libere e meno diseguali sia stata il frutto di trasformazioni intrecciate e inaspettate, spesso non intenzionali, non di rado accidentali: per quanto controintuitivo, questo è anche un messaggio di speranza.
marco.bresciani@unifi.it
M. Bresciani insegna storia contemporanea all’Università di Firenze