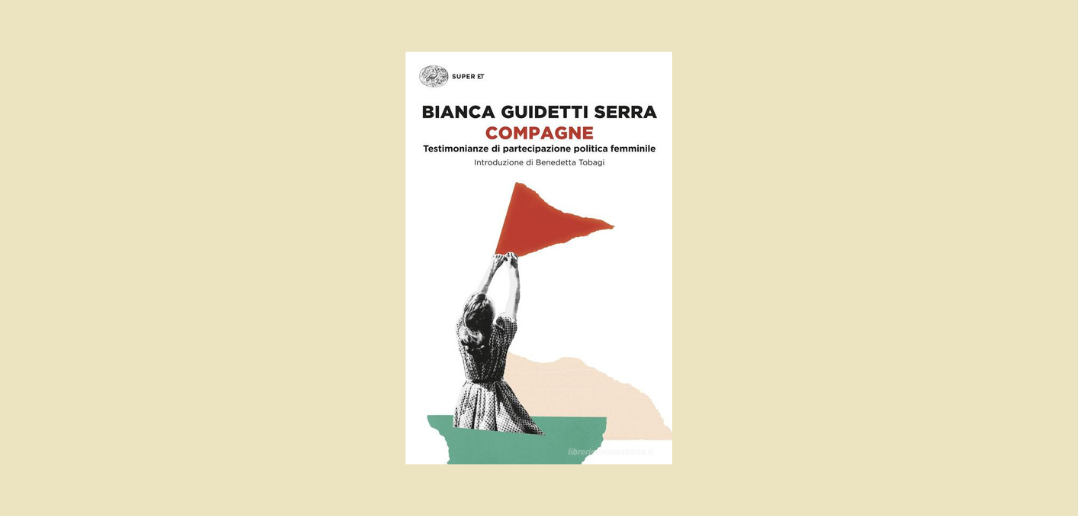Bianca Guidetti Serra
Compagne. Testimonianze di partecipazione politica femminile
introduzione di Benedetta Tobagi, postfaz. di Santina Mobiglia,
pp. XXIV-680, € 16,50,
Einaudi, Torino 2025
Le donne, tra ricordi di vita e memoria storica
di Francesca Sensini
C’è una storia che non si adatta agevolmente alla struttura dei manuali, con le loro esigenze di chiarezza documentaria, un racconto frammentario che traluce, in filigrana, sotto le pagine dispiegate della storiografia ufficiale, e aspira a completarle, disordinandone la lettura in modo fecondo. È la storia delle donne che hanno partecipato alla Resistenza, che hanno intrecciato faticosamente vita quotidiana e politica, trasformando la loro marginalità sociale in militanza e autodeterminazione. Compagne. Testimonianze di partecipazione politica femminile di Bianca Guidetti Serra, pubblicato da Einaudi nel 1977 e oggi riproposto, con un’Introduzione di Benedetta Tobagi e una Postfazione di Santina Mobiglia, riporta al centro dell’interesse editoriale e critico il risultato di un gesto etico e politico preziosissimo: raccogliere le voci di donne che, compagne nella lotta antifascista, hanno incarnato per l’autrice una formidabile scuola di formazione politica, la cui vitalità resta intatta nel dispiegarsi di questo diario pubblico e privato, collettivo e individuale a un tempo.
Torinese, classe 1919, laica, antifascista, avvocata penalista, militante nel Pci dal 1943 al 1956, Guidetti Serra raccoglie quarantotto interviste che tracciano quella che lei definisce “l’autobiografia politica” di cinquantuno donne, nate tra la fine del XIX secolo e gli anni venti, di estrazione proletaria, per lo più comuniste, militanti nella Resistenza, protagoniste delle battaglie sindacali e sociali dell’immediato dopoguerra, nel contesto della storia del movimento popolare e operaio a Torino. Si tratta dunque di un “campione non scientifico”, come Guidetti Serra sottolinea, motivato da un legame di vita diretto tra l’intervistatrice e le sue interlocutrici, e circoscritto territorialmente a Torino, con le sue fabbriche, animate dai primi scioperi a inizio Novecento, le sue barriere e i suoi borghi, spazio limitato e insieme scenario emblematico, in grado di restituire il senso di un’esperienza più vasta.
Ne esce un mosaico di vite vivacissimo e refrattario all’epica guerriera che offre, con un pudore e una modestia che sono portato di classe e nel contempo di genere, una contronarrazione della storia dominante. Sono vicende di sacrificio, di fame, di paura, di galera, ma anche di ribellione all’ingiustizia, di solidarietà, di una coscienza politica che germoglia dal vissuto personale, di una libertà negata due volte, in quanto antifasciste e in quanto donne, ma ricercata caparbiamente giorno per giorno.
Il lavoro di Guidetti Serra vuole essere, prima di tutto, un’opera di restituzione. Non c’è nessuna intenzione celebrativa, né desiderio di spuntare le asprezze di un’esperienza collettiva capitale ma non priva di dubbi, di contraddizioni, di una certa casualità che a volte si confonde con un destino ineludibile. Molte delle donne che raccontano la loro storia, dalla loro nascita al presente, evocano la “necessità” del loro agire, l’azione di una spinta in avanti a cui non hanno potuto sottrarsi e che ha portato, attraverso una faticosa emancipazione individuale, alla liberazione di un paese intero. Tutte le compagne dicono “io”, interpellando immediatamente chi legge, con un parlare diretto, registrato nella sua scarna vivacità, che affastella l’evocazione di azzardi quotidiani e piccole avventure insieme a grandi imprese, non di rado attribuite non al coraggio individuale ma all’audacia abbagliante della gioventù. E così raccontano la durezza della loro vita di donne, dentro casa e fuori. I racconti si susseguono in forma di colloquio, senza cornici interpretative imposte, ma con la confidenza di un ascolto fondato su un rispetto umano radicale.
A colpire non è solo la varietà delle vicende di ciascuna, ma la tenacia con cui queste donne hanno resistito, spesso in secondo piano, senza aspettarsi nulla in cambio, con un senso del dovere civile luminosissimo nella sua disarmante semplicità. Alcune hanno portato messaggi ai partigiani, nascondendo carte compromettenti dove potevano, rischiando il tutto per tutto, ogni volta. Altre hanno fatto sciopero in fabbrica, in pieno fascismo. Molte sono state arrestate, picchiate, licenziate, brutalizzate, torturate. Nessuna si sente vagamente un’eroina e lo dice, per allontanare da sé ogni sospetto di presunzione, ma tutte condividono una profonda coscienza della dignità umana e del senso della giustizia. È qui che l’autrice – che nella sua lunga carriera ha difeso operai, detenuti e minori – riconosce un terreno comune: una legalità vissuta come esigenza etica prima che giuridica. La registrazione di queste voci, essenziali, nude e vitalmente mosse, non pretende alcuno statuto letterario. Si vuole testimoniale. Guidetti Serra non interpreta, non addolcisce né enfatizza. Affida tutto alla parola delle intervistate, anche alle loro reticenze, e a chi legge resta il privilegio di un ascolto come dal vivo, in un presente che si rinnova e che insegna, con l’esempio, il valore della partecipazione politica e civile al bene comune. All’epoca della prima uscita di Compagne, l’Italia degli anni settanta è percorsa da tensioni sociali e politiche molto forti, e il dibattito pubblico fatica a dare spazio a una memoria altra, complementare, di matrice popolare e femminile. Eppure, Guidetti Serra propone la sua raccolta di testimonianze perché vuole forzare la rottura di un silenzio durato troppo a lungo e offrire dei documenti nuovi, inattesi, nati dal fermento dei ricordi individuali ma aspiranti a farsi tasselli di memoria storica condivisa. Compagne offre così l’opportunità di approfondire la riflessione sulla Resistenza valendosi di una storiografia rinnovata, di derivazione orale e, nel contempo, di approfondire i temi legati all’antifascismo nel contesto dei movimenti politici degli anni settanta. In particolare, l’autrice intende arricchire la trama della storia delle donne intrecciando il passato militante delle sue compagne e il nuovo femminismo, raccontando a quante erano cresciute dopo la guerra le opere e i giorni di quelle che prima di loro avevano aspirato alla giustizia e all’autodeterminazione.
Libro pionieristico, Compagne anticipa molte riflessioni che la storiografia di genere affronterà negli anni successivi. Si pensi ai lavori di Anna Bravo e di Luisa Passerini che, a partire proprio dalla storia orale e dalle fonti soggettive, struttureranno nuove categorie nell’interpretazione della storia. In questo senso, Compagne ha aperto una strada nuova e fruttuosa. Rileggerlo oggi – in un contesto culturale più attento alla pluralità della memoria e alla presenza delle voci delle donne nella storia – permette di riscoprirne il valore civile, al di là dell’innegabile valore documentario. È un testo che sorprende per la sua onestà, che invita chi legge a riconsiderare le proprie certezze su cosa siano l’impegno e la storia. La Resistenza che vive in queste pagine non è quella dei manuali di storia, ma della vita, del lavoro, delle figlie che si ribellano ai genitori o che, da loro ispirate, ne fanno la fierezza e insieme la disperazione, per la costante paura di vederle cadere, un giorno o l’altro, dietro il loro avventato, forse casuale (o forse no), eroismo. In un tempo in cui la memoria rischia di irrigidirsi in monumento marmoreo, freddo e retoricamente distante, Compagne attesta che ricordare è, prima di tutto, un moto vitale che ha a che fare con la responsabilità. E che le storie delle donne sono una componente essenziale della storia. Lo sguardo di Guidetti Serra non giudica, non erocizza, rifugge da ogni idealizzazione ma riconosce delle esperienze e le afferma. E in questo gesto sta la bellezza di Compagne e la sua necessità.
francesca.sensini@gmail.com
F. Sensini insegna italianistica all’Università di Nizza