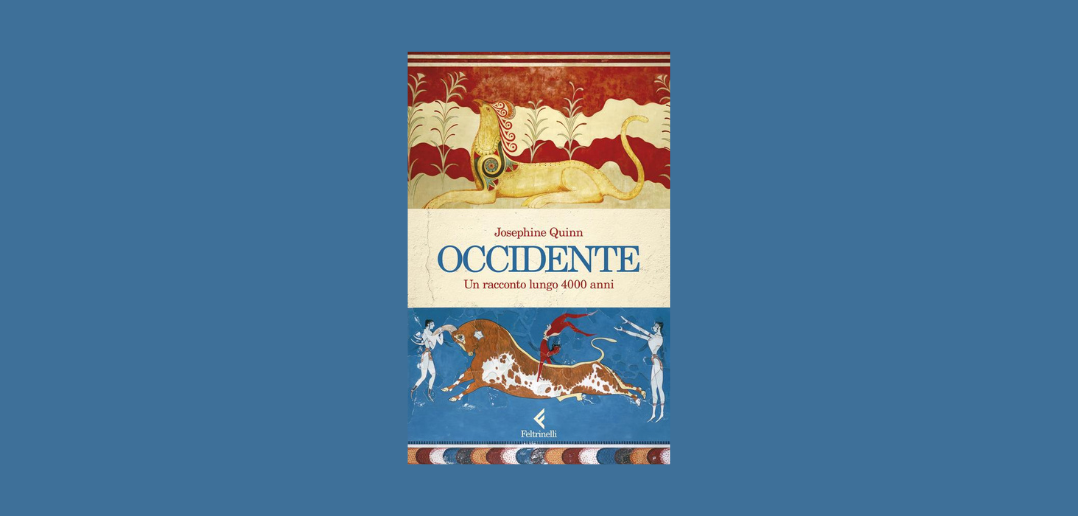Josephine Quinn
Occidente.
Un racconto lungo 4000 anni
ed. orig. 2024, trad. dall’inglese di Francesca Pe’,
pp. 565, € 30,
Feltrinelli, Milano 2024
La civiltà occidentale come costrutto ideologico
di Matteo Zaccarini
Il civilisational thinking è una corrente di pensiero che guarda alle civiltà umane come entità rigidamente distinguibili, caratterizzate e isolabili nei loro tratti specifici. Un costrutto ideologico nato nell’Ottocento, ma ancora oggi estremamente influente, che si fonda su concezioni identitarie e sostanzialmente razziste della storia umana. Al centro del civilisational thinking vi è la convinzione che esista un legame intimo e quasi esclusivo, un’eredità culturale acquisita per discendenza pressoché diretta, tra le civiltà classiche (soprattutto Greci e Romani) e il mondo occidentale, in un’ottica tutta incentrata sull’esaltazione delle radici e delle conquiste di quest’ultimo.
Attraverso un’analisi di oltre 4.000 anni di storia tra l’età del Bronzo e l’Ottocento, in questo libro Josephine Quinn, che insegna storia antica a Oxford, smonta metodicamente i fondamenti di ogni visione occidentalizzante del passato. Il volume argomenta, da un lato, che il presunto rapporto privilegiato tra l’odierno Occidente e l’antichità classica non abbia solide basi storico-culturali; dall’altro, che l’idea stessa di un’antica civiltà occidentale pura, trainante, animata da valori esclusivi sia un costrutto ideologico relativamente recente che peraltro è mutato nel tempo a seconda delle contingenze. Attraverso trenta densi capitoli organizzati in senso tematico-cronologico, Quinn mette in luce le debolezze e le rigidità della narrazione storica tradizionale sulla genesi e l’evoluzione dell’identità occidentale. Al centro del viaggio, che significativamente inizia e termina nel Levante, c’è un mondo che ruota intorno al Mediterraneo, ma che giunge regolarmente a includere tutta l’Europa, il Vicino Oriente, l’Asia e l’Africa più lontane. Quello che racconta è, infatti, un mondo antico complesso, sfaccettato, animato da mobilità, permeabile agli scambi, in continua trasformazione e, sin dai tempi più remoti, estraneo a ogni inquadramento fondato su rigide etichette e confini, fisici quanto culturali.
I singoli elementi discussi da Quinn non sono in sé innovativi, come l’autrice stessa mostra attraverso una bibliografia, articolata e aggiornatissima, che spazia dagli studi storici, letterari e archeologici a quelli climatici e genetici. Il volume infatti s’inserisce in una linea di ricerca ormai (ri)aperta da oltre un ventennio, un approccio che ricostruisce un Mediterraneo espanso, interconnesso, policentrico, la cui storia, fatta di viaggi, scambi, commerci e conflitti, si può cogliere solo attraverso una visione d’insieme, nella lunga durata e di ampio respiro, anziché tramite singoli casi che rischiano di oscurare i collegamenti, anziché spiegarli. Un’indagine con radici lontane, al cui centro indubbiamente resta, per il XX secolo, Fernand Braudel, ma che nel campo degli studi classici è rappresentata in diverso modo da altri studi, quali il tanto controverso Atena Nera di Martin Bernal, che apparve nel 1987, o il recente Filosofia greca e identità dell’Occidente. Le avventure di una tradizione (il Mulino, 2022) di Giuseppe Cambiano.
Ciò che questo lavoro offre di nuovo è una narrazione d’insieme ampia, stimolante, vivida, autorevole e aggiornata. Si tratta di un testo al contempo documentato e accessibile, solidamente fondato e ricco d’immaginazione, che sovente immerge il lettore in epoche e luoghi passati a partire da scene di vita quotidiana. Quinn critica senza mezzi termini l’artificiosa, deformante narrazione dell’Egeo dell’età del Bronzo attraverso le due pseudociviltà di “Minoici” e “Micenei”, etichette in fin dei conti molto più ideologiche che scientifiche; sgombra il campo dal mito, ancora oggi frequentemente ripetuto, delle invasioni di popoli nordici (“Dori”), tanto abusato da correnti di pensiero alla base delle teorie razziali più buie tra XIX e XX secolo; colloca in un contesto allargato, ricco di fermento, confronti e mobilità umana, la costruzione e la manifestazione del potere entro il “sistema di Amarna” in un vasto arco tra il Mediterraneo orientale, l’Egitto, la Mesopotamia, fino agli altopiani iranici; ci ricorda come la caduta dell’Occidente romano nel 476 ebbe scarso impatto concreto sulla vita degli abitanti di mezzo impero, e ancor meno su quelli dell’altra metà. Un elemento centrale dell’interconnessione narrata da Quinn è la navigazione a vela, fondamentale per consentire la partecipazione a una rete di collegamenti estesa e ramificata, sin dall’età del Bronzo, lungo la quale hanno viaggiato l’arte, la scrittura, il trasferimento tecnologico, e più in generale idee, merci e conflitti. Nel ricostruire i tracciati culturali Quinn rifiuta il concetto, sterile e semplicistico, di “influenza” di un modello e si concentra piuttosto sulla ricezione attiva di chi quel modello lo adotta. La narrazione è condita da una gradevole, misurata ironia nel commentare personaggi storici e non, che si tratti di Hammurabi, Alessandro Magno, o il mondo della scienza odierna. Non tutte le sue tesi saranno convincenti allo stesso modo: ad esempio, l’autrice sembra conferire peso eccessivo a vaghi, limitati indizi d’istanze “proto-democratiche” nel Vicino Oriente ben prima che nella Grecia classica; né magari si troverà condivisibile l’idea che i Greci fossero sostanzialmente disinteressati a una contrapposizione – prima di tutto culturale – tra i continenti europeo e asiatico. Ma si tratta di singoli punti che non minano il successo delle tesi di fondo del volume.
L’edizione italiana offre una leggibilità e una veste editoriale pregevoli. Qua e là, va detto, stridono un po’ i non rari riferimenti pensati dall’autrice per un pubblico strettamente anglosassone (e peraltro per lo più inquadrabile entro un preciso, ristretto milieu socioculturale): Londra, New York, i Padri Pellegrini, Shakespeare, e così via. Ma questo non significa affatto che il libro sia inadeguato al pubblico italiano. Tuttora non accennano a spegnersi le polemiche suscitate dalle Nuove Indicazioni ministeriali che, scandite da continui, confusi riferimenti al concetto di Occidente, mirano a riprogettare l’istruzione nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo in Italia. Impossibile, leggendo questo libro, non pensare alle norme sulla didattica della storia enunciate in una sezione di questo documento, piena di errori – anche terminologici e concettuali – imbarazzanti, che esordisce con lo slogan “Solo l’Occidente conosce la Storia”. Possiamo affermare, dunque, che il libro di Quinn giunge da noi con un tempismo perfetto.
matteo.zaccarini2@unibo.it
M. Zaccarini insegna storia greca all’Università di Bologna