I bianchi non pensano molto lontano
di Francesco Remotti
dal numero di gennaio 2019
Davi Kopenawa e Bruce Albert
LA CADUTA DEL CIELO
Parole di uno sciamano yanomami
ed. orig. 2010, trad. dal tedesco di Alessandro Lucera e Alessandro Palmieri
pp. 1072, € 35
nottetempo, Milano 2018
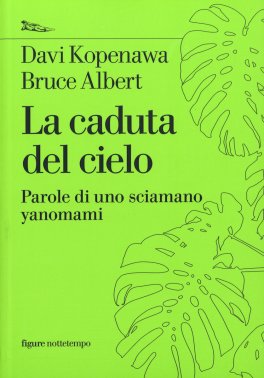 Questo libro è la trascrizione con cui un etnologo francese, Bruce Albert – nato in Marocco nel 1952, laureato a in antropologia a Paris-Nanterre nel 1985, studioso degli Yanomami del Brasile a partire dal 1975 – ha voluto riprodurre i racconti e le riflessioni di Davi Kopenawa, uno sciamano, il quale per un verso espone diversi aspetti della sua cultura, inerenti soprattutto al mondo degli spiriti, dei miti e dei riti, e per un altro verso racconta il suo incontro con i bianchi (missionari, funzionari, cercatori d’oro), nonché i pensieri che questo incontro ha provocato nel suo animo. Anche per il lettore non specialista (non antropologo, non esperto delle società amazzoniche) dovrebbe fare un certo effetto mettersi in ascolto di un personaggio a noi contemporaneo e tuttavia così diverso dai ruoli con cui abitualmente abbiamo a che fare nella nostra vita quotidiana. Davi Kopenawa non ci è però del tutto estraneo: egli conosce il mondo dei bianchi; ha viaggiato a Parigi, a New York. Ma le sue parole ci trascinano inesorabilmente nella foresta amazzonica in cui è nato (attorno al 1956) e in cui continua a vivere. In effetti, se dovessimo dire qual è il personaggio più importante di tutte queste pagine, non sbaglieremmo a sostenere che è la foresta (urihi per gli Yanomami), oggetto di predazione continua da parte dei cercatori d’oro (alla fine degli anni ottanta, migliaia di garimpeiros invasero il territorio degli Yanomami portando con sé malattie, violenze, morte) e nello stesso tempo rifugio, garanzia di sopravvivenza per i suoi abitanti.
Questo libro è la trascrizione con cui un etnologo francese, Bruce Albert – nato in Marocco nel 1952, laureato a in antropologia a Paris-Nanterre nel 1985, studioso degli Yanomami del Brasile a partire dal 1975 – ha voluto riprodurre i racconti e le riflessioni di Davi Kopenawa, uno sciamano, il quale per un verso espone diversi aspetti della sua cultura, inerenti soprattutto al mondo degli spiriti, dei miti e dei riti, e per un altro verso racconta il suo incontro con i bianchi (missionari, funzionari, cercatori d’oro), nonché i pensieri che questo incontro ha provocato nel suo animo. Anche per il lettore non specialista (non antropologo, non esperto delle società amazzoniche) dovrebbe fare un certo effetto mettersi in ascolto di un personaggio a noi contemporaneo e tuttavia così diverso dai ruoli con cui abitualmente abbiamo a che fare nella nostra vita quotidiana. Davi Kopenawa non ci è però del tutto estraneo: egli conosce il mondo dei bianchi; ha viaggiato a Parigi, a New York. Ma le sue parole ci trascinano inesorabilmente nella foresta amazzonica in cui è nato (attorno al 1956) e in cui continua a vivere. In effetti, se dovessimo dire qual è il personaggio più importante di tutte queste pagine, non sbaglieremmo a sostenere che è la foresta (urihi per gli Yanomami), oggetto di predazione continua da parte dei cercatori d’oro (alla fine degli anni ottanta, migliaia di garimpeiros invasero il territorio degli Yanomami portando con sé malattie, violenze, morte) e nello stesso tempo rifugio, garanzia di sopravvivenza per i suoi abitanti.
Bruce Albert ci dice che è stato lo stesso Davi Kopenawa a chiedergli di mettere per iscritto le sue parole, così da “lanciare un appello” a quello che egli chiama il “Popolo della Merce”, ben consapevole della minaccia che esso rappresenta per il “futuro del mondo umano e non umano”. Per Albert non c’è dubbio che “le profezie sciamaniche di Davi Kopenawa riecheggiano, in modo inquietante, i teorici del cambiamento climatico e dell’antropocene”. Vi è da supporre che Kopenawa non avesse letto l’articolo con cui il chimico Premio Nobel Paul Crutzen e il biologo Eugene F. Stoermer nel 2000 hanno introdotto la nozione di antropocene nella cultura scientifica occidentale. Ancor più rilevante è perciò l’incontro tra le riflessioni allarmate di uno sciamano amazzonico e quelle che percorrono il mondo scientifico del popolo della merce.
Si tratta di un incontro tra i due estremi di un arco: da un lato un rappresentante dei “Popoli della Foresta” (come lo stesso Kopenawa li chiama), ossia coloro che ancora oggi vivono immersi nella più complessa e autonoma forma di vita vegetale e animale, e dall’altro i rappresentanti della più raffinata cultura scientifica e tecnologica prodotta dal popolo della città e della merce, che con la sua economia continua a devastare il pianeta, depredandone le risorse, distruggendone le principali forme di vita. In mezzo, c’è l’antropocene, cioè gli effetti trasformativi – spesso irreversibilmente – che le attività umane hanno prodotto e sempre più producono sui ritmi, i processi, le condizioni della terra, a partire quanto meno dall’epoca della rivoluzione industriale. L’antropocene è una cultura, un’enorme e intricata cultura, con le sue tecnologie, i suoi prodotti materiali, le sue teorie, i suoi valori, per cui possiamo dire che vi è una cultura dell’antropocene, ispiratrice e produttrice, ma nello stesso tempo prodotto e riflesso, di questo nuovo periodo geologico.
Vi è anche però una cultura sull’antropocene, e questa è fatta di analisi strumentali, di previsioni, calcoli e teorie scientifiche in relazione ai processi attuali e alle conseguenze per lo più catastrofiche che ne risultano. Ebbene, Kopenawa fa parte a pieno titolo di questa cultura sull’antropocenee, in quanto non soltanto denuncia la distruzione che il popolo della merce continua a operare nei confronti di urihi, il mondo della foresta, ma illustra un’altra maniera di vivere e di pensare, quella dei popoli della foresta, nettamente alternativa alla mentalità dei bianchi. In questo modo, Kopenawa può essere considerato non solo come una testimonianza vivente, ma anche il difensore di un numero indefinito di società, le quali, in moltissime parti del mondo, hanno adottato stili di vita (di pensiero e di economia) improntate a un principio di convivenza con la natura. In altri termini, sarebbe opportuno che la cultura sull’antropocene vedesse affiancato al sapere scientifico contemporaneo, il sapere che etnologi e antropologi hanno da sempre raccolto e indagato presso le società che hanno studiato, anche e soprattutto se si tratta di società che i processi dell’occidentalizzazione hanno travolto e distrutto.
Kopenawa entra consapevolmente in questa cultura “su” ciò che noi chiamiamo antropocene, non soltanto perché denuncia la devastazione della sua foresta a causa dei garimpeiros, i cercatori d’oro, e di tutti coloro che vogliono depredarne le risorse, ma anche perché si rende conto che ciò che avviene nella terra degli Yanomami è qualcosa di molto generale, che è già avvenuto nella terra dei bianchi e in chissà quante altre parti del mondo. “Ho compreso” – afferma – “che non bastava proteggere solamente la piccola parte di foresta dove abitiamo. Per questo ho deciso di parlare per difenderla tutta, compresa quella che gli esseri umani non abitano, e persino la terra dei bianchi, molto lontano da noi. Nella nostra lingua tutto questo è urihi a pree – la grande terra-foresta. Penso sia quello che i Bianchi chiamano mondo intero”.
Fare parte attiva della cultura sull’antropocene significa anche capire perché i bianchi si comportano in questo modo tanto distruttivo per tutto il pianeta. Emblematiche le pagine che Kopenawa dedica al “desiderio senza limiti” da cui i bianchi sono posseduti e che si traduce in un oscuramento del loro pensiero: “I Bianchi non pensano molto lontano davanti a sé. Sono sempre troppo preoccupati dalle cose del momento”; “il loro pensiero è corto e oscuro”; “i Bianchi mancano davvero di saggezza”. Le parole di Kopenawa si collegano in questo modo all’allarme lanciato da Amitav Ghosh, il quale si pone il problema della “grande cecità” che la cultura occidentale – la cultura dell’antropocene – manifesta proprio in relazione agli effetti devastanti che si approssimano sempre di più. Nella cultura dell’antropocene vi è una sorta di impotenza: un’incapacità a scorgere alternative praticabili. Grazie anche alle riflessioni di questo sciamano amazzonico, vi è da chiedersi se la grande cecità del popolo della merce sia dovuta a modi di pensare profondi, a scelte culturali che continuano ad agire in maniera inesorabilmente naturale, come “a priori storici” divenuti natura. Per il popolo della merce la natura non ha anima: è una riserva di risorse messa a disposizione dell’umanità da parte del suo Dio.
Per Kopenawa la terra-foresta (la natura), prima di essere una risorsa, è qualcosa di vivo. Egli afferma: “Penso che dovreste sognare la terra, perché ha un cuore e respira (…) Forse i Bianchi non la sentono lamentarsi, ma prova dolore, proprio come gli esseri umani”. Allo stesso modo, gli animali che vivono nella foresta sono anch’essi dotati di anima, come gli esseri umani. Le pagine che Kopenawa dedica ai temi dell’animismo fanno venire in mente le ricerche di Philippe Descola, di Eduardo Viveiros de Castro, di Eduardo Kohn, l’autore che significativamente ha voluto intitolare un suo recente volume How Forest Think (California University Press, 2013). Vi è da supporre che Kopenawa sarebbe molto d’accordo nel dare un aiuto ai bianchi per liberarli della loro cecità. Un aiuto importante consiste certamente nel rendere la cultura sull’antropocene non già un velo sottile e rarefatto, bensì un sapere doppiamente scientifico, fatto cioè dalla scienza della nostra stessa società e dalla saggezza, ma anche dalla scienza, delle società che hanno posto al centro delle loro preoccupazioni la convivenza con la natura. Dagli angoli di mondo come la foresta in cui Kopenawa ha scelto di vivere può ancora provenire l’insegnamento che consiste nel fare penetrare la cultura sull’antropocene nella cultura dell’antropocenee, così che il nostro sguardo si allunghi e le nostre attività siano ispirate a una saggezza più profonda e vitale.
F. Remotti è professore emerito di antropologia culturale all’Università di Torino


