Più rispetto per il senso comune
di Giorgio Biferali
dal numero di febbraio 2014
Un discreto canapè, due finestre dietro cui si nascondono i tetti di Roma, un babelico affastellarsi di libri e uno scrittore, Raffaele La Capria. Ha più di novant’anni e gode ancora del privilegio di essere un uomo impaziente.
La prima domanda riguarda proprio l’impazienza, da non confondere con la volgare ambizione, con l’arrivismo misero dei più. Dal “cerchio egocentrico del personaggio” al “mondo dialettico dell’uomo”, cosa intende lei per impazienza?
 È una caratteristica di uno dei miei personaggi di Un giorno d’impazienza, in cui il protagonista vuole volontariamente fare delle esperienze che invece dovrebbero essere naturali, come l’amore. L’amore o è naturale o non è un’esperienza come la vita te le fa capitare. Le esperienze vere sono quelle che capitano. È un tema indicativo nel mio modo di concepire i miei personaggi. Viviamo in un’epoca senza saggezza e senza certezze, di questa insicurezza i miei personaggi partecipano, sono personaggi non all’altezza, sono sempre inadeguati e immaturi, ma questa immaturità dà loro una certa innocenza. Ogni tanto si meravigliano di cose di cui non dovrebbero meravigliarsi, quella meraviglia permette allo scrittore di vivere appieno la pagina. Novant’anni d’impazienza è stato voluto dall’editore, ma credo che l’editore non avesse in mente tutto questo.
È una caratteristica di uno dei miei personaggi di Un giorno d’impazienza, in cui il protagonista vuole volontariamente fare delle esperienze che invece dovrebbero essere naturali, come l’amore. L’amore o è naturale o non è un’esperienza come la vita te le fa capitare. Le esperienze vere sono quelle che capitano. È un tema indicativo nel mio modo di concepire i miei personaggi. Viviamo in un’epoca senza saggezza e senza certezze, di questa insicurezza i miei personaggi partecipano, sono personaggi non all’altezza, sono sempre inadeguati e immaturi, ma questa immaturità dà loro una certa innocenza. Ogni tanto si meravigliano di cose di cui non dovrebbero meravigliarsi, quella meraviglia permette allo scrittore di vivere appieno la pagina. Novant’anni d’impazienza è stato voluto dall’editore, ma credo che l’editore non avesse in mente tutto questo.
Nel libro, lei cita spesso Goffredo Parise. I Sillabari uscirono alla fine degli anni sessanta, “in piena contestazione ideologica”, e Parise venne criticato aspramente e tacciato di disimpegno, poiché credeva nei sentimenti e non nella “vanità” delle ideologie. Lei affronta il medesimo argomento quando parla del suo primo libro, Un giorno d’impazienza. Qual è stato, e qual è ancora oggi, il suo rapporto con l’engagement? In che cosa consiste quel limite, quel confine – rivelatosi spesso troppo labile – tra la pura letteratura e un saggio di natura prettamente politica?
Sintetizzo in un detto di Gregorio di Nissa: “I concetti creano gli idoli, solo lo stupore conosce”. I concetti sono le astrazioni, le idee generali, le ideologie, la banalità del bene astratto proclamato da tante anime belle. Lo stupore è la quotidiana meraviglia per tutte le cose e nasce dalla meraviglia di stare al mondo, di vedere il mondo. Quella meraviglia è il fondamento di ogni vera scrittura perché si fonda non su dei concetti ma su delle emozioni. Qual è la vera vocazione di uno scrittore? Quella di comunicare, attraverso le parole, un’emozione. A comunicare i concetti ci pensa la filosofia, a comunicare le emozioni ci pensa la letteratura. La letteratura è la memoria delle emozioni che gli uomini hanno provato, ed è espresso in forme e parole diverse nei vari secoli, da omero fino ai giorni nostri. Quando parlo di un’emozione mi riferisco a Ettore e Andromaca, a Orfeo ed Euridice, personaggi in cui quest’emozione si concretizza. Cos’è che accade? Noi, attraverso la letteratura, possiamo riconoscere noi stessi, le nostre emozioni nei personaggi che ci arrivano dal passato. Senza di questo, i guerrieri che combattevano sotto le mura di Troia sarebbero come i fumetti dei pupazzi giapponesi che vediamo in televisione. La letteratura è l’unica scienza delle nostre emozioni.
All’inizio dell’ottavo capitolo di Ferito a morte, lei descrive così uno dei personaggi del romanzo, Rossomalpelo: “Eccolo là, seduto di fronte a me, più giovane di me, informato di tutto, e capace di indignarsi”. Quanti e quali, scrittori e non, al giorno d’oggi sono capaci d’indignarsi? E qual è la sua opinione in merito al panorama letterario contemporaneo, in Italia?
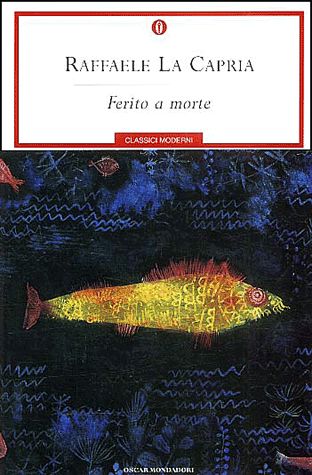 Lo scrittore non dovrebbe conformarsi all’opinione generale, al vento che tira, ma dovrebbe avere una dissenting opinion, trovare in sé una capacità individuale di reagire alle cose che avvengono. Insomma, lo scrittore dovrebbe essere nella società uno che non è amato da nessuno in particolare, perché è una mina vagante di cui non ci si deve poter fidare. Lo scrittore è qualcuno che non può essere controllabile. L’ideologia, spesso, è un controllo che si stende sull’immaginazione di certi scrittori. Uno scrittore dev’essere all’altezza di un individualismo che è al di fuori di qualsiasi appartenenza, alias controllo. A me non piacciono gli scrittori che s’indignano per professione perché credo che spesso questo tipo d’indignazione renda autopromozionali, serva a promuoversi. Oggi ci sono più risentiti, poiché il risentimento rende. Io non voglio campare sul risentimento, voglio provarlo quando capita. Riguardo agli scrittori di oggi, taluni (come Albinati, Piperno, Ammaniti, Piccolo) mi piacciono, ognuno in modo diverso, e su molti ho anche qualche critica: in generale, sento che questi sono scrittori autentici con qualche pecca.
Lo scrittore non dovrebbe conformarsi all’opinione generale, al vento che tira, ma dovrebbe avere una dissenting opinion, trovare in sé una capacità individuale di reagire alle cose che avvengono. Insomma, lo scrittore dovrebbe essere nella società uno che non è amato da nessuno in particolare, perché è una mina vagante di cui non ci si deve poter fidare. Lo scrittore è qualcuno che non può essere controllabile. L’ideologia, spesso, è un controllo che si stende sull’immaginazione di certi scrittori. Uno scrittore dev’essere all’altezza di un individualismo che è al di fuori di qualsiasi appartenenza, alias controllo. A me non piacciono gli scrittori che s’indignano per professione perché credo che spesso questo tipo d’indignazione renda autopromozionali, serva a promuoversi. Oggi ci sono più risentiti, poiché il risentimento rende. Io non voglio campare sul risentimento, voglio provarlo quando capita. Riguardo agli scrittori di oggi, taluni (come Albinati, Piperno, Ammaniti, Piccolo) mi piacciono, ognuno in modo diverso, e su molti ho anche qualche critica: in generale, sento che questi sono scrittori autentici con qualche pecca.
Parlando del suo Fiori giapponesi, lei scrive che intendeva evitare le strade già intraprese da Queneau o da Manganelli (entrambi partecipi di gruppi avvezzi a sperimentare tutte le possibilità linguistiche che la letteratura era in grado di offrire), andando oltre il manierismo sterile e concentrandosi sul contenuto. Il 2013 è stato l’anno del cinquantenario del Gruppo ’63, qual è stato e qual è il suo rapporto con quella realtà? Sanguineti, in un’intervista, sostenne che, dopo l’avvento della neoavanguardia, gli scrittori cosiddetti tradizionali cambiarono il loro modo di scrivere. È d’accordo?
Dopo il ’63, c’è stata la decentralizzazione della letteratura, che è divenuta mondiale e non più occidentale, da zone con cui prima non c’era alcun rapporto. Insomma, la letteratura dall’Europa s’è mossa. Chi aveva pensato a una scrittrice del Canada? O ai personaggi di alcuni autori giapponesi? L’avanguardia non è stata responsabile del cambiamento, semplicemente è cambiato il mondo. Nel ’63 sentivo gli avanguardisti proclamare le loro scoperte, ma erano cose che già sapevo, loro si sono solo limitati ad esaltarle. Volevano un po’ più di potere nelle case editrici, nei giornali, in tutti i luoghi in cui la cultura può esercitare il proprio potere. Di loro, ho amato Arbasino, alcuni saggi di Eco. Diciamo che quello che potevo prendere l’ho preso. Molte cose le avevo ricevute dai saggisti francesi, da Robbe Grillet e dal Nouveau Roman, che esistevano già prima del Gruppo ’63.
Rivolgendosi ai tanti che hanno la fortuna di fare il suo stesso mestiere, e forse complice della lezione calviniana sulla leggerezza, lei scrive: “Abbiate più rispetto per il senso comune”. Perdoni il gioco di parole, in che senso?
Il senso comune non è il buon senso, che è spesso egoistico e troppo protettivo, tipo “moglie e buoi dei paesi tuoi”. Il senso comune è qualcosa su cui tutti possono convenire. Se piove, tutti dicono che è cattivo tempo. Viviamo in un’epoca in cui se dici che piove quando piove, vai in un lager. In altri termini, il senso comune è quel common sense inglese che serve a riconoscere l’evidenza. Cos’è l’evidenza? Qualcosa che non è discutibile. Un uovo è un uovo, non si discute. Oggi, troppo spesso, attraverso la manipolazione dei concetti contrari alla logica elementare, devi dimostrare che un uovo è un uovo e che le evidenze sono tutte discutibili. È l’epoca in cui si fabbricano le false verità. Il senso comune è quel senso che ti fa capire che l’evidenza non dev’essere negata. Lo scrittore, oggi, non deve negare l’evidenza.
giorgio.biferali1988@gmail.com
G. Biferali è critico letterario


