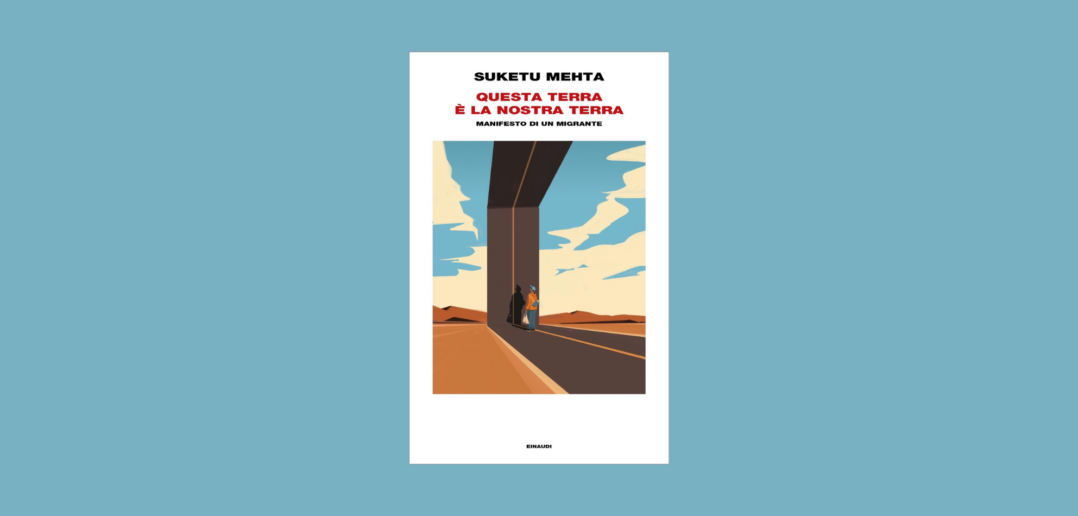Siamo qui perché voi eravate lì
di Carmen Concilio
Alcuni scrittori non si riconoscono nella definizione di “postcoloniale”: uno fra tanti, Amitav Ghosh, rifiuta categoricamente di appartenere a tale gruppo. Tuttavia, il termine postcoloniale indica piuttosto un orientamento, anche metodologico, del pensiero critico, atto a decostruire le strutture asimmetriche di potere, le gerarchie che fomentano razzismo, sessismo e specismo, che stigmatizzano l’altro, e che ha il fine di promuovere l’antirazzismo, l’accoglienza, l’ospitalità e l’inclusione. Quando Suketu Mehta in Questa terra è la nostra terra. Un manifesto dei migranti (trad. dall’inglese di Alberto Pezzotta, ed. orig. 2019, pp. 231, € 19.50, Einaudi, Torino 2021) racconta le esperienze di suo nonno in epoca coloniale, il colonialismo appare come una ferita ancora aperta: “Le atrocità di massa commesse dagli inglesi nei paesi colonizzati vengono oggi minimizzate da storici revisionisti come Ferguson e Gilley. Ma esiste un’altra storia (…) Durante la guerriglia dei Mau Mau per l’indipendenza del Kenya, mio nonno venne costretto a fare il cuoco in un campo di concentramento dove gli inglesi detenevano i ribelli. Un giorno passò davanti a una fossa colma di corpi neri. – Li buttavano dentro come cani – ricordava. In quei campi gli inglesi imprigionarono e torturano centocinquantamila kenyani”. Questo, a distanza di una sola generazione, spiega ancora gran parte dei fenomeni globali di migrazione: “Quando i migranti decidono di partire (…) partono, come sapeva mio nonno, perché il fardello della storia ha reso i loro paesi natali sempre meno abitabili. Sono qui perché voi eravate lì”. Questa non è una spiegazione semplicistica. Tutt’altro. Suketu Mehta con professionalità da giornalista d’inchiesta ha studiato il fenomeno delle migrazioni e, dati alla mano (con dovizia di facts and figures), ha verificato teorie, statistiche, studi e dibattiti del nostro tempo con la partecipe umanità di chi sa: “Risiedo negli Stati uniti da quarantadue anni. Da trenta sono cittadino americano. (…) Questo libro è scritto con dolore e collera, così come con speranza”. La sua “indagine-manifesto” parte dal Parco dell’amicizia, lungo le cancellate che separano il Messico dagli Stati Uniti, dove le coppie, i parenti, gli amici si danno appuntamento con la speranza di potersi sfiorare le dita, anche se questo semplice gesto è diventato impossibile da quando una ulteriore barriera metallica si è frapposta a quelle già esistenti. Lungo queste barriere Suketu Mehta raccoglie testimonianze di madri che fuggono dai paesi del centro e sud America per portare i propri figli lontano dalle gang criminali, anche a costo di vederseli sottrarre dagli assistenti sociali. Meglio un figlio vivo e nutrito che un figlio morto. Per le donne il viaggio non è facile, hanno solo il proprio corpo come moneta.
Lungo un altro confine, a Tangeri e Ceuta, la situazione non è molto diversa. Lì, da tutto il nord Africa si radunano capannelli di migranti, famigliole con neonati e vecchi. Suketu Mehta è ospite di un nucleo familiare: padre, madre, un neonato di cinque giorni, una vecchia parente, una cugina; devono trovare altre persone per poter pagare un passaggio in gommone, pagare il pilota, corrompere la guardia costiera. “Se veranno intercettati, saranno prelevati dal gommone e portati indietro, se ci sarà brutto tempo affonderanno”. La loro destinazione è il Belgio: là, Kalhil sogna di diventare calciatore professionista. Mehta, con un amico, porta loro uno scatolone con vestitini per il neonato; forse li venderanno, perché sul gommone possono portare solo uno zaino. In Spagna, la polizia accoglie con i manganelli i migranti in arrivo da Ceuta e li rimanda indietro.
Ci sono però anche storie a lieto fine. Una giovane donna nigeriana lavora in un negozietto di oggetti per turisti: lei ce l’ha fatta, si è integrata, è benvoluta. Proviene dalla zona del Delta del Niger, da una baracca di metallo rovente, là dove passano gli oleodotti che pompano ricchezze fuori dal paese, là dove Ken Saro-Wiwa è stato giustiziato per la sua campagna nonviolenta contro la Shell. Tarifa ha superato il mare, ha iniziato a lavorare, è molto ricercata per le capigliature a treccine, e con l’aiuto della comunità locale può mandare i propri figli a scuola, in Spagna, e sperare in un futuro migliore, fatto però solo di duro lavoro. Suketu Mehta si propone di rispondere alla domanda più cogente: perché arrivano, perché fanno paura? Le cause sono complesse e innumerevoli: il colonialismo, il neocolonialismo delle multinazionali che con i loro paradisi fiscali continuano a impoverire i paesi del sud globale, le guerre, anche quelle indotte e finanziate dagli Stati Uniti in sud America, i cambiamenti climatici. Mehta analizza ciascuna di queste cause in modo esaustivo e convincente, comparando quanto avviene negli Stati Uniti e in Europa, e poi con pazienza e buoni argomenti smantella una a una le paure fomentate dai populisti dei quattro continenti. I migranti non sottraggono lavoro ai nativi, compiono i lavori umili che i nativi non vogliono svolgere. L’arrivo dei migranti, anzi, produce nuovi posti di lavoro per i nativi, visti i servizi di cui necessitano. I migranti ripopolano e riabilitano centri storici abbandonati, fanno rifiorire i commerci e i servizi, producono a loro volta impresa, spesso nell’artigianato e nel commercio. I migranti non incrementano la criminalità, contribuiscono a farla diminuire. Le sue non sono opinioni controcorrente, ma sono argomentazioni complesse e ragionate, dimostrate sulla base di studi e proiezioni statistiche ed economico-finanziarie, che smentiscono le approssimazioni negazioniste e le falsità populiste. Tra i vari paesi presi in esame, vi sono anche esempi virtuosi: “La quota di immigrati del Canada è il triplo di quella degli Stati Uniti. (…) Oggi un canadese su cinque non è nato lì. E i canadesi sono contenti. L’82 per cento di loro pensa che l’immigrazione sia qualcosa di positivo; due terzi amano il multiculturalismo e il fatto che non esista, e che non ci debba essere, una cultura canadese uniforme. Anche i bianchi delle classi meno abbienti che hanno votato partiti populisti (…) sono a favore dell’immigrazione e del multiculturalismo. (…) la maggior parte di noi continua ad avere fiducia nel Canada come la più accogliente società multiculturale del pianeta”. Suketu Mehta affronta di petto il tema, a lui caro, delle migrazioni: il suo saggio è spesso un puntuale j’accuse; esempio di giornalismo impegnato e di testimonianza; accorato appello all’umanità; ma, soprattutto, speranzosa riscrittura del futuro. Lui, figlio di migranti e cittadino americano, che aveva già avanzato la sua proposta di liberalizzare gli affitti dei basement di New York per accogliere migranti e richiedenti asilo in La vita segreta delle città (Einaudi 2016), che aveva già decantato Jackson Heights in Maximum City (2008), quale enclave multietnica di New York, dove pure da ragazzino aveva incontrato qualche difficoltà, torna a tambur battente sul tema dei migranti, sulla necessità dell’accoglienza di rifugiati, profughi e moltitudini, ritraendoli né come vittime, né come esotici eroi, ma analizzando l’evidenza delle cause profonde che li spingono a cercare – e li inducono a creare – un mondo migliore. Ascoltiamolo.
C. Concilio insegna letteratura post coloniale all’Università di Torino