La letteratura come frutto di un’agnizione
di Domenico Calcaterra
 All’approssimarsi del trentennale della scomparsa di Leonardo Sciascia, non poche le pubblicazioni che si sono succedute nel corso dell’ultimo anno. Dalla raccolta in volume, per i tipi di Adelphi e con l’ottima curatela del solito Paolo Squillacioti, degli scritti che Sciascia dedicò al genere amatissimo del giallo (Il metodo di Maigret e altri scritti sul giallo, Adelphi, 2018), al nuovo regesto di memorie di Antonio Motta, sulle orme dei libri dello scrittore di Racalmuto (Leonardo Sciascia. La memoria, la nostalgia e il mistero, Progedit, 2018); dal ponderoso numero monografico Leonardo Sciascia trent’anni dopo dedicato dalla rivista semestrale “Il Giannone”, diretta dallo stesso Motta (anni XV-XVII, numero 29-34, gennaio-dicembre 2019) all’edizione di due interessanti epistolari utili, come spero di dimostrare fra poco, a mettere a fuoco una questione spesso trascurata: le lettere degli anni giovanili (1940-1957) rivolte al sodale Stefano Vilardo (Nessuno è felice: tranne i prosperosi imbecilli, De Piante, 2018) e il carteggio che testimonia il duraturo rapporto tra Sciascia e Consolo (Essere o no scrittore. Lettere 1963-1988, pp. 96, € 14, Archinto, 2019) e, soprattutto, il debito contratto da quest’ultimo nei confronti dell’autore delle Parrocchie di Regalpetra (Laterza, 1956) e del Consiglio d’Egitto (Einaudi, 1963). Le prospezioni nella galassia sciasciana di Antonio Motta, resoconto di una intramontata passione per l’autore e i suoi libri, nel complesso, concorrono a scorciarne un frammentario centripeto ritratto. Pezzi d’occasione che tuttavia mostrano come non di rado dall’aneddotica possa scaturire la riflessione critica; dal racconto del fatto in sé lo spunto per una quintessenziale verità da raccogliere sullo scrittore.
All’approssimarsi del trentennale della scomparsa di Leonardo Sciascia, non poche le pubblicazioni che si sono succedute nel corso dell’ultimo anno. Dalla raccolta in volume, per i tipi di Adelphi e con l’ottima curatela del solito Paolo Squillacioti, degli scritti che Sciascia dedicò al genere amatissimo del giallo (Il metodo di Maigret e altri scritti sul giallo, Adelphi, 2018), al nuovo regesto di memorie di Antonio Motta, sulle orme dei libri dello scrittore di Racalmuto (Leonardo Sciascia. La memoria, la nostalgia e il mistero, Progedit, 2018); dal ponderoso numero monografico Leonardo Sciascia trent’anni dopo dedicato dalla rivista semestrale “Il Giannone”, diretta dallo stesso Motta (anni XV-XVII, numero 29-34, gennaio-dicembre 2019) all’edizione di due interessanti epistolari utili, come spero di dimostrare fra poco, a mettere a fuoco una questione spesso trascurata: le lettere degli anni giovanili (1940-1957) rivolte al sodale Stefano Vilardo (Nessuno è felice: tranne i prosperosi imbecilli, De Piante, 2018) e il carteggio che testimonia il duraturo rapporto tra Sciascia e Consolo (Essere o no scrittore. Lettere 1963-1988, pp. 96, € 14, Archinto, 2019) e, soprattutto, il debito contratto da quest’ultimo nei confronti dell’autore delle Parrocchie di Regalpetra (Laterza, 1956) e del Consiglio d’Egitto (Einaudi, 1963). Le prospezioni nella galassia sciasciana di Antonio Motta, resoconto di una intramontata passione per l’autore e i suoi libri, nel complesso, concorrono a scorciarne un frammentario centripeto ritratto. Pezzi d’occasione che tuttavia mostrano come non di rado dall’aneddotica possa scaturire la riflessione critica; dal racconto del fatto in sé lo spunto per una quintessenziale verità da raccogliere sullo scrittore.
Ampio spazio è qui riservato a illuminare il rapporto di Sciascia con gli amici artisti che, con le loro carte, hanno impreziosito la sua bibliografia: dalla solida amicizia con Bruno Caruso, alla rottura, per le note divergenze politiche, con Renato Guttuso; all’incontro, nell’eremo di Barattoli, con il visionario e inattuale Fabrizio Clerici, là dove Sciascia ebbe modo di scoprire quel dipinto di Rutilio Manetti di un Sant’Antonio tentato dal diavolo, in cui il demone viene raffigurato con degli occhiali da intellettuale, ove la tentazione è proprio rappresentata dallo strumento che facilita il sapere, e che tanto lo colpì al punto da fargli abbandonare le carte della scomparsa di Majorana per tuffarsi nella scrittura di Todo modo (Einaudi, 1974). Quello stesso Clerici che, qualche anno dopo, avrebbe realizzato l’acquaforte, emblematicamente intitolata L’uomo solo, per la copertina del libro dell’amara svolta, L’affaire Moro (Sellerio, 1978). Il numero monografico del “Giannone”, accogliendo per lo più saggi e articoli sullo scrittore già editi, può leggersi in gran parte come una vera e propria antologia della critica. Presenta, infatti, uno sguardo a trecentosessanta gradi sull’autore: riletto nelle sue opere, analizzato sul piano formale e linguistico, sviscerato nei suoi interessi, nella poliedrica attività di scrittore, saggista, pamphlettista, giornalista, editore, appassionato d’arte e di acqueforti (quell’arte da sempre capace di stuzzicare la sua voracissima immaginazione letteraria). Per rispondere alla domanda sul peso specifico oggi dell’eredità sciasciana, anziché interrogarsi, come invero più interpreti in questi anni non hanno mancato di fare (sul “Giannone” ci prova Giulio Ferroni con un saggio intitolato Sciascia verso la fine), sullo Sciascia terminale, trovo più proficuo, per meglio addentrarsi nella comprensione del suo sistema, accostarsi alle scaturigini della sua vocazione letteraria e del suo naturale moto alla ricerca della verità: penso ai frammenti poetici di La Sicilia, il suo cuore (Bardi, 1952). Laddove si annidano – lo chiarisce superbamente in Altri italiani (Gaffi, 2010) con tersità d’argomentazione Massimo Onofri –, le ferite di un privato poi violentemente rimosse, e a cui sarebbe da ricondurre la gemma di ogni suo futuro razionalistico scandaglio. Dico la poesia che, in Sciascia, più che celebrare la gloria della lingua, è scolpita nella dura pietra del dolore, origina dal magma delle tragedie famigliari (su tutte il suicidio del fratello Giuseppe e la conseguente instabilità del padre), a un passo dall’irrompere del silenzio; prima che cessi di essere una cosa seria.
Quello stesso Clerici che, qualche anno dopo, avrebbe realizzato l’acquaforte, emblematicamente intitolata L’uomo solo, per la copertina del libro dell’amara svolta, L’affaire Moro (Sellerio, 1978). Il numero monografico del “Giannone”, accogliendo per lo più saggi e articoli sullo scrittore già editi, può leggersi in gran parte come una vera e propria antologia della critica. Presenta, infatti, uno sguardo a trecentosessanta gradi sull’autore: riletto nelle sue opere, analizzato sul piano formale e linguistico, sviscerato nei suoi interessi, nella poliedrica attività di scrittore, saggista, pamphlettista, giornalista, editore, appassionato d’arte e di acqueforti (quell’arte da sempre capace di stuzzicare la sua voracissima immaginazione letteraria). Per rispondere alla domanda sul peso specifico oggi dell’eredità sciasciana, anziché interrogarsi, come invero più interpreti in questi anni non hanno mancato di fare (sul “Giannone” ci prova Giulio Ferroni con un saggio intitolato Sciascia verso la fine), sullo Sciascia terminale, trovo più proficuo, per meglio addentrarsi nella comprensione del suo sistema, accostarsi alle scaturigini della sua vocazione letteraria e del suo naturale moto alla ricerca della verità: penso ai frammenti poetici di La Sicilia, il suo cuore (Bardi, 1952). Laddove si annidano – lo chiarisce superbamente in Altri italiani (Gaffi, 2010) con tersità d’argomentazione Massimo Onofri –, le ferite di un privato poi violentemente rimosse, e a cui sarebbe da ricondurre la gemma di ogni suo futuro razionalistico scandaglio. Dico la poesia che, in Sciascia, più che celebrare la gloria della lingua, è scolpita nella dura pietra del dolore, origina dal magma delle tragedie famigliari (su tutte il suicidio del fratello Giuseppe e la conseguente instabilità del padre), a un passo dall’irrompere del silenzio; prima che cessi di essere una cosa seria.
A suggerire una simile riflessione la lettura del “piccolo epistolario” (appena sei lettere) che Sciascia inviò tra il 1940 e il 1957 al quasi coetaneo Stefano Vilardo. Già nella prima missiva dimostra apprezzamento per ciò che l’amico va scrivendo, epperò nel contempo lo esorta ad avvertire tutta la responsabilità e la fatica del poetare: quel lavoro “più faticoso di un qualunque lavoro normale”. E subito dopo lo spiazza, ammonendolo a non considerare cosa seria il suo stesso impegno con la poesia (“non credere che con le mie poesie io faccia sul serio”). 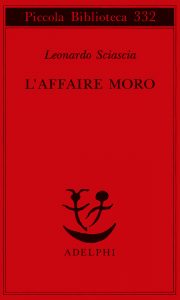 Ad anticipare la guardinga e progressiva presa di distanza dalla pratica poetica cui rimase fedele, fatta eccezione per qualche sporadica prova, dalla metà degli anni cinquanta in poi. Entrambi impegnati a fare i conti con l’ingombrante lezione quasimodiana e a porre maniacale attenzione ai dati del paesaggio (fisico ed interiore). Stefano Vilardo, il compagno, l’amico di una vita, bonariamente invidiato, per il suo essergli vicino, da un poco più che esordiente Vincenzo Consolo (lettera del 16 agosto 1964). Quel Consolo che proprio nelle lettere di devota ammirazione rivolte al maestro trasfonde tutta la sua voglia di emanciparsi dalle angustie del “natìo borgo scipito” (lettera del 15 aprile 1967), quell’isolamento che l’autore della Ferita dell’aprile (Mondadori, 1963) riconosce nuocergli non poco, per il fatto che alimenta infondati timori (strozzato com’è dalle infinite cure che gli derivano dal “clan” familiare).E anche dopo, a espatrio dall’isola da tempo avvenuto, Consolo, frastornato dall’essersi misurato con la lettura dell’Affaire Moro, avverte e confida a Sciascia un montante “senso di colpa”, per quel non riuscire a mantenersi “lucido” e “laico” nello scrivere, in preda alle risorgenti sirene “degli ornamenti” (leggi poesia) nella visione della “nuda realtà”. E senso di colpa che tracima nella paura, se è vero che Consolo, scrittore peraltro già affermato nel panorama italiano a quell’altezza cronologica, a proposito del risvolto di Retablo (Sellerio, 1987) scritto da Sciascia, incamerato il giudizio positivo dell’amico e mentore, si lascia andare a un’altra eloquente confessione: “Però io ho così paura di scrivere, scrivo così poco”.
Ad anticipare la guardinga e progressiva presa di distanza dalla pratica poetica cui rimase fedele, fatta eccezione per qualche sporadica prova, dalla metà degli anni cinquanta in poi. Entrambi impegnati a fare i conti con l’ingombrante lezione quasimodiana e a porre maniacale attenzione ai dati del paesaggio (fisico ed interiore). Stefano Vilardo, il compagno, l’amico di una vita, bonariamente invidiato, per il suo essergli vicino, da un poco più che esordiente Vincenzo Consolo (lettera del 16 agosto 1964). Quel Consolo che proprio nelle lettere di devota ammirazione rivolte al maestro trasfonde tutta la sua voglia di emanciparsi dalle angustie del “natìo borgo scipito” (lettera del 15 aprile 1967), quell’isolamento che l’autore della Ferita dell’aprile (Mondadori, 1963) riconosce nuocergli non poco, per il fatto che alimenta infondati timori (strozzato com’è dalle infinite cure che gli derivano dal “clan” familiare).E anche dopo, a espatrio dall’isola da tempo avvenuto, Consolo, frastornato dall’essersi misurato con la lettura dell’Affaire Moro, avverte e confida a Sciascia un montante “senso di colpa”, per quel non riuscire a mantenersi “lucido” e “laico” nello scrivere, in preda alle risorgenti sirene “degli ornamenti” (leggi poesia) nella visione della “nuda realtà”. E senso di colpa che tracima nella paura, se è vero che Consolo, scrittore peraltro già affermato nel panorama italiano a quell’altezza cronologica, a proposito del risvolto di Retablo (Sellerio, 1987) scritto da Sciascia, incamerato il giudizio positivo dell’amico e mentore, si lascia andare a un’altra eloquente confessione: “Però io ho così paura di scrivere, scrivo così poco”.
Siamo a un punto sintomatico nel rivelarsi dell’autobiografia del rimosso di questi due giganti del secondo Novecento: l’affrettarsi di Sciascia a chiarire all’amico e aspirante poeta Vilardo di non prendere sul serio le proprie poesie; il senso di colpa confidato da Consolo per il non essere riuscito a sottrarsi al richiamo del demone della poesia (che pure da sempre lo abita). Sentimento di negazione, senso di colpa, intimamente vissuti come allarmante diversione non tanto dall’impegno, quanto da un più razionale (controllato e controllabile) magistero di scrittura. Ecco che una simile fuga dalla poesia – in apparenza più netta in Sciascia, frutto di irrisolta crisi e del tutto utopica, almeno stando agli esiti, in Consolo – denuncia l’incompatibilità con le esigenze che, da un certo momento in poi, si affermano per entrambi gli scrittori. E per entrambi vale senz’altro ciò che lo stesso Sciascia scrisse nel 1954, con profonda convinzione, a proposito della poesia di Mario Tobino (si legga il bel saggio che Paola Italia dedica sul “Giannone” proprio all’amicizia tra i due), ossia che “un discorso sul poeta non può che risolversi in un discorso sull’uomo”: indicazione che suona come dichiarazione d’implicita autobiografia e che non può non applicarsi alla sua precoce e iniziale passione per la poesia (tuttavia presto accantonata). Come dire che è impensabile imbastire discorso alcuno su Sciascia che non tenga conto della “pianta uomo”, non principi da quel trascurato alfa poetico.
Un’arretrata e limitante percezione dell’autore, nonostante lo sforzo critico compiuto negli ultimi vent’anni da numerosi interpreti (spia evidente di quello scollamento tra scuola e critica che Guido Baldi, nella sua ultima raccolta di saggi, indica come causa principale del declino dell’insegnamento della letteratura nelle aule), rimane lacuna a oggi non colmata nel mondo della scuola in cui viene ancora letto, in maniera assai selettiva, ed entro una prospettiva regionalistica, esclusivamente come “mafiologo”; soltanto come l’autore che ha saputo decrittare, attraverso opere come Il giorno della civetta (Einaudi, 1961), ai siciliani e al mondo, l’antropologia mafiosa. Il futuro della lezione sciasciana, potremmo desumerne, è infine ostaggio del paradosso per cui questo classico della letteratura contemporanea non ha ancora incontrato il suo vero pubblico: quello dei giovani d’oggi, degli studenti di domani. Rimane da chiedersi quale il lascito più grande di uno scrittore che più di tutti forse è riuscito nell’impresa di rischiarare il nesso tra inventio e realtà, finzione e verità; peraltro praticando una riconoscibilissima cifra stilistica per cui riesce “saggista nel racconto e narratore nel saggio”. Senza dubbio la più grande verità di cui sentirsi debitori a Leonardo Sciascia è che la letteratura, ci ha insegnato, si consuma sempre come avventura conoscitiva, detection; frutto di un’agnizione, una presa di coscienza (sia per l’autore, sia per il lettore). Niente di diverso da ciò che accade poi con la critica.
domenico.calcaterra@gmail.com
D. Calcaterra è insegnante e saggista


