Con scrupolo e chiarezza
di Luciano Zampese
La rivista bimestrale “Comunità” di Adriano Olivetti pubblica tra il dicembre 1953 e l’aprile successivo tre interventi intitolati Lo sterminio degli ebrei d’Europa, a firma di Ugo Varnai, pseudonimo di Luigi Meneghello; il secondo intervento avrà il sottotitolo Auschwitz, e l’ultimo sarà dedicato ai Risultati della “soluzione finale”, con un apparato di dati e tabelle, e una particolare attenzione all’Italia (i tre articoli saranno riproposti in Promemoria, pubblicato nel 1994 dal Mulino). L’occasione immediata è l’opera di Gerald Reitlinger, The Final Solution. The Attempt to Exterminate the Jews of Europe 1939-1945 (London, 1953), così descritta da Meneghello in una lettera a Renzo Zorzi (direttore di “Comunità”): “Un esauriente volume appena uscito (G. Reitlinger, The Final Solution; oltre 500 pagine di orrori espressi in cifre e documenti). 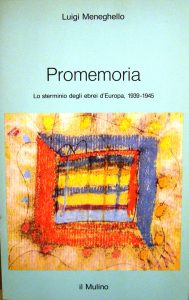 Sarebbe importantissimo render noto al nostro pubblico queste cose, di cui i nazionalisti nostrani vanno dicendo che mancano le prove!”.
Sarebbe importantissimo render noto al nostro pubblico queste cose, di cui i nazionalisti nostrani vanno dicendo che mancano le prove!”.
Nasce così il resoconto di Varnai-Meneghello, che nella sua stessa estensione (una ventina di pagine fittissime) e soprattutto nello straordinario corredo fotografico (25 immagini e tre cartine geografiche) rappresenta un’anomalia rispetto alle architetture della recensione. Le foto sono il risultato di una minuziosa ricerca di Meneghello, cui ha in parte collaborato anche Reitlinger (il cui libro però si limitava a qualche cartina geografica), e rappresentano una tappa importante nella costruzione dell’immaginario della Shoah in Italia (ci sarà anche una minaccia di denuncia per offesa al pudore, per una straziante foto di madri in fila verso il massacro, nude e con in braccio i loro bambini). Tra le fonti risalta uno straordinario volume, pubblicato a Lodz nel dicembre 1945, Extermination of Polish Jews. Album of Pictures (a cura del Central Jewish Historical Committee in Poland), che illustra la tragedia degli ebrei polacchi dai primi scherzi razzisti ai ghetti, ai campi di sterminio, alla resistenza e al ritorno dei sopravvissuti sui luoghi del massacro, in 252 immagini con ricche didascalie in sei lingue (tra cui ebraico e yiddish): un testo che varrebbe la pena di ripubblicare.
Per una minima contestualizzazione, andrebbe richiamato il clima di marginalità o di vera e propria rimozione che vigeva in quegli anni attorno ai crimini tedeschi contro gli ebrei: se al processo di Norimberga non era emerso alcun capo d’imputazione specifico per lo sterminio ebraico, la situazione internazionale caratterizzata sempre più dai due blocchi e dalla guerra fredda, con la ricostruzione della Germania Ovest e la sua progressiva integrazione economica e militare, rendevano sempre meno polically correct l’evocazione del fantasma nazista. In Italia poi c’erano ulteriori ostacoli: il ritardo e la povertà di informazioni sui campi di sterminio (Matard-Bonucci parla di “situation atypique de la presse italienne”); il desiderio di addossare l’ideologia razzista al nazismo e alle sole gerarchie fasciste (e solo in una fase tarda), mentre il popolo assumeva il mito degli “italiani brava gente”; il sovrapporsi di sofferenze reali ma d’altra natura che assorbivano l’esperienza degli ebrei in un più generale e “virtuoso” paradigma resistenziale (Filippo Focardi ha parlato di “racconto egemone” dell’antifascismo, e per Gadi Luzzato Voghera, gli ebrei, paradigma perfetto delle vittime del nazismo, “venivano arruolati ipso facto nel campo della resistenza antifascista”); e infine la semplice impellenza dei problemi sociali ed economici del dopoguerra e lo slancio verso il futuro. Fatto sta che Primo Levi apre così un suo articolo dell’aprile del 1955 (nel decennale della liberazione), dal significativo titolo di Deportati: “A dieci anni dalla liberazione dei Lager, è triste e significativo dover constatare che, almeno in Italia l’argomento dei campi di sterminio, lungi dall’essere diventato storia, si avvia alla più completa dimenticanza”. Colpisce che anche qui vengano mescolati deportati politici ed ebrei, dalle tabelle con i dati numerici delle vittime, alla mappa dei “campi di concentramento”, fino all’immagine di chiusura, la cui didascalia recita: “Arrivo a Torino della salma del deportato ignoto”. Si capisce allora, con le parole di Gordon, come gli interventi di Meneghello “esponevano, sostanzialmente per la prima volta in italiano – quanto meno dopo i resoconti improvvisati, ‘a caldo’, dei mesi immediatamente successivi alla guerra – una sintesi della storia della Soluzione finale”.

La collaborazione di Meneghello con “Comunità” era agli inizi, ma nel segno di un’etica di scrittura molto lucida: alla richiesta di Zorzi di un parere sulla rivista, Meneghello aveva caldeggiato una divulgazione storica “scritta con scrupolo e chiarezza, senza pretese di contributi specializzati ma anche senza concessioni alle debolezze di una parte del pubblico”, e il destinatario ideale sarebbe stato una “persona di media cultura che sa poco di storia italiana ed europea e d’altra parte si trova isolata fra le riviste specializzate e i periodici a sensazione”. Più avanti annota: “si tratta di farsi capire, e soprattutto di non voler dire più di quel che s’ha da dire”. Una pulizia di stile che traduce un’etica della comunicazione.
Meneghello nel 1953 propone a Zorzi un mannello di articoli ad argomento tedesco, convinto – anche per una personale inchiesta tra i suoi amici – che in Italia “la conoscenza è poca e l’interesse estremamente vivo. E mi pare che sarebbe un peccato rinunciare a battere, una volta tanto, con scritti onesti e obbiettivi, i periodici a sensazione. Questo è uno dei pochi campi in cui ciò appaia possibile. Vincere sui rotocalchi, ma superare anche le secche di una prosa accademica “sensata e plausibile nella sostanza, attendibile come raccolta ragionata dei materiali, ma un po’ angusta e cauta”, e a cui magari manca “il lievito di un alto interesse per i problemi etico-politici”: cito dalla recensione di Meneghello (“Comunità”, giugno 1953), alle settecento pagine di Alan Bullock dedicate alla biografia di Hitler.
Il saggio di Reitlinger sembra avere ulteriori problemi: alla straordinaria ricchezza dei contenuti, frutto di “parecchi anni di scrupolose ricerche”, non corrisponde secondo Meneghello un’adeguata dispositio ed elocutio: “Peccato che sia per la natura del materiale, sia per gli intenti non divulgativi dell’autore, il suo libro risulti assai difficile a leggersi. Impegnato a ricavare i fatti contenuti nei suoi documenti l’autore non indugia a raccontare e tanto meno a descrivere. Così per poter usare il suo indispensabile lavoro, bisogna adattarsi a studiarlo e qualche volta a riassortirne i materiali”. Se uno studioso o anche uno studente possono adattarsi a studiare un libro, il compito di un giornalista serio sarà quello di rendere leggibili i risultati di questa ricerca. Si tratta di un compito sommamente etico, vista la desolante e pericolosa situazione della coscienza europea su un simile tema: “Ciò che i tedeschi fecero agli ebrei d’Europa dal 1939 al 1945 non ha lasciato nella coscienza degli europei che un’immagine confusa di inconcepibili stragi. In questa forma riesce più facile evitare di pensarci”. Partendo da queste premesse, enunciate nel sommario del primo intervento, Meneghello inizia a raccontare la Shoah, in una lucida selezione e ristrutturazione dei dati, dei documenti, delle analisi, “con scrupolo e chiarezza”, per una scrittura “che vuol farsi capire”. E qui si affronta forse la prova più alta, perché l’intrinseca natura d’orrore dei fatti si intreccia con il vissuto della moglie Katia Bleier, ebrea ungherese, come confessa in una lettera a Zorzi a proposito dei sottoclichés alle foto delle selezioni ad Auschwitz (affiancate dalla cartina dell’Ungheria), in apertura del terzo contributo: “Nello scrivere questi (i sottoclichés) che ti mando mi ha paralizzato l’impegno a non lasciarmi prendere la mano dal sentimento – forse sai che mia moglie fu deportata a Auschwitz dall’Ungheria nel ’44 e perdette in questa prima selezione papà e mamma oltre a altri parenti (tra cui un nipotino di quattro anni)”. Tenere a bada l’emozione è un altro tratto di questa scrittura al servizio dell’informazione e del lettore, da affiancare alla lotta contro la retorica, vizio così tipicamente italiano e fascista.
Enfant prodige del fascismo (aveva vinto a 18 anni i Littoriali della cultura), Meneghello rinasce dolorosamente e a poco a poco nell’esperienza partigiana e poi del Partito d’Azione: la delusione del dopoguerra lo conduce in Inghilterra, all’Università di Reading a studiare e poi a insegnare; qui fa le sue prime prove di scrittura accademica, e in una lettera del gennaio del 1949 a Licisco Magagnato (tra gli amici più cari, e modello di rigore etico e impegno politico) Meneghello confessa: “Mi trovo impacciatissimo in queste prime esperienze di… storico. Quanto s’ha da sapere e da capire per scrivere una pagina vera, mi è sempre una sorpresa”. Gli articoli di “Comunità”, la forma della recensione, del resoconto, il passaggio dalla scrittura accademica a quella di alta divulgazione offriranno i modi e gli scopi che daranno fine a questo impaccio, in attesa della scrittura letteraria, dei capolavori di Libera nos a malo e dei Piccoli maestri.
luciano.zampese@unige.ch
L. Zampese insegna linguistica italiana all’Università di Ginevra e latino e greco al liceo classico di Thiene (VI)


