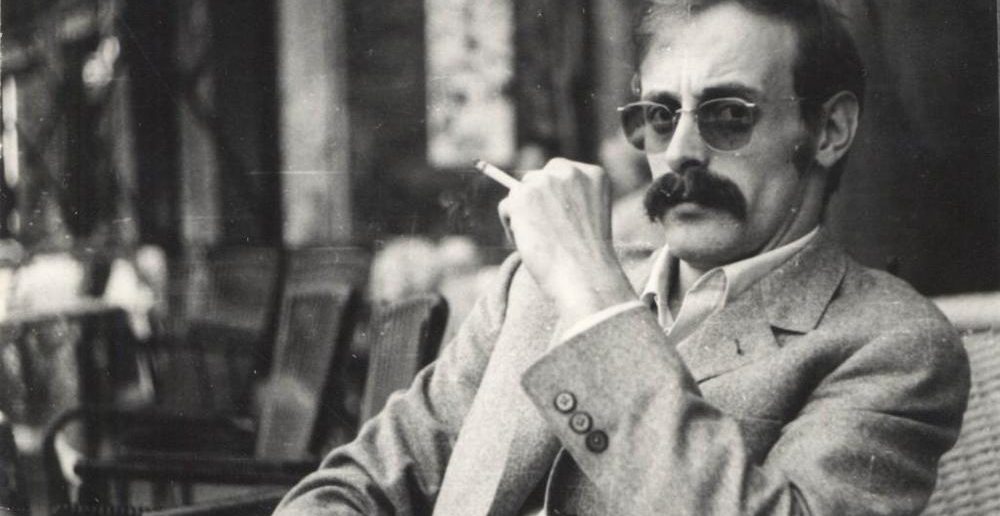Dal numero di marzo 2000
di Antonio Tabucchi
Il portoghese José Maria Eça de Queirós è oggi universalmente riconosciuto come uno dei massimi scrittori dell’Ottocento europeo. In Italia, tuttavia, al di là di una fama consolidata soprattutto per sentito dire, alla quale hanno dato un contributo anche illustrissimi filologi, e lusitanisti “per diletto” come Gianfranco Contini, il riconoscimento che spetta a uno scrittore come Eça sembra stentare a verificarsi sul piano pratico. La sua opera, dispersa in una miriade di editori e in gran parte in traduzioni obsolete e difficilmente reperibili, costituisce una sorta di scissione nucleare impossibile da ricompattare. A differenza di altri paesi, dove i suoi romanzi e racconti sono giudiziosamente raccolti e annotati in opere complete così come lo meritano Balzac, Stendhal, Flaubert, Gogol’ o altri scrittori del suo calibro, in Italia ci dobbiamo accontentare di schegge che l’editoria ci regala occasionalmente, spesso anche di pregevole cura (penso ad esempio al Mandarino, curato da Paolo Collo per Einaudi nel 1988, o a La città e le montagne, tradotto l’anno scorso da Nicoletta Vincenti per le edizioni Tarara).  È pur vero che uno scrittore come Eça costituisce a suo modo uno scoglio per una serena accoglienza perfino in patria. Estrangeirado come formazione (così il Portogallo definisce, analogamente al Giappone, i suoi scrittori che hanno vissuto all’estero e che si sono nutriti di una cultura diversa), ferocemente caustico nei confronti dei costumi del suo paese (si pensi ad esempio al Cugino Basilio, impietoso ritratto di una società e di un’anima lisbonese che trova analogie nella Madame Bovary di Flaubert; o a I Maia, amaro affresco della decadenza di un’aristocrazia e di un’alta borghesia che, come avrebbe detto Pessoa, “dopo avere scoperto le Indie restò disoccupata”), spietato nell’affondare il rasoio della sua narrativa, fino a rischiare scomuniche, nel sordido mondo clericale del Portogallo di fine Ottocento intriso di bigottismo, loschi costumi e profondo oscurantismo – quello stesso che poi produrrà personaggi come il cardinal Cerejeira, compare, oltre che intimo amico di Antonio Oliveira Salazar (si pensi a romanzi come La colpa di Padre Amaro o La reliquia), Eça non è certo uno di quegli scrittori che un paese ami eleggere a rappresentante del proprio spirito nazionale. Ma a differenza di Gogol’, con il quale credo presenti molte analogie, Eça non ebbe una tardiva conversione (vera o presunta che sia stata quella gogoliana), che consenta di recuperarlo in termini positivi, così come una certa critica russa ha tentato di fare a suo tempo con Gogol’.
È pur vero che uno scrittore come Eça costituisce a suo modo uno scoglio per una serena accoglienza perfino in patria. Estrangeirado come formazione (così il Portogallo definisce, analogamente al Giappone, i suoi scrittori che hanno vissuto all’estero e che si sono nutriti di una cultura diversa), ferocemente caustico nei confronti dei costumi del suo paese (si pensi ad esempio al Cugino Basilio, impietoso ritratto di una società e di un’anima lisbonese che trova analogie nella Madame Bovary di Flaubert; o a I Maia, amaro affresco della decadenza di un’aristocrazia e di un’alta borghesia che, come avrebbe detto Pessoa, “dopo avere scoperto le Indie restò disoccupata”), spietato nell’affondare il rasoio della sua narrativa, fino a rischiare scomuniche, nel sordido mondo clericale del Portogallo di fine Ottocento intriso di bigottismo, loschi costumi e profondo oscurantismo – quello stesso che poi produrrà personaggi come il cardinal Cerejeira, compare, oltre che intimo amico di Antonio Oliveira Salazar (si pensi a romanzi come La colpa di Padre Amaro o La reliquia), Eça non è certo uno di quegli scrittori che un paese ami eleggere a rappresentante del proprio spirito nazionale. Ma a differenza di Gogol’, con il quale credo presenti molte analogie, Eça non ebbe una tardiva conversione (vera o presunta che sia stata quella gogoliana), che consenta di recuperarlo in termini positivi, così come una certa critica russa ha tentato di fare a suo tempo con Gogol’.
Eça è a suo modo un irriducibile, e una sua lettura in chiave di anima nazionale da parte della critica del suo paese rivela una difficoltà di fondo che, quando non lascia trasparire una inconscia ostilità, si rifugia in un tentato e spesso difficoltoso recupero. Si pensi alla soddisfazione con cui, durante tutto il secolo, la critica portoghese nel suo complesso (salvo rare eccezioni) ha letto l’ultimo romanzo queirosiano Le città e le montagne, come il nostos di un enfant gàté che, dopo aver snobisticamente dissipato la sua vita nelle grandi capitali europee, giunge ad apprezzare finalmente i genuini sapori del Portogallo rurale. Insomma: il cosmopolita che alla fine riconosce la moglie e i buoi dei paesi suoi. Per tutti questi motivi e altri ancora avrei voluto salutare con allegria il recente volumetto dei racconti completi, la cui ultima edizione risaliva alle ormai lontane traduzioni di Mario Puccini nella “Bur” e di Camillo Berrà per la Utet, entrambe del 1953 (a parte la ragguardevole “scheggia” del racconto José Matias, curato in maniera perfetta da Luciana Stegagno Picchio per l’editore Tranchida nel 1992).
Purtroppo, vista l’edizione dei racconti proposta ora dalla Rizzoli per la sua illustre collana economica, mi chiedo per quale motivo, invece di utilizzare, magari rivedendola, una traduzione vecchia ma dignitosa, si pubblichi una traduzione che fa strage non solo del testo originale, ma perfino della lingua italiana. Con l’aggravante che il volume ha ricevuto la sovvenzione del Ministero della Cultura portoghese e dell’Istituto portoghese del libro, che esibiscono le loro sigle nella prima pagina. Per usare un linguaggio politico, si potrebbe dire che si tratta quasi di una “strage di Stato”. Mi limiterò al primo racconto, uno dei più celebrati dell’opera di Eça de Queirós: Singularidades de urna rapariga loira, tradotto con Singolarità di una ragazza bionda, dove il termine “singularidades” – uno dei tanti falsi amici nel cui tranello cadono spesso i traduttori – appartiene a un’area semantica che significa piuttosto “originalità”, “stranezze”, e che tradotto con “singolarità” può apparire singolare. Così com’è singolare che venga adottata l’arcaica grafia “Queiroz”, in luogo dell’ormai corrente “Queirós”, ignorando la riforma ortografica che il Portogallo ha avuto nel Novecento. Sarebbe come se all’estero traducessero il Principe del “Machiavello”, o simili. Il testo queirosiano, costruito sul procedimento dell’io-narran-te che racconta un racconto che egli ascoltò da un altro, è la storia di due sconosciuti che si incontrano di sera in una locanda fra i monti. Il luogo, l’anonimato e la notte favoriscono una confidenza altrimenti impossibile, la narrazione di un equivoco che segnò irrimediabilmente la vita di un uomo: l’amore fatale per una donna che sembrava angelica e che si rivelò tutt’altro che un angelo.
Ma veniamo alla traduzione. Se, poniamo, parla un io-narrante che è un signore che arriva in diligenza in una località del Nord del Portogallo in una notte di “un freddo fine e secco”, sappiamo che in italiano si direbbe “pungente e asciutto”. Questo signore ha appena attraversato un paesaggio “escarpado e àrido”, che non è naturalmente “scosceso e piatto” (cosa che neppure il paesaggio più disponibile del mondo può essere contemporaneamente) ma un paesaggio “scosceso e desertico”. La notte è di tempesta e, ci dicono i traduttori, “l’elettricità si addensava in alto”. Solo che in portoghese “nas altruras” non significa “in alto”, ma “sulle alture”, o, se si preferisce, “sui monti”. Farò il possibile per “rotolare” anch’io su una diligenza che, dicono i traduttori, “rotolava continuamente” (nel senso che “correva monotona”), così come scivolo anche su una frase che sembra provenire da una commedia di Ionesco: “Mi trovavo ad essere tiranneggiato dall’immaginazione e dalle chimere”, che significa che la persona in questione si sentiva assediata dalla sua immaginazione e dalle sue fantasie. Lo sfortunato personaggio si trova finalmente in una locanda dove un’onesta cameriera, manovrando una “brocca invetriata” (che sta naturalmente per “brocca di porcellana”), fa spillare nel suo bicchiere del buon vino “facendolo cadere dall’alto” (che significa naturalmente “versandolo nel bicchiere”). Dopo tale onesta mescita, che evidentemente provoca allegria nell’avventore tanto da farlo ridere apertamente (“largamente”, intendono i traduttori) il commensale che gli sta di fronte, sollecitato da una domanda forse troppo intima, si chiude in un “silenzio vistoso” (che è ovviamente un “ostentato silenzio”). La faccenda si complica quando il personaggio pronuncia al suo commensale una frase grazie alla quale egli capisce che “aveva toccato la carne viva di un ricordo”. Dove in portoghese il modismo “carne viva” significa semplicemente “ferita”, che qui naturalmente ha un suo senso (“la ferita di un ricordo”). Poche righe più in basso l’incauto avventore si rende conto che “il caso di quell’uomo era dovuto essere grottesco”, dove il grottesco sta soltanto nell’uso dei verbi italiani. E, nel frattempo, l’insistente commensale va decantando all’altro personaggio, località per località, gli attributi delle bellezze femminili del Portogallo settentrionale.
Le donne di Vila Real sono le più belle donne del mondo, specifica il Nostro, e puntualizza: “Per gli occhi, Guimaràes”. E qui ci siamo. “Per i corpi” (avremmo preferito “per il corpo”, o “per il personale”, ma pazienza), Santo Aleixo. E qui ci siamo ancora. “Per le vite sottili, Viana” (avremmo preferito il singolare), ma anche qui ci siamo quasi. E infine, “per le belle pelli, Amarante”. Dove le “belle pelli”, che è termine di conceria, dovrebbe stare per “incarnato”. E qui non ci siamo proprio. Andiamo avanti. Con “ampia e sentita confidenza” viene tradotto il participio passato e aggettivo “sentido” che in portoghese è un perfido falso amico che indica risentimento e che significa appunto “risentita” oppure “amara confidenza”. Che poi questo signore, all’epoca delle sue passioni, manifestasse una “spiccata lindezza di abito e di biancheria”, non significa che facesse la pubblicità a qualche detersivo, ma che prestava attenzione all’eleganza del suo vestire. Erano i tempi, rimpiange il personaggio, “in cui l’epoca era casalinga e ristretta”, che detto fra noi significa che la vita, a quel tempo, era parca e la si trascorreva fra le mura di casa (una vita “sobria e domestica”). Peraltro, ci assicurano i traduttori, quella era l’epoca “di una borghesia cautelosa”, che naturalmente significa “borghesia timorata”. Rimpiangendo un passato che non c’è più, il nostro infelice personaggio, che si trovava su una poltrona, “facendo come i gatti sensibili che si sfregano” (che in una lingua da cristiani vorrebbe dire “certi gatti voluttuosi che si strofinano alle gambe”), “decise sbadigliando che la sua vita era monotona”. Dove il verbo “decidir” significa solo “arrivare alla conclusione”. Per il resto vado di fretta, limitandomi soprattutto all’italiano. Di solito un innamorato dice “sono pazzo di te”. Qui “era matto di lei”. “Solo nel pomeriggio, la tenda si arricciava”, nel senso che la tenda “si increspava”, perché qualcuno la spostava con la mano per sbirciar fuori. Lo zio del protagonista, proprietario di un fiorente commercio di stoffe a cui erano spariti dei fazzoletti di seta, rimprovera il nipote, ivi impiegato contabile, con questa frase insensata: “è l’abitudine di lasciare entrare poveri nel magazzino”. Dove “armazém” in portoghese significa “bottega”, e che quindi va tradotta “è l’andazzo di lasciare entrare i mendicanti in bottega”. Si passa poi alla descrizione di alcune serate in una salotto della borghesia dell’epoca, serate che i traduttori rendono con “riunioni” e che all’epoca si chiamavano “veglie” (vedi il Fucini delle Veglie di Neri). A tali serate partecipa tutta una serie di personaggi che sembrano usciti da una stampa del Daumier: il canonico del posto, l’immancabile e ispirata dama che suona il clavicembalo, il notaio letterato e il poeta di turno. Poeta, poverino, che vediamo entrare nel salotto “con il naso adunco e fatale” e soprattutto con “un tubo di latta nella mano” (che se i lettori indovinano cos’è vincono il superenalotto). Mentre il povero notaio, latinista e amico delle muse, scriveva in un giornale dell’epoca che secondo i traduttori si intitolerebbe “La Mezzana delle Da- me”. Ora, il termine “alcofa” ha in portoghese una doppia derivazione: la prima, dal verbo “alcofar’, che in origine significa “preparare, sistemare”, ha dato “alcoviteira” e cioè persona ruffiana e mezzana; la seconda, dall’arabo “al-quffiz”, che significa “cesto”, “paniere”. Ahimè, i traduttori si sono scoraggiati nella non difficile ricerca lessicale fermandosi sciaguratamente al primo termine.
Ve lo immaginate, in un salotto della Restaurazione frequentato da una borghesia “cautelosa” come quella, un notaio così perbene che scriveva su una rivista che invece di chiamarsi timoratamente, come difatti si chiamava, “Il Cestello delle Dame” (cestello nel quale si indovinano multicolori gomitoli di lana con i quali le timorate dame facevano la calza), si chiamava la “Mezzana delle Dame”? Si sarebbe meritato il fuoco del rogo inquisitoriale, che a quell’epoca in Portogallo non era ancora del tutto spento. 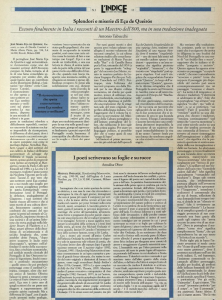 Sorvolo su tutta l’onomastica portoghese che tradotta nella nostra lingua ci fa sentire in una provincia italiana: Joào V che diventa re Giovanni Quinto, il mottetto pernambucano intitolato, Lindas moqas, lindas moqas, che diventa “una canzonetta di Pernambuco, Belle ragazze, belle ragazze”, o i toponimi tipo Rua dos Calafates che diventa Via dei Calafati. Una lista di questa fiera della castronerie costituirebbe un elenco telefonico: “la notte si svolgeva spiritualmente”, “era rimasta rattrappita dalla paura”, “i guaiti degli isterismi”, “gesticolava con l’occhia-letto”, “il cavaliere tutto curvato e con un occhio strizzato, faceva la somma delle puglie sul dorso di un asso”. Termino con una scena surrealista: la carrozza reale ritorna da una corrida conclusasi tragicamente: il re è dentro la carrozza, “con i cocchieri impiumati, i muli pieni di sonagli e i battitori con i pungiglioni”. Pensare a guardie che avessero in mano delle picche e delle alabarde, sono buoni tutti. Ma immaginarli come un nugolo di calabroni, questa sì che è fantasia! Quello che sorprende di questo massacro è che esso sia opera non di due allegri dilettanti, ma di due persone che, riporta il volume, si presentano con le credenziali degli studiosi. Maria Abreu Pinto è lettrice di portoghese dell’Istituto Camòes all’Università di Firenze, e Davide Conrieri (cito) “insegna alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si occupa di letteratura italiana e delle relazioni fra letteratura italiana e portoghese”. Il primo caso è meno preoccupante, perché i lettori non hanno responsabilità di docenza stabile in Italia. Il secondo solleva invece maggiori perplessità, perché seppure con la limitata responsabilità del livello di ricercatore, pone seri interrogativi sullo stato della conoscenza della lingua italiana in una scuola che dovrebbe essere di grande prestigio. Possibile che questo giovane (credo) italianista di una scuola prestigiosa non abbia avuto un maestro che gli abbia insegnato l’italiano? O, dubbio ancor più inquietante, non gli avranno mica detto che va bene così? Che poi egli si occupi non solo di letteratura italiana (e qui c’è da augurare ai suoi studenti che Dio gliela mandi buona) ma anche “delle relazioni fra la letteratura italiana e portoghese”, risulta ancora più allarmante. Al di là della diligente introduzione, utile e uggiosa come una tesi di laurea compilativa, per un così delicato lavoro comparatistico bisogna sapersi muovere come un pesce in entrambe le acque culturali, e ciò richiede un serio e lungo tirocinio filologico, linguistico e letterario, e non qualche bracciata annaspante tanto per tenersi a galla. Non vorrei chiudere concludendo che ai miei tempi, in quella scuola, gli studi di italianistica erano ben altra cosa: rischierei di essere considerato un vecchio nostalgico dalla mentalità “cautelosa”. Purtroppo, più che a cautela i tempi inducono allo sconforto, e questa disinvolta operazione che in un batter d’occhio rende simultaneamente un cattivo servizio alla lingua italiana e al maggior scrittore portoghese dell’Ottocento ne è, fra le tante, una malinconica conferma.
Sorvolo su tutta l’onomastica portoghese che tradotta nella nostra lingua ci fa sentire in una provincia italiana: Joào V che diventa re Giovanni Quinto, il mottetto pernambucano intitolato, Lindas moqas, lindas moqas, che diventa “una canzonetta di Pernambuco, Belle ragazze, belle ragazze”, o i toponimi tipo Rua dos Calafates che diventa Via dei Calafati. Una lista di questa fiera della castronerie costituirebbe un elenco telefonico: “la notte si svolgeva spiritualmente”, “era rimasta rattrappita dalla paura”, “i guaiti degli isterismi”, “gesticolava con l’occhia-letto”, “il cavaliere tutto curvato e con un occhio strizzato, faceva la somma delle puglie sul dorso di un asso”. Termino con una scena surrealista: la carrozza reale ritorna da una corrida conclusasi tragicamente: il re è dentro la carrozza, “con i cocchieri impiumati, i muli pieni di sonagli e i battitori con i pungiglioni”. Pensare a guardie che avessero in mano delle picche e delle alabarde, sono buoni tutti. Ma immaginarli come un nugolo di calabroni, questa sì che è fantasia! Quello che sorprende di questo massacro è che esso sia opera non di due allegri dilettanti, ma di due persone che, riporta il volume, si presentano con le credenziali degli studiosi. Maria Abreu Pinto è lettrice di portoghese dell’Istituto Camòes all’Università di Firenze, e Davide Conrieri (cito) “insegna alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si occupa di letteratura italiana e delle relazioni fra letteratura italiana e portoghese”. Il primo caso è meno preoccupante, perché i lettori non hanno responsabilità di docenza stabile in Italia. Il secondo solleva invece maggiori perplessità, perché seppure con la limitata responsabilità del livello di ricercatore, pone seri interrogativi sullo stato della conoscenza della lingua italiana in una scuola che dovrebbe essere di grande prestigio. Possibile che questo giovane (credo) italianista di una scuola prestigiosa non abbia avuto un maestro che gli abbia insegnato l’italiano? O, dubbio ancor più inquietante, non gli avranno mica detto che va bene così? Che poi egli si occupi non solo di letteratura italiana (e qui c’è da augurare ai suoi studenti che Dio gliela mandi buona) ma anche “delle relazioni fra la letteratura italiana e portoghese”, risulta ancora più allarmante. Al di là della diligente introduzione, utile e uggiosa come una tesi di laurea compilativa, per un così delicato lavoro comparatistico bisogna sapersi muovere come un pesce in entrambe le acque culturali, e ciò richiede un serio e lungo tirocinio filologico, linguistico e letterario, e non qualche bracciata annaspante tanto per tenersi a galla. Non vorrei chiudere concludendo che ai miei tempi, in quella scuola, gli studi di italianistica erano ben altra cosa: rischierei di essere considerato un vecchio nostalgico dalla mentalità “cautelosa”. Purtroppo, più che a cautela i tempi inducono allo sconforto, e questa disinvolta operazione che in un batter d’occhio rende simultaneamente un cattivo servizio alla lingua italiana e al maggior scrittore portoghese dell’Ottocento ne è, fra le tante, una malinconica conferma.